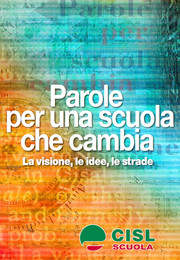
In questa pagina:
Pensieri a voce alta: Una staffetta corsa bene (Maddalena Gissi)
La parola di questo mese: Glocal (Orazio Parisotto)
Identità CISL: Carniti e Marini per la pace (Francesco Lauria)
La scuola è viva. W la scuola: Una scuola comunitaria e trasformativa (Roberto Mancini)
Testimoni del nostro tempo: L’eredità culturale di Don Tonino (Luigi Lo Papa)
Hombre vertical: La cosa più folle di tutte (Emidio Pichelan)
Storia contemporanea: Parlamentarismo e antiparlamentarismo (Paolo Acanfora)
Un autore: Manzoni? C’est moi (Leonarda Tola)
Autobiografie scolastiche: Amos Oz (Mario Bertin)
Zibaldone minimo: Tradimento (Gianni Gasparini)
Scrivici, se vuoi, a redazione@cislscuola.it
PENSIERI A VOCE ALTA
Una staffetta corsa bene
di Maddalena Gissi

Al nostro congresso nazionale, in programma a Riccione dal 16 al 18 di questo mese, si chiuderà per me la bellissima esperienza che ho avuto il privilegio di vivere, guidando per più di sei anni la CISL Scuola. Un passaggio da tempo annunciato, dettato dalle regole del nostro Statuto e che l’organizzazione ha preparato in questi mesi con grande cura, coinvolta nella gestione di un avvicendamento che potrà dunque avvenire nel migliore dei modi. Un cambiamento nella continuità, dove quest’ultima non è affatto da intendersi come condizionamento, limite o freno rispetto alla carica di novità cui un passaggio di testimone all’insegna della serenità e dell’entusiasmo potrà imprimere ancora più slancio, se mai ce ne fosse bisogno. Come avviene, e come ci ricordano eventi sportivi di cui abbiamo fresca memoria, in una staffetta corsa bene e risultata vincente anche per l’ottima gestione dei cambi.
Non intendo anticipare qui decisioni che spettano al Congresso, e al Consiglio Generale che si riunirà immediatamente dopo la sua conclusione: non sarebbe né giusto né opportuno. Approfitto invece volentieri dell’occasione che mi è data, con questi ultimi miei “pensieri a voce alta”, per un commiato, carico di affetto e gratitudine, da quanti hanno avuto per tanto tempo la pazienza e la voglia di leggerli e che li vedranno affidati, dal prossimo mese, ad altra voce e ad altra firma. È stato per me, in questi anni, un appuntamento impegnativo da onorare, ma utile e prezioso perché mi ha sollecitata a fare il punto a cadenza regolare sulle tante problematiche con cui il sindacato è chiamato ogni giorno a misurarsi e, con una riflessione condotta anzitutto su me stessa, sull’efficacia del nostro “stare in campo” rispetto ai problemi e alle attese di chi ci affida la sua rappresentanza. Un periodico esame di coscienza particolarmente utile negli ultimi due anni, segnati da eventi eccezionali la cui straordinarietà è senz’altro destinata a rimanere nella storia.
Ritrovo, rileggendo ciò che ho scritto ogni mese, una sorta di diario al quale ho affidato di volta in volta le mie considerazioni, tentando di fare sintesi di uno scambio quotidiano, continuo e costante, cercato e voluto nel dialogo con le altre persone chiamate a condividere l’onore e gli oneri derivanti dall’essere, insieme, alla guida della più grande organizzazione sindacale di un settore così importante per la vita della comunità. Devo a loro l’aver potuto far conto, in questi anni, su una grande e bella squadra: era la speranza che nutrivo e l’invito che rivolgevo a tutti, nel dicembre del 2015, quando nell’accingermi ad assumere, con qualche trepidazione, un incarico così prestigioso evocavo l’immagine, mutuata anche allora da uno sport di gruppo, di atleti che insieme si trasmettono l’un l’altro energia, determinazione, coraggio. Chi mi conosce, sa bene che quello è lo “stile di comando” al quale mi sono sempre attenuta, in tutti i ruoli ricoperti nella mia ormai lunga esperienza di vita sindacale, perché lo sento mio: una modalità per la quale coinvolgimento e partecipazione sono pilastri fondamentali. Il motto che accompagna il logo della CISL Scuola, “In prima persona al plurale”, ne esprime con massima efficacia il senso e il significato.
Tutto il nostro percorso congressuale, da settembre a oggi, pur dovendo fare i conti con i vincoli imposti dall’emergenza pandemica, si è nutrito di partecipazione. Ed è ancora la partecipazione il carburante che muove il nostro motore nell’altro concomitante appuntamento, il rinnovo delle RSU, per il quale tutta la CISL Scuola è oggi fortemente impegnata, un impegno davvero “totale” perché si tratta di una partita giocata scuola per scuola sull’intero territorio nazionale. La grande fatica di una nobile impresa: la definisco così perché condivisa da decine di migliaia di lavoratrici e lavoratori. Un esempio concreto di democrazia praticata, di grande responsabilità civile, di senso della comunità. La segnalo come spunto di riflessione per chi avesse dei dubbi sul ruolo che il mondo del lavoro e le sue organizzazioni possono svolgere per la coesione e il buon governo della società e del Paese.
Sono convinta che il sindacato, e in particolare il nostro, possa dare un contributo rilevante al grande sforzo che l’Italia sta sostenendo per un’uscita dall’emergenza pandemica che sia anche occasione di una ripresa della crescita nel segno dell’innovazione. Di quali cambiamenti ci sia bisogno, non di facciata ma profondi e in qualche caso radicali, ce ne ha resi più consapevoli proprio la pandemia, tanto che oggi è molto ben delineato il panorama delle sfide che ci attendono, a partire da quella ambientale che investe l’intera umanità e le sue stesse prospettive di sopravvivenza. Tra queste sfide c’è quella di un’emergenza educativa da affrontare con politiche di più forte e consistente investimento sul sistema di istruzione e formazione, la cui centralità non può essere affermata solo a parole. Le professionalità che operano al suo interno rappresentano la principale risorsa su cui agire per sostenere l’efficacia e la qualità del sistema, ma sono invece da troppo tempo trascurate e non riconosciute come si dovrebbe. Per modificare questo stato di cose, non basta gridare ogni tanto la propria rabbia o dare sfogo al disagio che si avverte, occorre costruire condivisione e una più diffusa consapevolezza sulla bontà delle nostre ragioni, perché si trasformino in obiettivi sostenuti da un ampio consenso sociale e politico. Sono questi in sostanza i motivi che ci hanno condotto, negli ultimi tempi, a seguire strade diverse da quelle di altre sigle, più inclini a percorrere quella di un antagonismo sul quale, a conti fatti, hanno trovato ben poco seguito.
A chi prenderà il mio posto alla guida della CISL Scuola toccherà portare a compimento l’intento delineato nel motto del nostro congresso, “disegnare oggi la scuola di domani”, sapendo che quel disegno dovrà contenere almeno l’avvio di una rivalutazione significativa di tutte le componenti professionali operanti nel sistema di istruzione e formazione. Il rinnovo del contratto sarà per questo a breve un impegnativo banco di prova. Sarà senz’altro una partita difficile e complessa quella che si giocherà al tavolo del negoziato: la CISL Scuola ha tutta l’intelligenza, l’energia e la determinazione necessarie per esserne ancora una volta protagonista vincente.
Doveroso post scriptum
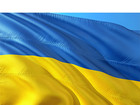
L'invasione dell'Ucraina da parte delle forze armate della Russia riporta l'Europa a scenari di guerra che speravamo di non dover rivivere a settantasette anni dalla fine del secondo conflitto mondiale. Sono giorni di angoscia quelli che il mondo sta vivendo, nella consapevolezza dei rischi gravissimi che comporta un atto la cui portata destabilizzante può alterare pericolosamente gli equilibri su scala planetaria, al di là dell'immediato impatto che il conflitto produce sulle popolazioni coinvolte e sull'economia dei paesi europei. Il mondo del lavoro, attraverso i maggiori sindacati, è sceso immediatamente in piazza per protestare contro le azioni militari, a sostegno di un immediato cessate il fuoco perché si affidi alla diplomazia, e non alle armi, la ricerca di soluzioni che garantiscano la pace e l'indipendenza dei popoli.
La CISL Scuola assume e condivide totalmente l'iniziativa della CISL, delle altre organizzazioni del lavoro e del vasto fronte di associazioni che sabato 26 aprile si sono radunate a Roma, in piazza Santi Apostoli, per dire no alla guerra e sì alla pace.
Speravo che il passaggio di testimone avvenisse in un clima dominato dalla speranza di una possibile uscita dall'emergenza pandemica, purtroppo se ne sovrappone un'altra, e altrettanto drammatica. Ma è proprio in momenti come questi che la presenza, l'impegno, la passione civile di donne e uomini di buona volontà diventano risorse decisive. Non ho dubbi sul fatto che la CISL Scuola sarà anche su questo all'altezza dei tempi e del compito.
m.g.
LA PAROLA DI QUESTO MESE
Glocal
di Orazio Parisotto

In uno scenario dove le scelte cruciali economiche e socio politiche, data l’interdipendenza globale di fatto esistente, vengono decretate a livello planetario e non più solo nazionale o regionale, i nostri destini e quelli delle nostre democrazie sono legati alla capacità interna di rispetto dei diritti fondamentali, ma anche all’influsso esercitato dagli altri paesi, dagli eventi internazionali, dagli organismi pubblici e/o privati a valenza internazionale e, soprattutto, dai gruppi di potere transnazionali. Dopo Hiroshima e Chernobyl, dopo le guerre in Iraq, Afghanistan e in Siria, con le grandi migrazioni, i tragici fatti legati al terrorismo internazionale, a fronte delle emergenze dell’ecosistema e della grande crisi finanziaria e ora di quella pandemica in atto, tutti hanno capito, ancor più chiaramente, quanto il genere umano sia ormai legato a comuni destini. Ciò che accade in un Paese, quindi a livello locale, si ripercuote a livello globale.
Il pianeta è diviso in circa 200 Stati nazionali sovrani e armati; Stati spesso in contrasto tra di loro, abituati a operare nel proprio interesse (se non soltanto in quello delle lobby dominanti), anche qualora questo sia contrario all’interesse generale dell’umanità. Serve, quindi, un impegno comune per superare questa situazione che si sta manifestando all’interno di un processo di globalizzazione senza regole e mentre l’umanità tutta, di fronte al caos socio-politico istituzionale, economico-finanziario, militare e sanitario, sembra procedere in modo rassegnato nel succedersi degli eventi, incapace di influenzarli e gestirli nell’interesse dei popoli, ovvero dell’uomo cittadino del mondo e, in particolare, nell’interesse dei giovani.
La maggioranza dei cittadini si è finora interessata quasi esclusivamente dei problemi personali e della propria famiglia in un futuro a breve e medio termine. Una parte si è interessata anche dei problemi della propria città, regione o nazione. Solo pochi possiedono una visione globale dei problemi continentali o mondiali, e questo è, al giorno d’oggi, indispensabile. La partecipazione con i moderni mezzi di comunicazione e attraverso i rappresentanti di associazioni, enti e istituzioni può e deve avvenire a tutti i livelli del vivere sociale e deve essere percepita da ciascuno come dovere fondamentale utile per salvaguardare gli interessi dei singoli e dei popoli dalle tentazioni egoistiche sempre emergenti di gruppi di potere e di élite predatorie prive di responsabilità sociale.
Emerge allora chiara la necessità che ciascuno di noi percorra la strada dell’impegno iniziando dal miglioramento individuale ma impegnandosi anche in una consapevole e corretta partecipazione sociale, facendosi parte attiva nella gestione della cosa pubblica, non solo locale e nazionale, ma anche internazionale. Deve essere, quindi, un cittadino che sappia comprendere e appoggiare anche la possibilità di risolvere il problema diventato urgente della creazione di istituzioni sovranazionali democratiche; istituzioni attraverso le quali poter affrontare le grandi emergenze planetarie che nessuno Stato può affrontare da solo. È chiaro che non si può più aspettare, perché, oltre a quella climatico-ambientale, sono molte le emergenze che si intrecciano tra loro e rappresentano altrettante sfide per la sopravvivenza e la dignità del genere umano. Ne cito solo alcune: il bisogno di sicurezza, di disarmo atomico e globale, la vergognosa costosissima corsa agli armamenti e il dramma dei migranti, lo strapotere dei colossi transnazionali economico finanziari, la progressiva perdita della libertà, l’inquinamento e le ricadute sanitarie, la tragedia delle nuove forme di schiavitù, il dramma della droga …
Albert Einstein ci dice: “La modernità ha fallito. Bisogna costruire un nuovo umanesimo altrimenti il pianeta non si salva". Ma ci dice anche che: “Non possiamo risolvere i problemi con lo stesso livello di pensiero che li ha creati” Quindi ricorda: “Se l'umanità deve sopravvivere, avremo bisogno di un vero e proprio nuovo modo di pensare”.
L’insieme delle emergenze, la caotica situazione geopolitica, gli effetti di una globalizzazione dell’egoismo e dell’indifferenza, ci obbliga a reagire, a cambiare alla radice i vecchi paradigmi, molti dei rapporti socio culturali ed economici finora ritenuti basilari e i tanti comportamenti e atteggiamenti mentali dati, da sempre, per scontati, il che significa avviare una vera e propria rivoluzione pacifica che però può realizzarsi solo attraverso una partecipazione attiva e consapevole dei cittadini.
Ma la partecipazione attiva e consapevole presuppone una preparazione culturale e operativa sviluppata in forma nuova, adeguata a cambiare i vecchi paradigmi, deve, cioè, essere GLOCAL.
Sì, finalmente siamo arrivati al termine GLOCAL. Nell’Enciclopedia Treccani si legge: “glocal agg., ingl. [comp. di glo(bal) «globale» e (lo)cal «locale»] – Di atteggiamento, politica, visione, che si concentra contemporaneamente sulla dimensione globale o planetaria e su quella locale”.
È necessario il massimo impegno nell’educazione dei giovani alla democrazia partecipativa e ai diritti e doveri fondamentali non solo nell’ambito dell’Educazione civica sviluppando con metodo percorsi didattici trasversali a tutte le discipline in una visione glocal.
Il nostro Ministero dell’Istruzione ci stimola in modo appropriato, rendendo obbligatorio l’insegnamento dell’Educazione civica e indicando tre assi attorno a cui deve ruotare: “Lo studio della Costituzione, lo sviluppo sostenibile, la cittadinanza digitale, tenendo conto degli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’ONU”. Ci invita a passare dal locale, dal nazionale all’internazionale, anche attraverso lo studio dell’Unione Europea e dell’Organizzazione delle Nazioni Unite. Ci invita quindi a sviluppare l’insegnamento in modalità glocal, ad agire cioè con visione globale e azione locale e viceversa, il che, se ben applicato, rappresenta un nuovo modo di pensare.
Nel numero di maggio-agosto 2021 di “Scuola e Formazione” pagg. 53-55 è stato pubblicato un articolo su un progetto pilota di Educazione civica “Educazione Civica Nuovo Umanesimo”, che sta avendo un sorprendente successo partecipativo soprattutto da parte degli studenti. Articolo che invito caldamente a leggere anche perché il successo viene proprio dal fatto che tutto il progetto si caratterizza e sviluppa in una visione glocal cercando di intercettare e rispondere assieme ai giovani alle problematiche più urgenti che assillano la nostra società, indicando quali sono i diritti/doveri ai quali far riferimento per poterle affrontare e possibilmente risolvere. Insomma, si è cercato di favorire l’acquisizione di un atteggiamento glocal utilizzabile in tutti i settori del vivere sociale. Esemplare è il Curricolo trasversale di Educazione civica dell’Istituto, in cui il progetto è inserito.
Localmente ci si può impegnare personalmente e direttamente nelle associazioni di volontariato, ad esempio, per l’assistenza ai migranti. Ma cosa significa possedere una visione glocal in questo ambito e come fare per incidere anche a livello internazionale? La visione globale ci ricorda che nel pianeta ci sono circa 250 milioni di migranti, in forte aumento anche per effetto della pandemia “Covid-19”; migranti, spesso disperati, che si mettono in movimento nella speranza di sopravvivere e di far sopravvivere i loro figli. E allora, di fronte a tutto questo, che si può fare? Ci si sente impotenti, rassegnati, a meno che non ci si sappia muovere anche nel contesto internazionale, per conoscere le varie emergenze planetarie, le associazioni, le istituzioni che operano nei vari settori e per capire che è possibile, anzi necessario, attivarsi con loro per far sì che siano affrontate, insieme, quelle emergenze che nessuno può risolvere da solo.
Si possono acquisire le nozioni utili presso le agenzie culturali e soprattutto nella scuola, ad esempio, attraverso un curricolo trasversale di Educazione civica di istituto e, se, nell’ambito della sua applicazione, si realizzerà una vera collaborazione tra docenti, gli insegnamenti delle diverse discipline si potranno intrecciare tra loro, donando agli studenti un’importante esperienza educativa interdisciplinare e coordinata che, nel suo insieme, stimolerà fortemente l’acquisizione di una mentalità e operatività glocal, presupposto per la nascita e l’avvio di un Nuovo Umanesimo di civile convivenza e di Pace.
L’avvio di un Nuovo Umanesimo e la necessità di una Pace sicura e duratura hanno bisogno, oltre che della crescita culturale individuale glocal, di un adeguamento delle istituzioni a tutti i livelli e, in particolare, a livello internazionale. Multilateralismo e conferenze intergovernative possono aprire la strada per arrivare almeno ad un “regolamento mondiale di civile convivenza” che eviti i continui ricorsi al confronto-scontro e alle guerre e che prepari, attraverso i necessari passaggi, nel tempo e con l’impegno delle nuove generazioni, la riforma dell’ONU. Può sembrare un sogno ma é una necessità, se vogliamo difendere libertà, giustizia e democrazia. Deve essere una meta, una speranza per i nostri giovani che hanno un assoluto bisogno non di illusioni, ma di credere e di impegnarsi per la costruzione di un mondo migliore.
Ma dobbiamo partecipare e interessarci del globale, delle emergenze planetarie e delle altre gravi emergenze tanto quanto dei nostri interessi personali, familiari e dei problemi locali. E, quali “cittadini glocal”, dobbiamo essere non più responsabili solo di noi stessi, ma di tutta l’umanità e del pianeta che ci ospita. Questo, se realmente applicato, rappresenta un nuovo modo di pensare e di agire che può portare ad un fondamentale cambio di paradigma, cioè: “riconoscere che il cittadino (la sua salute-libertà-indipendenza e dignità) viene prima di ogni interesse economico, prima dello Stato e che il pianeta Terra viene prima sia del cittadino che dello Stato, il tutto nel rispetto dei principi ai quali si rifanno i diritti fondamentali".
Orazio Parisotto è studioso di Scienze Umane e dei Diritti Fondamentali, Fondatore e Presidente di Unipax, NGO associata al DGC delle Nazioni Unite
IDENTITÀ CISL
Carniti, Marini e il tizzone ardente del “trionfo di un ideale di Pace”.
di Francesco Lauria

- Pierre Carniti e Franco Marini al Congresso CISL del 1985
Pierre Carniti (1936-2018) e Franco Marini (1933-2021) sono stati due grandi, grandissimi pilastri della storia della Cisl e del nostro paese.
Ricordare questi due segretari generali della nostra organizzazione, scomparsi dopo l’ultimo congresso confederale, proprio mentre, dai più inaspettato, il fuoco devastante della guerra torna a divampare in Europa, può sembrare un esercizio fuori dal tempo, sconnesso dalla tragedia bruciante, rappresentata dal conflitto seguito all’invasione russa dell’Ucraina.
Eppure non è difficile scorgere, in forme diverse, il loro impegno concreto per quello che nel proprio Statuto, all’articolo da due, la Cisl, da sempre, definisce il: “trionfo di un ideale di Pace”.
Scriveva Franco Marini su “Il Foglio”, nell’agosto del 2014, in occasione dell’anniversario dello scoppio della Prima Guerra Mondiale, di cui era il Presidente del Comitato storico-scientifico per la rievocazione:
“(…) Proprio l’Europa, a cavallo tra luglio e agosto del 1914 si incammina verso il suicidio. Il poeta francese Paul Valery si esprimerà così dopo il conflitto: “Constatiamo ora che l’abisso della storia è grande abbastanza per tutti. Sentiamo che una civiltà è fragile come una vita. Ruggini territoriali mai sopite, pulsioni nazionaliste, competizione commerciale, lotta per l’accaparramento delle aree coloniali da sfruttare per le materie prime e, sul piano interno ai singoli Paesi, movimenti indipendentisti, agitazioni sociali, preoccupazioni per il cammino della democrazia, tensioni ricorrenti nell’economia e nella finanza forniscono legna per l’incendio che, prima o poi sarebbe stato acceso.
L’industria militare bruciava acciaio e sfornava armi di stermino sempre più potenti. Suonano dunque come previsione più che profezia le parole pronunciate nel 1895 (!) dall’uomo che qualche anno dopo avrebbe ricevuto il premio Nobel per la pace, il francese Frederic Passy: “un incidente imprevisto, un caso ineluttabile, perché le scintille cadano un attimo su quei mucchi di materiale infiammabile che si tanno follemente ammassando (…) e facciano saltare in aria, fino al cielo, tutta l’Europa”. E l’Europa saltò. (…)"
Continuava l’ex segretario generale della Cisl: “Ha osservato lo storico americano Lawrence Sondhaus in un’intervista: “il retaggio forse più impressionante della prima guerra mondiale è il contributo all’assuefazione di milioni di persone alla brutalità, alla disumanità, agli immani massacri della guerra dell’età industriale. (…) Dopo l’agosto del ’14 l’Europa dovrà attendere trentuno anni perché sul suo suolo torni a soffiare la pace. E alcuni grandi uomini, tra cui De Gasperi, Adenauer, Schuman, perché l’Europa cominci a pensarsi come una cosa comune è il sogno dell’integrazione del continente perché “mai più” ci sia un europea che leva il fucile contro un altro europeo e si apra una stagione di prosperità e progresso che solo la pace può permettere”.
Sono parole da rileggere dolorosamente nel presente, senza rassegnazione, proprio mentre scendiamo in piazza per la Pace e ci rendiamo conto che fare ciò sia, allo stesso tempo, una risposta necessaria, quanto insufficiente.
Osserviamo gran parte dell’opinione pubblica europea rischiare ancora, pur in forme profondamente diverse di quanto ricordato da Marini, l’assuefazione alla “banalità del male”, a quella che Papa Francesco, da anni, giustamente definisce la: “terza guerra mondiale a pezzi”.
Non possiamo fermarci solo a considerare l’aumento della bolletta del gas o, in Italia, del possibile mancato rinnovo del bonus energetico!
L’impegno per pace e giustizia sociale, ce lo insegnano i nostri padri fondatori, non può mai scindersi.
Il 7 ottobre 1981, l’allora segretario generale Pierre Carniti apriva a Roma, con una relazione di trentuno (31!) pagine, il nono congresso nazionale confederale della Cisl.
Quasi all’inizio di questo lungo intervento, di fronte al dibattito sul dispiegamento dei c.d. “euromissili” nel nostro continente e nel nostro paese, Carniti affermava:
“La guerra nucleare diventa possibile a dimensioni ridotte, non planetarie. E con prevedibile fronteggiarsi di truppe avversarie sul terreno europeo. E’ per questo che chiediamo che l’Italia manifesti concretamente il più alto interesse e il più fermi impegno per una Conferenza Europea sul disarmo e faccia nel contempo sentire la sua voce per far approdare a risultati positivi il negoziato sul disarmo.
Il mondo ha bisogno di pace per affrontare i grandi problemi dell’umanità.
Come ha detto Brandt, un mondo più armato non è più sicuro, è soltanto un mondo più povero. Nuove spese militari costituiscono uno sperpero insopportabile per l’economia mondiale. Ma la pace non è separabile dal diritto dei popoli, di tutti i popoli, all’indipendenza, alla sovranità, alla scelta autonoma della propria via di sviluppo”.
Solo quattro anni prima, nel gennaio del 1977, in occasione dell’assunzione della carica di segretario generale aggiunto della confederazione di Via Po, Carniti aveva pronunciato, di fronte al consiglio generale dell’organizzazione un intervento intitolato: “Il mestiere del sindacato nuovo”.
Ammoniva il futuro segretario generale della Cisl:
"Noi non siamo chiamati a fare la guardia alle istituzioni, a preservare un ordine semplicemente rassicurante, nel quale il progresso economico può essere disgiunto dal progresso sociale, può lasciare alle sue spalle profondi squilibri e diseguaglianze, perpetuando gravi ingiustizie.
Siamo invece chiamati a raccogliere, con consapevolezza democratica, tutte le tensioni, i problemi della povera gente, degli emarginati, dei disoccupati, delle donne e dei giovani, ad esprimere piena dedizione, in sostanza, alla causa della liberazione dell'uomo, e della sua presenza in una società che sia costruita a sua misura.
(...) Se si perde il senso dell'ideale ci si immiserisce nella pratica quotidiana. Se si perde il senso di responsabilità ci si adegua al modo d'essere di un sindacato che si rinchiude in una logica difensiva, che può vagheggiare l'avvenire, ma non è chiamato a gestire il presente. Ci sono le condizioni e le potenzialità perché non sia disertata nessuna di queste esigenze, perché non ci si sottragga a nessuna di queste responsabilità".
A quasi quattro anni dalla scomparsa di Carniti e a poco più di un anno dalla scomparsa di Marini, non dobbiamo stancarci di ricordare il profilo storico di due grandi protagonisti della Cisl e dell’Italia della seconda parte del Novecento.
Anche oggi, in un tempo in cui non possiamo non guardare fuori da noi, a quello che accade nel mondo dell’economia dell’interdipendenza, ai confini della nostra Europa, ideale di pace.
Dobbiamo pensare a queste figure non nell’ottica tradizionale di un tempo cronologico, per quanto esteso, ma di un kairòs, un “tempo opportuno”.
Come ci insegna, da sempre, Bruno Manghi, il sindacato, la Cisl è un grande scommessa collettiva, radicata ai luoghi di lavoro e ai territori, ma è anche, inesorabilmente e soprattutto, un: “fatto nel mondo”.
Paolo Giuntella in un suo testo, “Il fiore rosso” ci ricordava che nel Libro della giungla di Kipling, il cucciolo d'uomo Mowgli riesce a vincere l'arrogante tigre Shere Khan con il fiore rosso, il fuoco, un tizzone ardente. Il fuoco non brucia Shere Khan, lo allontana per sempre.
Prendendo lo spunto da questo episodio, e soprattutto da questa simbologia, Giuntella ci mostrava il passaggio, di generazione in generazione, del tizzone ardente, del fuoco della fede, del fuoco interiore, fino a un oggi infinito.
Come scriveva Giuntella: “non è, dunque, la potenza delle pietre dei templi o la forza delle istituzioni ad assicurarci l'avvenire, ma il passaggio da persona a persona di questo tizzone ardente, del fiore rosso della testimonianza”.
Portiamo con noi nelle piazze questi due grandi uomini del Novecento (Marini era nato a San Pio delle Camere in Abruzzo il 9 aprile 1933, Carniti a Castelleone, in provincia di Cremona il 25 settembre 1936) che si sono conosciuti, nel 1956, proprio nel cuore della comunità educante della Cisl: il Centro Studi di Firenze.
Torniamo anche alle origini valoriali di una straordinaria e più che centenaria esperienza collettiva. Riscopriamo, senza contraddizione con il dramma globale della guerra divampante in Europa dopo la pandemia, il desiderio di fare ed essere sindacato. La felicità, in senso antropologico, quell’habitus che Bordieu definisce “desiderio di essere”.
Ripensare a Carniti e Marini, oggi, dopo che il soffio della loro fragilità ci ha terrenamente lasciato, senza trasformarli in comode icone, ci permette, infatti, pur nelle difficoltà di questo tempo frantumato, di sentirci dentro un tempo opportuno e condiviso per la Speranza per la Pace e non della rassegnazione e del rancore.
C’è, infatti, sempre un Kairòs, un tempo opportuno per “sognare da svegli”, come ricordava spesso Carniti, citando Aristotele.
Scriveva Chesterton: “Noi possiamo prendere le nostre lacrime più alla leggera della tremenda levità degli angeli. Così forse sediamo in una camera stellata di silenzio, mentre la risata dei cieli risuona troppo forte perché possiamo udirla”.
Così, anche di fronte a questa immonda guerra: “la morte non avrà l’ultima parola” e, mi concedo una citazione sindacale antica, da calabroni, sarà possibile e desiderabile “paradossalmente volare” e “remare controcorrente”.
LA SCUOLA È VIVA. W LA SCUOLA
Una scuola comunitaria e trasformativa
di Roberto Mancini

1. Vedere le nuove generazioni
Le nuove generazioni non sono viste dalle istituzioni e dalla mentalità degli adulti. “Viste” significa ascoltate, sentite, accolte, accompagnate, nutrite eticamente e civilmente, ispirate ad assumere la vita come un dono che richiede la loro libertà, creatività, felicità. Il punto cruciale sta nell’alternativa seguente, che formulo in forma di domanda: ragioniamo secondo la logica del potere e dei suoi ricatti, avendo il cuore congelato dalla chiusura alla corrente relazionale della vita, oppure seguiamo il pensiero della giustizia secondo la dignità delle persone e abbiamo nel cuore la gratitudine per la presenza delle nuove generazioni?
Nella scelta di tornare a vedere i giovani bisogna anche chiedersi quale sia il senso della scuola. Spesso si dimentica che, anziché ridursi a una qualunque organizzazione, la scuola è un organismo vivente e comunitario, che respira e si esprime con grande ricchezza di umanità, mentre è impegnato a nutrire la vita relazionale, cognitiva ed etica di chi ne partecipa. Alunne ed alunni, personale docente e non docente, dirigenti e famiglie non sono parti di un’organizzazione che deve funzionare come una macchina, ma sono soggetti partecipi di una comunità aperta fatta di persone.
Il senso della scuola sta nell’educare le persone che a essa sono affidate, poi anche nel renderle così forti, creative, libere e responsabili da saper portare il loro apporto per trasformare in meglio la società. Per contro, ridurre le persone a oggetti, piegando l’educazione a essere un mero addestramento in vista delle esigenze del mercato, significa tradire i nostri figli e le nostre figlie, distruggere il senso della scuola, negare il diritto delle nuove generazioni all’educazione e alla libertà, sottraendo alla società la principale forza antropologica e generazionale del suo indispensabile rinnovamento.
Da questo punto di vista suona amaramente come un’eco di tempi migliori, in fondo più umani e però molto lontani da noi, la domanda retorica di Gesù: “chi è quel padre fra di voi che, se il figlio gli chiede un pane, gli darà una pietra? O, se gli chiede un pesce, gli darà un serpente? Oppure, se gli chiede un uovo, gli darà uno scorpione?” (Lc 11, 11-12). Intendeva dire che, per quanto malvagi, gli adulti sanno dare “buoni doni ai figli” (Lc 11, 13). Invece oggi spesso i padri e le madri obbedienti alla logica dei poteri dominanti nella società globalizzata danno pietre, serpenti e scorpioni ai giovani e mentre lo fanno li rimproverano persino di non essere all’altezza della sfida dei tempi.
Ormai da lungo tempo la situazione della scuola italiana risulta precaria, colpita dall’incuria e da una mentalità governativa – persistente a prescindere da quali siano i partiti in posizione di comando – che vede l’educazione, la conoscenza e la ricerca come un costo da tagliare. Colpisce in particolare la pretesa di produrre “riforme” che scaturiscono da mode futili, da zelo conformista per lo spirito del tempo, da pedagogie superficiali e copiate da qualche altro Paese, quindi prive di qualsiasi spessore critico, e soprattutto dalla sudditanza all’idea stolta per cui la società stessa sarebbe un unico immenso mercato e tutto dovrebbe adeguarsi di conseguenza. Così secondo tale opinione, una scuola moderna, avanzata e che sia “al passo con i tempi” sarebbe automaticamente una scuola del tutto funzionale rispetto al mercato e ai poteri che lo gestiscono.
Risalendo all’origine del malessere della scuola, del suo misconoscimento nella politica attuale e nella mentalità prevalente, si può dire che il vizio d’origine è l’ignoranza antropologica. Con tale espressione intendo due cose: anzitutto il misconoscimento e l’oblio della dignità umana, con tutta la cura che essa comporta, e poi quella mancanza di consapevolezza che deriva non soltanto dalla carenza di conoscenze, ma anche da quella mancata sapienza che consiste nel non aver mai scoperto un altro e migliore modo di vivere.
Il punto di svolta programmatico, etico e politico sta allora nella scelta di non pensare più la scuola secondo il mercato, preferendo invece pensarla secondo la dignità umana, il bene comune e il diritto all’educazione delle nuove generazioni. Soggetti singoli, collettivi e istituzionali potranno sperimentare questa trasformazione e guarigione dello sguardo sulla scuola se, come passaggio preliminare di recupero del senso della realtà, procedono a una lettura critica della situazione attuale della società. Infatti il bilancio sul tipo di scuola che abbiamo deve poter scaturire dalla consapevolezza relativa al tipo di società in cui ci troviamo.
2. Se la scuola è sottomessa alla stupidità del mercato
Quella odierna è una società dell’astrazione. “Astrazione” significa, intanto, estrazione e isolamento di un aspetto, di uno scopo, di una funzione, per cui tutto il resto viene piegato all’elemento privilegiato. Nel nostro caso l’astrazione regina consiste nel primato del denaro sulla vita, sull’umanità, sulla natura, su ogni valore antropologico, etico, metafisico, estetico, naturale. Una concezione del mondo e della realtà in cui esistono parole per dire e occhi per vedere soltanto due tipi di valore – il valore d’uso, cioè l’utilità di una cosa e il valore di scambio, cioè appunto il denaro – è letteralmente incapace di dire e di vedere qualsiasi valore vivente, come sono le persone, le creature della natura, le relazioni, la bellezza, il bene, la giustizia, la libertà, la verità, la vita stessa. Perciò il mercato è stupido: non capisce i valori veri, non ha alcun riguardo per loro. E chi si adegua contrae questa stupidità etica, affettiva e politica.
Oltre tutto, come è noto, il valore di scambio ha una prevalenza schiacciante sul valore d’uso, cosicché il capitale, ossia il denaro accumulato, diventa non solo il massimo valore, ma anche l’unico vero “soggetto” della società. Il denaro diventa così potente e decisivo da rappresentare non certo un mezzo in vista di altre finalità, ma neppure soltanto un fine. Diventa ancora più importante, perché è concepito come il padre di tutti i mezzi e di tutti i fini, la condizione effettiva della vita e di qualsiasi potere.
Inoltre, “astrazione” significa rovesciamento: ciò che è astratto diventa concreto e ciò che è concreto diventa astratto. Concreto è il capitale, che si muove nel mondo determinando politiche, destini, condizioni di vita o di morte; astratte sono le persone, la natura, le relazioni, la vita, le possibilità reali di avere un futuro.
Ma è soltanto nella luce della gratuità che possiamo fondare quella giustizia che non significa trattare ciascuno per come si merita, bensì in ragione della sua dignità incondizionata. Su questa intuizione si giustifica poi la democrazia, intesa non come il regime in cui vince la maggioranza, bensì come l’ordinamento della vita pubblica in cui il criterio della dignità umana e della dignità della natura è il criterio fondante.
Una scuola forte di questa consapevolezza antropologica universale è una scuola del bene comune, che educando le persone coltiva una correlativa etica del bene comune. Con la parola “etica”, tuttavia, non intendo semplicemente una serie di principi e di regole, ma intendo: il risveglio e il nutrimento delle coscienze; l’esperienza concreta del valore delle persone, delle relazioni e della natura; l’adesione alla vita come comunità dei viventi in spirito di solidarietà e di giustizia; la scoperta della responsabilità di ciascuno per la sorte degli altri.
In confronto ai criteri e all’orizzonte che ho appena abbozzato, si capisce quanto sia inadeguata e falsata una scuola geneticamente modificata sotto la pressione delle esigenze del mercato guidato dai poteri finanziari globali. Si comprende quindi che la scuola delle skills è sbagliata, come lo è la scuola dell’autonomia competitiva. È sbagliata la scuola dove il dirigente è un padrone che tratta i docenti come minorenni e pedine in suo potere, come lo è la scuola degli incentivi e dei crediti, che vuole “monetizzare” le motivazioni e le passioni. Ugualmente sbagliata è la scuola della valutazione quantitativa e oggettivante, per cui si vedono prestazioni astratte ma non si vedono le persone e le facoltà propriamente umane.
Un altro errore consiste nel ritenere che l’istituzione scolastica sia neutra sul piano etico, estranea alla formazione della coscienza morale. Questa scuola post-morale è la più sbagliata di tutte perché non c’è educazione, dunque non c’è scuola senza formazione delle coscienze, senza educazione etica. E non è inutile ricordare che non c’è luogo nel quale trovare le ragioni del vivere insieme e della democrazia autentica se non nell’etica come risveglio alla responsabilità solidale per la storia e per il bene comune indissolubile.
Se adesso ci chiediamo quali siano, nel loro profilo essenziale, le caratteristiche e le tendenze specifiche di una scuola educativa, mi pare che vengano in primo piano diversi profili correlati tra loro. Penso alla scuola in quanto comunità aperta, una scuola democratica, che pratica il cosmopolitismo dal basso nel dialogo delle diverse culture e storie di vita. Una scuola che si nutre delle esperienze di socialità e di ricerca avanzata nel territorio dove è presente e nel mondo. Penso anche a una scuola dell’esperienza e della ricerca, dove gli studenti e i docenti stessi possano inoltrarsi verso le frontiere avanzate dei saperi, coltivati come percorsi transdisciplinari di partecipazione alla realtà nei suoi molteplici gradi di profondità.
Ci sono ulteriori versanti dell’idea di una scuola educativa e del bene comune. Parlo del profilo di una scuola che forma persone-cittadini che siano capaci di esprimere la loro forza trasformativa della società. Non giovani pronti per il mercato, ma giovani pronti a mutare radicalmente il mercato stesso. Evidentemente ciò implica che si tratti di una scuola della coscienza, che diventa uno dei luoghi preferenziali di esperienza quotidiana dell’etica del bene comune. Infine, penso a una scuola dell’anima, dove – senza mai cadere nelle pratiche dell’indottrinamento – si percorra insieme la strada lungo la quale ogni persona può trovare il suo centro interiore e il suo orizzonte di senso, sviluppando la propria capacità di dedizione a un ideale in grado di illuminare l’esistenza. Una scuola simile sarebbe più capace di andare in profondità, ma nel contempo saprebbe davvero ospitare la ricchezza delle differenze delle quali è intessuta l’umanità grazie alla diversità dei generi, delle generazioni e delle culture. Ho accennato poco fa al cosmopolitismo dal basso. Questa formula indica quel percorso comunitario aperto e ospitale nel quale vale ogni persona e valgono le relazioni, senza che le differenze etniche, di cultura, di genere, di età o di condizione sociale siano mai usate per creare muri di separazione e discriminazioni. Anzi si impara ad affrontare insieme, solidalmente, i problemi quotidiani.
3. La svolta: una scuola comunitaria e trasformativa
Una svolta di questo tipo richiede il pieno recupero della forza educativa della scuola. Deve ispirarci la consapevolezza del fatto che educare, per un verso, è aiutare maieuticamente le persone a dare alla luce il loro sé autentico e le loro migliori facoltà. Ma per altro verso è anche far incontrare i più piccoli e i giovani con le più luminose forze educative della natura e della cultura. Non è che i piccoli abbiano già tutto dentro se stessi; occorre preparare il loro incontro con quelle presenze della natura e con quei tesori della cultura che hanno la capacità di nutrire la loro anima, la coscienza, la ragione, la sensibilità affettiva, l’armonia del corpo.
Occorre ricordare che educare è liberare. Liberare dall’ignoranza, dalla paura, dai ricatti, dalla menzogna, dalla sfiducia nel futuro e nella vita. Una scuola realmente educativa è un luogo vitale fondamentale per lo sviluppo della cultura della liberazione delle persone, in alternativa a quella logica della funzione per cui chiunque viene ridotto a strumento o “risorsa” al servizio dei sistemi impersonali e tendenzialmente automatici di organizzazione della società. Una scuola così è trasformativa perché liberando la creatività dei giovani li prepara a trasformare la società (mercato compreso) umanizzandola.
Ho ricordato il pericolo del mercato globale e assoluto a guida finanziaria, ma si potrebbero accostare a esso anche l’apparato tecnologico, la burocrazia, il sistema globale dei media e lo scacchiere mondiale della geopolitica. Si tratta di tutti sistemi che dovrebbero servire l’umanità e che invece sono divenuti dei sovrani che la tiranneggiano. Essi, per così dire, “funzionalizzano” a proprio vantaggio singoli, comunità e istituzioni inducendo, oltre a squilibri sociali e naturali, una mutazione antropologica. Infatti vengono “prodotti” individui che sono non tanto nativi digitali, ma nativi funzionali, abituati fin da piccoli a obbedire a logiche che li sovrastano e ne misconoscono la libertà. Di conseguenza emerge non la persona, ma l’individuo assoggettato, che di volta in volta si modula in varie figure: homo oeconomicus dato come risorsa, esubero o scarto; l’internauta; l’uomo amministrato; l’uomo-massa; il suddito, il profugo, il migrante, la vittima. La scuola fedele alla sua vocazione educativa non serve affatto a preparare i piccoli e i giovani a qualcuno di questi ruoli.
A fronte di una simile molteplicità di tendenze antieducative, occorre rendersi conto di quale sia la posizione esistenziale di una bambina o di un bambino, poi delle e dei giovani, che si trovano in questo contesto epocale. Ciò che i giovani si trovano a vivere inizia da bambine e da bambini. Essi sono gettati in una società tendenzialmente psicotica, che riduce le persone a funzioni e che diffonde il sentimento dell’angoscia come clima normale dell’essere al mondo. Questo rende le generazioni nuove confuse, intimidite, prive dell’orientamento a una meta per l’esistenza. Manca loro l’esperienza di un mondo comune, poiché, per tutti, l’omologazione non crea comunità e universalità vissuta, ma disgrega e isola.
In tali condizioni le generazioni nuove sperimentano il vuoto: vuoto di senso, di umanizzazione e di democratizzazione. Un vuoto che è come un gorgo, un vuoto che risucchia le energie migliori e produce un malessere talvolta tematizzato, spesso non riconosciuto. Pertanto si capisce chiaramente che educare significa liberare chi sta crescendo da questo vuoto magnetico disgregatore. E insegnare i più piccoli ad affrontare questo vuoto, la sofferenza e il negativo che incontrano.
Si può far nascere un’altra società e un altro ordine del mondo soltanto superando questo vuoto. Alla scuola spetta oggi tale compito storico nel suo specifico risvolto educativo: promuovere le dinamiche dell’umanizzazione delle persone, nonché i processi di democratizzazione delle relazioni e della società intera. Questo duplice impegno è irrinunciabile per l’istituzione scolastica, pena lo snaturamento completo della sua ragion d’essere e del suo senso fondamentale.
L’istituzione scolastica deve nel contempo ridiventare educativa e corale: la dinamica che la porta a essere liberante e cosmopolita è la stessa. La scuola non esercita la sua vocazione educativa se torna verso modelli del passato e comunque nazionalistici o etnocentrici, né diventa cosmopolita se fa uno sforzo di estensione ideale dei principi universalistici della tradizione europea, o se tenta una retorica dell’universalismo. Siccome l’educazione è liberazione e sviluppo maieutico dell’umanità in ciascuno, essa deve sperimentare quotidianamente il valore dell’universalità, dunque deve avere modalità didattiche adeguate a chiunque, a prescindere dalla sua identità particolare e dalle sue appartenenze.
Se ci poniamo in questa prospettiva, si comprende quanto sia rilevante e gravida di conseguenze la scelta delle forme di didattica più adeguate al senso della scuola. Tale scelta non è mai puramente tecnica, poiché riassume in sé l’orientamento pedagogico di fondo e lo svolge operativamente, giorno per giorno. Perciò in corrispondenza all’alternativa tra logica della funzione e cultura della liberazione esistono due serie opposte di criteri-modalità per impostare la didattica quotidiana a scuola, trasversalmente, in ogni disciplina e con respiro transdisciplinare. Ne traccio qui di seguito un quadro schematico.

Ognuna di queste voci meriterebbe un approfondimento specifico, ma in questa sede mi basta dare l’idea del profilo d’insieme dei due opposti modi di fare scuola. La valenza educativa e concretamente cosmopolita dell’istituzione scolastica si gioca anzitutto sulla scelta tra queste modalità della relazione e dell’attività didattica. Per le ragioni che ho esposto sinora, credo sia giusto e doveroso scegliere quelle tipiche della cultura della liberazione. In una sintesi molto stringata si può dire che tali modalità essenziali riguardano:
- le persone, facendo in modo che ognuno sia accolto, riconosciuto, partecipe della comunità e delle attività, sollecitato maieuticamente a divenire una persona libera e non un individuo assoggettato;
- le relazioni intersoggettive, facendo in modo che siano non secondo la competizione ma secondo la solidarietà, l’empatia, il dialogo e la cooperazione;
- le facoltà umane, facendo in modo che tutte le capacità essenziali siano sviluppate;
- le conoscenze, facendo in modo che siano non autoreferenziali, ma idonee a partecipare con la maggiore consapevolezza e creatività possibile alla vita del mondo;
- le competenze, promuovendo quelle più adatte alla realizzazione e all’espressione della persona, nonché a far emergere la forma di società più accogliente e giusta.
Oggi prendersi cura della scuola è un imperativo categorico. Rigenerarla come comunità educativa, liberatrice e trasformativa è un passaggio determinante per la rinascita della società intera. Il fatto che oggi i giovani siano manganellati nelle manifestazioni o possano morire negli stages dell’alternanza scuola-lavoro è il segno di quanto le scelte politiche che li riguardano debbano essere non semplicemente riformate, ma radicalmente mutate con coscienza etica, saggezza politica e sapienza esistenziale. Un compito da cui il sindacato deve lasciarsi rinnovare in profondità.
TESTIMONI DEL NOSTRO TEMPO
L’eredità culturale di Don Tonino
di Luigi Lo Papa

“Delle parole dette mi chiederà conto la Storia, ma del silenzio con cui ho mancato di difendere i deboli dovrò rendere conto a Dio”.
Una gioia infinita: don Tonino Bello può essere venerato da tutto il popolo che l’ha sempre ritenuto un santo. Siamo, infatti, ad un passo dalla sua beatificazione.
Nel lasciare la Segreteria Regionale dei lavoratori in pensione della Puglia, ho pensato di far acquistare, da Edizioni La Meridiana (BA), le opere di don Tonino con la speranza che fossero lette per attuare, nell’azione quotidiana, i sogni di don Tonino, che chi disdegna l’impegno civile e sociale, in senso dispregiativo, chiama utopie.
A quasi trent’anni dalla morte, il messaggio, la visione di don Tonino, prete scomodo del Salento, finestra aperta sull’Oriente e Vescovo di strada, che arriva alla diocesi di Molfetta con una Cinquecento scassata, con un anello di mamma Maria, una croce pettorale e il pastorale di legno di ulivo, resta di cruciale attualità in questo tempo della Chiesa di Papa Francesco e quando riappare il rischio di guerra in Europa.
Don Tonino, come amava farsi chiamare, è un profeta dei nostri tempi, capace di leggere oltre, di praticare, sulla scorta del Vaticano II, la rivoluzionaria Parola del Vangelo: amore e misericordia, incontro-dialogo con tutti, gioia di dover e saper accogliere chiunque, cammino faticoso verso la giustizia, che genera la pace e semina germi di speranza come forza di rinnovamento e sviluppo. Don Tonino è testimonianza vivente del precetto: «Vi riconosceranno se avrete amore gli uni per gli altri».
I suoi scritti
Don Tonino, nella babele, ci invita ad andare nel deserto, a fermarci, a pensare in silenzio – Lettera a Gesù – per redigere la mappa dei bisogni nuovi e trovare risposte adeguate alle situazioni che viviamo, segnati da un deficit di amore, di ascolto reciproco, di rispetto per il diverso, da disuguaglianze, povertà, discriminazioni, intolleranze, violenze e odio che la nostra cattiva coscienza nasconde per non scomodarci e cambiare.
Non ho avuto la fortuna di conoscere don Tonino.
L’ho conosciuto attraverso le mirabili pagine dei suoi scritti che volentieri regalo.
Non so se ho letto prima Pietre di scarto o Ti Voglio Bene.
È il periodo romano, passo la sera dalla stazione Termini e vedo sui cartoni dormire i barboni, i clochard. Sono i Bartolo maleodoranti, per don Tonino, reliquie e frammenti di santità, coronati di gloria e d’onore, i veri beati.
Un pugno nello stomaco per chi dorme nelle comodità di un albergo.
Resto colpito dalla profondità dei suoi scritti, ricchi d’immagini-simboli: la cetra, la bisaccia vuota, il bastone del pellegrino, il rotolo dell’alleanza, l’ala, la brocca, la stola e il grembiule.
Scritti densi di passione e di tenerezza per l’uomo – basilica maggiore – per le pietre di scarto: stranieri, migranti alla deriva,drop out, sfrattati, disoccupati, prostitute, drogati, tutti chiamati per nome, accolti in episcopio senza prenotazione, e destinati a divenire polvere di stelle.
Le pro-vocazioni
Scritti, pieni d’espressioni forti e di una costellazione di domande radicali, che suscitano perplessità quando non scandali e sfidano convenzioni, luoghi comuni, stereotipi, pregiudizi e ogni forma di potentato. Ricordiamo gli auguri scomodi inviati da don Tonino a Natale.
Diventano pro-vocazioni, cioè sollecitazioni a uscire fuori dalla quotidianità sonnolenta, dalla cultura dell’indifferenza, dai bastioni delle proprie sicurezze, dalle logiche di potere, d’accaparramento, di calcolo e adesione del cuore a servire, con umiltà, Dio e l’uomo, Senza Misura, Charitas sine modo. Scritti che sono monito per quelli che non hanno il coraggio di cambiare.
Nell’elenco finisce la sua stessa Chiesa, che fatica a consegnarsi al vento dello Spirito, troppo prudente, se non silenziosa nel condannare ingiustizie, connivenze, mafie, produzione e l’immondo commercio d’armi, cause, con la miseria, delle guerre, e veste poco il panno usato da Gesù: il grembiule, il panno del servizio.
Non sono risparmiati gli intellettuali, che dovrebbero essere le sentinelle delle città e avere il dovere di dire sempre la verità – parresia – e non farsi complici del potere, e i politici tronfi ai quali rimprovera di non essere operatori di pace, di manipolare la verità, di chiudersi a difesa dei loro privilegi, sordi al grido dei poveri che reclamano lavoro, giustizia, dignità.
Sconvolgente la teoria della povertà, imperniata su tre sostantivi: rinuncia, denuncia, annuncio, che fondano un progetto rivoluzionario di vita individuale e comunitaria che può dar luogo a cieli nuovi e terre nuove.
Scritti concreti, colmi di scommesse e proposte sul terreno dell’animazione culturale, dell’educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva e non violenta, delle politiche sociali, non riducibili ai pannolini dell’assistenzialismo, ma incarnate in servizi e prestazioni che danno dignità: case, scuole, comunità di accoglienza, centri di ascolto, strutture per i minori in difficoltà, servizi domiciliari per gli anziani, ospedali, che mancano perché uomini paurosi, arroganti operano la scelta sciagurata di sperperare denaro nel costruire poligoni di tiro, armi e fare la guerra, violenza gratuita, che esprime la sete di potere delle lobby dei forti nei confronti dei deboli.
Scritti che diventano, infine, preghiera e poesia di struggente bellezza: Milagro, piccolo prodigio di luce, Parole d’amore, Quella notte a Efeso, La carezza di Dio.
È difficile condensare in un articolo la multiforme opera ed attività di don Tonino, il prete folle, che definisce la parrocchia luogo pericoloso ove si fa memoria eversiva della Parola; il polemista inquieto che ripudia la militarizzazione del Sud e le subculture mafiose, che ostacolano e condizionano il modello di sviluppo, e prova a conciliare storia, geografia, teologia, cultura laica e cultura cattolica. Per alcune di queste scelte coraggiose e posizioni audaci è inviso a parte dello stesso clero e viene richiamato anche dalle gerarchie della Chiesa, la Chiesa che avrebbe voluto di parte: Chiesa di parte, Chiesa del grembiule.
L’Eredità di don Tonino
Cosa lascia in eredità l’avventura evangelica di don Tonino a noi operatori sociali della Cisl che ci richiamiamo alla Dottrina sociale della Chiesa?
La centralità dell’amore e della misericordia
L’uomo, immagine di Dio, non è una cifra, un codice fiscale ma un volto. L’etica del volto. Nel terzo millennio allacceremo rapporti umani basati sulla contemplazione dei volti.
La concezione della politica
Mistica Arte, arte nobile e difficile di costruire il futuro. La politica rientra nella categoria del servizio, che, per non trasformarsi in potere, richiede una forte carica di spiritualità. «Ricordatevi – diceva – che una delle forme più esigenti, più crocifisse, più organiche dell’esercizio della carità è la politica». È un delitto lasciare la politica nelle mani degli avventurieri, giannizzeri e portaborse. Per i politici scrive, tra gli altri, Vegliare nella notte e scomoda la parabola del buon samaritano.
La sconvolgente estensione della carità
L’altro, il marocchino Mohamed, il profugo albanese non sono una minaccia, dei nemici, sono un dono. Cristo, parlando, nel suo tempo, con una donna, per di più samaritana peccatrice, al Pozzo di Sichar, ci pro-voca sull’alterità. Dare un letto non basta se non si sa dare la buona notte. «Ho letto da qualche parte che gli uomini hanno un’ala: possono volare soltanto rimanendo abbracciati». E invoca: «Dammi, Signore, un’ala di riserva».
Da prima pagina lo scontro aperto non solo con i politici sulla condizione disumana degli Albanesi, sbarcati e ammassati, agosto 1991, nello stadio della Vittoria a Bari.
Quel suo “duro parlar chiaro” gli costa la derisione del ministro degli Interni Vincenzo Scotti: «A peste, a fame et Bello libera nos, Domine».
L’impegno impagabile del volontariato
Lo splendido testo, È il Tempo, ripensare il volontariato, è un contributo prezioso alle Associazioni di volontariato, alla nostra Anteas.
Il volontariato meridionale deve fare una chiara scelta di campo. Deve essere padre di cultura più che produttore di servizi, coltivando l’ansia di solidarietà presente tra la gente del Sud per costruire una civiltà multietnica, multireligiosa, interculturale. Non possiamo più essere uomini di una sola cultura. Il dialogo tra religioni e culture è l’unico antidoto al razzismo, all’antisemitismo, alla cultura dell’odio.
Il percorso verso giustizia
La giustizia è impegno e fedeltà a Dio e all’uomo. L’immagine dell’impegno è data dal seminare e dal camminare, dall’esodo, dal passaggio dall’interesse alla gratuità, dal dare al ricevere, dal privato al planetario, dalla carità religiosa a quella politica. Il contrario di camminare e seminare è diserzione, indifferenza. Chi diserta non si salva. Gli eventi supremi della salvezza sono caratterizzati dal terremoto, non dal ristagno.
La predilezione per i poveri
Il Signore bussa alla vostra porta con le mani dei poveri. Don Tonino ringrazia Dio di essere nato povero in una terra piccola e povera. Da loro viene la salvezza. Le cose cambieranno, se i poveri lo vorranno. Spetta a noi renderli interlocutori, protagonisti del proprio riscatto.
Il dovere della pace
Pace è Convivialità delle differenze, immagine del mistero trinitario, di tre persone uguali, ma distinte, uniche. È mangiare il pane insieme con i fratelli; è vivere radicalmente il faccia a faccia con l’altro, non il teschio a teschio. Pace è giustizia, libertà, verità, uguaglianza e riconoscimento della dignità umana.
È la somma delle ricchezze più grandi di cui un popolo possa godere, un cumulo di beni. Pax Christi, Comiso, Guerre del Golfo, Sarajevo sono le tappe di un impegno severo, di una responsabilità faticosa che gli procurano incomprensioni, solitudine fino al pianto, superate grazie alla saldezza della sua fede.
Il Mezzogiorno e i giovani
Nella produzione sterminata di don Tonino trovano conferma le analisi della realtà meridionale e le rivendicazioni avanzate dalla Cisl.
Per don Tonino, figlio della terra disastrata del Sud, il Sud d’Italia è il paradigma di tutti i Sud del mondo “dove l’ingiustizia ha collocato il suo domicilio”. Condanna e si batte contro la militarizzazione delle Murge e indica la Puglia come “arca di pace e non arco di guerra”, ma sa anche individuare le condizioni alternative di crescita civile e sociale: rafforzamento di un’etica pubblica, un pensiero diverso, un progetto autonomo di sviluppo fondato sui beni ambientali.
Meravigliosa La lettera ai giovani disoccupati per illustrare il documento dei Vescovi sul Mezzogiorno (1989), questione sulla quale ritorna in Sud a caro prezzo. Da pedagogo riformatore pro-voca i giovani a rimescolare le carte dei partiti in termini di pulizia e di onestà. Fidatevi dei cristiani autentici sovversivi come San Francesco. Coraggio, le cose cambieranno, non vendetevi a nessuno; rifuggite dalle raccomandazioni persino del vostro Vescovo. La speranza siete voi.
Gli anziani
Tante le pagine scritte per gli anziani.
Voi anziani siete fuori mercato perché non producete più. Siete vittime del mito dell’efficienza di questa società mercantile. Fate la cronaca, non la storia. Spesso vi capita di pensare di aver pure torto. La politica vi passa sulla testa, ma il rinnovamento può partire da voi se vi mettete in gioco, liberandovi dallo stile pernicioso della rassegnazione e della delega.
E il sindacato?
Una premessa. Don Tonino, nella Bologna del Card. Lercaro, anni ’50, studia nel Seminario dell’ONARMO (Opera Nazionale Assistenza Religiosa e Morale Operai) dove si preparavano i cappellani del lavoro e fa esperienza diretta nell’area industriale di Bologna.
Non meraviglia che sia in prima fila con gli operai nella difficile vertenza delle Acciaierie e Ferriere di Giovinazzo (BA); li sostiene prelevando undici milioni dal fondo per la costruzione delle chiese e, al culmine della lotta, chiede di essere arrestato al posto di alcuni operai. A un signore che lo invita a prendersi cura delle anime perché ai corpi pensano i sindacati, risponde lapidario: «Spero che il mio impegno sia proteso all’uomo tutto intero». L’uomo tutto intero è il soggetto della sua opera pastorale che trova compimento nell’azione civile e sociale. Don Tonino nobilita il termine sindacato. Il Risorto, l’amante della vita, è il capo del sindacato dei sofferenti. E la sofferenza tiene in piedi il mondo.
Cosa direbbe ancora oggi don Tonino a noi operatori sociali?
Non limitatevi a fare assistenza; organizzate la speranza, ripartendo dagli ultimi che diventano sempre più numerosi.
Ritenetevi servi inutili che stanno Nelle vene della storia, non tacete davanti all’iniqua distribuzione delle ricchezze e schieratevi dalla parte di chi ha fame e sete di giustizia.
Concorrete a rimuovere le forme strutturali delle ingiustizie.
Non fate pagare il costo dello strapotere economico-finanziario a chi fatica a vivere.
Non adagiatevi sul pensiero dominante.
Ricercate soluzioni; il vizio del pensare e di pensare agli altri, specie ai più deboli, è sovversivo perché genera un nuovo ordine mondiale. A questo fine serve la cultura.
Siate amici del cambio, gli appassionati della rivolta per il pane, quindi per il lavoro, la casa, l’istruzione, la salute, la salvaguardia del creato.
Sono beni sacri.
Questo non è marxismo, questo è il Vangelo.
State tra la gente non in capo, né in coda, in mezzo, insieme.
Non abbiate paura di scomodare le autorità costituite. Saranno costoro i primi a ringraziarvi per la coscienza critica che promuovete perché anche a voi il Signore chiederà conto se lo spirito che anima il vostro impegno è quello del servizio o del self service.
Papa Francesco e don Tonino
Papa Francesco, da pellegrino, ha pregato sulla tomba di don Tonino il 20 aprile 2018.
Tutti e due hanno come riferimento il Santo di Assisi; don Tonino si firmava vescovo terziario francescano.
Nel saluto rivolto ai fedeli di Alessano (LE) ripropone tutti i temi cari a don Tonino.
Dal profilo che traccio è facile verificare i tanti tratti in comune: pensieri, convinzioni, gesti e, soprattutto, uno stile di vita semplice, sobrio, coerente che li rende credibili.
Sono poco amati da alcuni ambienti conservatori e accusati di tradire il Vangelo.
Concepiscono la Chiesa in cammino come madre amorosa e strumento d’amore, di perdono.
Prediligono e partono dagli ultimi, dai poveri per costruire un modello un altro sviluppo, sostenibile e pacifico.
Affermano che l’uomo abita la terra, dono di Dio, per custodire il creato e ci esortano a ri-crearlo coltivando i beni della giustizia e della pace.
La partita del Cristianesimo per entrambi non si gioca in sacrestia e nei salotti dei ricchi e potenti, ma tra gli scartati dell’umanità sofferente, nelle periferie abbandonate delle città, tra i profumi delle piazze e delle strade del pianeta terra.
HOMBRE VERTICAL
La cosa più folle di tutte
di Emidio Pichelan

“Sai dove stai andando?”, chiedono al protagonista di L’ora senz’ombra di Osvaldo Soriano. “No”, risponde, “sono stato dappertutto e non ho la minima idea”. Soriano, giornalista e scrittore argentino, morto poco più che cinquantenne, innamorato della vita, del calcio (suo uno dei più libri su questo sport, Il rigore più lungo del mondo) e degli eroi perdenti, ha consumato la sua scrittura denunciando le malefatte di dittatori e dei nemici della verità. Non gli mancavano le storie da raccontare; gli bastava osservare la realtà così com’era: una locura, una follia per El ingenioso hidalgo don Quijote de la Mancha, secondo il quale “forse la cosa più folle di tutte è vedere il mondo così com’è e non come potrebbe essere”.
Un mondo decisamente inquietante quello che si registra in una contea del Tennessee, sud-est degli Usa, la cui capitale Nashville esibisce con orgoglio titoli prestigiosi quali “l’Atene del Sud” e “la capitale statunitense della country music”. È successo che il consiglio scolastico distrettuale della contea abbia ritenuto “inidoneo”, unfit (un aggettivo stampato a grandi caratteri sulla copertina dell’Economist allorquando il cavaliere di Arcore veniva incaricato, per la prima volta, di formare un nuovo governo) l’acquisto della saga in tre volumi Maus di Art Spiegelman, uno scrittore statunitense, figlio di un ebreo polacco sopravvissuto ad Auschwitz. Un testo che aveva ottenuto, unico nel suo genere, il prestigioso Pulitzer come miglior libro dell’anno. Il testo parla dell’Olocausto, rappresenta gli ebrei come topi e i tedeschi come gatti, mentre i polacchi prendono le sembianze dei maiali, gli americani, dei cani, gli inglesi, dei pesci. Troppo forte e realistico quel testo, secondo i membri del consiglio scolastico distrettuale: una realtà desolante i campi di concentramento, i prigionieri come larve ambulanti, divise raccapriccianti, cadaveri appesi, donne nude rapate a zero, filo spinato, torrette e soldati armati. Un orrore destabilizzante per ragazzi e adolescenti facilmente impressionabili.
Nulla hanno da eccepire quei genitori coscienziosi sulle armi, più numerose dei libri, in libera vendita, in bella mostra nelle loro case.
Steve Bannon, l’ex guru della vittoriosa campagna presidenza di Donald Trump, ex marine, ex banchiere, ex manager, teorico della lotta politica come guerra civile a bassa intensità sul modello della guerra fredda, ha lanciato la “battaglia dei libri di testo” come strumento per polarizzare la società, condizione – a quanto pare – elettoralmente molto redditizia per la “loro” causa. Da una parte “loro”, i “patrioti” del sogno americano, i crociati della razza bianca contro le minoranze (negri e latinos in particolare), i nemici giurati di quel sistema corrotto, ipocrita e debosciato denominato democrazia e, dall’altra, tutti gli altri, i “non patrioti” in salsa americana.
Povero mondo – loco, per dirlo con l’aggettivo di Miguel de Cervantes – se i libri di testo e le scuole diventano terreno di scontro, di contrapposizione e di affermazione di una fazione rancorosa, fanatica, violenta, antidemocratica. Povero mondo, loco, se una generale amnesia e una fatale nostalgia del passato sembrano far dimenticare a tanti, a troppi cittadini dove ci hanno portato i nazionalismi, i miti delle vittorie mutilate, la negazione della realtà, la sfiducia nella scienza, l’ignoranza della storia e del passato. Non rimane che “resistere, resistere, resistere”, come raccomandato da Francesco Saverio Borrelli, l’ex capo del pool Mani Pulite, nel discorso di congedo dalla vita attiva di magistrato.
“Sono convinto che il cristiano o è un resistente o non è cristiano”, ripeteva senza stancarsi Davide M. Turoldo, sacerdote e poeta, filosofo e profeta tanto in ambito religioso come in quello civile. E s’era inventato una nuova beatitudine: “Beati coloro che hanno fame e sete di opposizione”.
STORIA CONTEMPORANEA
Parlamentarismo e antiparlamentarismo. La lezione del fascismo
di Paolo Acanfora

Nello scorso numero (febbraio 2022), si è visto come il rapporto tra fascismo e democrazia sia articolato e possa offrire spunti per riflessioni meno scontate di quanto generalmente si immagini. Le questioni sollevate circa il rapporto tra capo e masse, l’incarnazione del principio della volontà generale e l’intreccio tra questa e la costruzione di un sistema totalitario hanno come comune punto di partenza il rifiuto della democrazia liberale.
Ora, è evidente che la democrazia liberale ha avuto nella storia e ha tutt’oggi forme di realizzazione assai diverse. In Occidente, i sistemi presidenziali (come quello statunitense), semipresidenziali (come quello francese), il cancellierato tedesco, il premierato inglese, il parlamentarismo italiano, etc. sono tutte espressioni istituzionali di democrazie liberali. Ciò per dire, banalmente, che parliamo di realtà plurali che possono prendere forme diverse ed avere caratteristiche anche sensibilmente differenti. Quel che tiene assieme questa pluralità di sistemi è il riferimento al tradizionale costituzionalismo otto-novecentesco (di fine Settecento, nel caso statunitense), in cui vengono sanciti innanzitutto i diritti e le libertà individuali e garantito il principio della libertà di voto in un regime a suffragio universale.
Il fascismo si è storicamente inserito in uno dei passaggi critici del sistema liberale presentandosi come una proposta politica radicalmente anti-sistemica. Il principio fondamentale di questa antitesi è proprio nel netto rifiuto del primato dell’individuo. Nella concezione politica fascista, l’individuo è interamente subordinato allo Stato; uno Stato etico che educa le masse alla visione fascista dell’uomo, della storia, della società. La totale subordinazione dell’individuo alla comunità nazionale avviene attraverso la disciplina e il cameratismo, all’interno di un contesto rigidamente gerarchizzato. In questa visione, non c’è spazio per i diritti individuali.
L’assalto del fascismo alla democrazia liberale è avvenuto in Italia attraverso la critica radicale e feroce al parlamentarismo. Non è stato certo il fascismo il primo movimento politico a vedere in esso la degenerazione delle istituzioni. Al contrario, si è inserito e si è servito di un diffuso clima di ostilità nei confronti del parlamento e della sua centralità nell’Italia liberale. La cultura antiparlamentare si è a lungo nutrita di rappresentazioni stereotipate che oggi sarebbero annoverate dagli analisti nel moderno (o, se si vuole, postmoderno) fenomeno dell’antipolitica. Il parlamento è divenuto nei primi decenni del Novecento il luogo delle negoziazioni private in cui i singoli notabili contrattano i propri interessi; l’istituzione trasformista per eccellenza, dove i deputati cambiano linea politica ed alleanze a seconda delle convenienze del momento; il centro di un sistema di potere paralizzato, incapace di prendere decisioni. Anziché essere valorizzato come l’istituzione capace di rappresentare i legittimi e plurali interessi della società civile, il parlamento è divenuto l’emblema della divagazione, del chiacchiericcio, delle lungaggini contrattuali, popolato da persone interessate solamente al proprio tornaconto e prive di una visione del bene comune e dell’interesse nazionale.
Il fascismo si è pienamente inserito in questo filone e ne ha ingrossato le fila, portandolo al suo punto più radicale. Essendo espressione di un sistema democratico che seleziona, per sua stessa natura, l’uomo mediocre, il parlamento diventa – come ha tuonato Mussolini il 16 novembre 1922 nel suo primo discorso da capo del governo – un’aula “sorda e grigia” che egli avrebbe potuto “sprangare” e trasformare in un “bivacco di manipoli”. È il punto più alto della critica all’inutilità dell’istituzione parlamentare ed è, non a caso, l’avvio di un regime che fu innanzitutto antiliberale e, appunto, antiparlamentare.
È del tutto evidente che da ciò non consegue che le critiche al sistema parlamentare siano ipso facto illegittime o possano essere bollate come antidemocratiche. Ma è bene precisare che occorre fare molta attenzione nel non identificare le classi dirigenti (e la qualità di esse) con le istituzioni che rappresentano o i limiti e i difetti di questo o quell’istituto con l’intero sistema. Può sembrare ovvio e banale ma questa sana distinzione può tracciare le linee di sviluppo di un paese e portarlo ad imboccare strade molto diverse, quando non opposte.
UN AUTORE
ALESSANDRO ZACCURI
Manzoni? C’est moi
di Leonarda Tola

Di Alessandro Zaccuri, scrittore e firma di valore del quotidiano Avvenire, è appena stato pubblicato il romanzo Poco a me stesso (Marsilio, 2022, pagg. 234). Il titolo viene dal sonetto di Alessandro Manzoni che chiude così il suo autoritratto giovanile. “Poco noto ad altrui, poco a me stesso:/Gli uomini e gli anni mi diran chi sono”. Ce ne dà conto lo stesso Zaccuri nelle pagine che leggiamo, finita la storia e a chiusura del libro, a guisa di sua “Giustificazione e congedo”.
Il personaggio intorno a cui si sviluppa il racconto che ha occupato, impossessandosene, l’immaginazione dell’autore in una lunga gestazione (un quarto di secolo), è nato il 7 marzo 1875, figlio di Giulia Beccaria, figlia a sua volta del grande Cesare Beccaria, “che l’intera Europa aveva salutato come nuovo legislatore di un’epoca più giusta e fraterna” (p. 13) nella Milano di fine Settecento.
Ma il personaggio di Poco a me stesso non è il figlio di Giulia, Alessandro, che prende il cognome (se non il sangue) da Pietro Manzoni, l’attempato e modesto nobiluomo che Giulia ha sposato a 20 anni “senza per questo rinunciare a essere l’amante del cavaliere di Malta Giovanni Verri”. Il protagonista non è l’autore degli Inni Sacri e dell’Adelchi e soprattutto dei Promessi Sposi, il sommo letterato a cui si deve l’invenzione della lingua che gli italiani oggi parlano e scrivono quando e se sanno parlare e scrivere in italiano. La storia immaginata nel romanzo è quella del “ Manzoni mancato”, la vita che sarebbe stata se …: nell’invenzione di Zaccuri la storia dell’unico figlio di Giulia Beccaria, nato il 7 marzo 1785, è quella di un neonato illegittimo, che la madre affida a un istituto di trovatelli, dove gli viene dato il nome di Evaristo Tirinnanzi e da dove se lo va a riprendere da grande : il Tirinnanzi vivrà sempre a palazzo Beccaria ignaro della sua identità, assunto come fidatissimo e fedelissimo contabile e amministratore. Una immaginaria vita alternativa a quella del Manzoni immortale letterato, un’esistenza nascosta e scarna di chi, avendo le potenzialità, comprovate, di diventare Alessandro Manzoni, resta Tirinnanzi: balbuziente, in ombra, ai margini e nelle nebbie di un’identità sconosciuta anche a se stesso e che insegue con affanno. Afflitto dall’ immanenza di quell’altro che si palesa ad intervalli di pacata follia con misteriose e indecifrabili dettature di lacerti di manzoniana memoria. Il romanzo di Zaccuri è tutto intorno a Manzoni, famiglia, casa e milieu, ma decapitato del protagonista: che resta consegnato al suo genio, in nessun modo riducibile alla sua biografia. È invece raccontata la vita del contabile Evaristo, il susseguirsi dei giorni (mancando le opere di scrittura), alla corte della marchesina Giulia e fino alla morte di quest’ultima (1841), con immaginifica aderenza ai costumi, abitudini, vizi e vezzi della società elevata della Milano tra Settecento e Ottocento.
Vi si narra la comparsa e il soggiorno nel palazzo dei Beccaria nel quartiere di Brera di un tal barone di Cerclefleury apostolo del mesmerismo, movimento fondato da Franz Anton Mesmer, medico tedesco (1734-1815); l’avvenente barone promette l’eterna giovinezza agli umani ma soprattutto alle dame della nutrita cerchia di nobildonne amiche-consorelle della quasi ottuagenaria Beccaria, spirito libero, madrina e propagandista della nuova dottrina.
Nel romanzo non scorrono solo quei tempi e le umane vicissitudini che ne discendono ma sono magnificamente evocati e ricostruiti i luoghi della Lombardia e soprattutto della sua città più importante: “Ah Milano! Ahi, perduto splendore delle straducole dispettose a tracciare un labirinto di slarghi e strettoie! Dove sono i ponti, dove le sponde lungo le quali placido scorreva il Naviglio? Dov’è adesso, la gran fossa di San Marco? Fortore come di selvaggina, afrore di fiume costretto a scorrere tra cortili e palazzi, Ah, Milano, dov’è oggi la quieta gloria delle tue bellezze?”.
Un’immersione nella realtà storica e dell’invenzione dello “scrittore che più ammiro”, afferma Zaccuri rivelando quello che noi lettori del 2022 già sappiamo della sua conoscenza larga e minuziosa, intima, e profonda del Manzoni uomo, letterato e scrittore. Una consuetudine con la vita e la scrittura di don Lisander, tale da fargli confessare di temere l’accusa di una “confidenza eccessiva”. Una confidenza tuttavia benedetta che consente il miracolo della lingua del romanzo nel quale Zaccuri “si sforza di adeguare la lingua parlata dai personaggi a un uso mediano, ma si confida non mediocre dell’italiano del tempo”.
A conti fatti il fascino di Poco a me stesso sta precisamente nella sua lingua “peculiare” fluida e avvolgente che scorre in un crescendo narrativo ed espositivo che ora ha il passo lungo ora la stringata efficacia di conclusioni inattese. La sontuosa abbondanza di un dire vario e sapiente sempre appropriato (lessico e sintassi) che tutto sembra cercare e potere nella felicità espressiva che niente lascia di ciò che vede e sente senza che lo si possa dire. Un godimento per chi legge all’altezza dell’ispirazione di chi ha scritto.
Alessandro (Zaccuri) si legge con ammirazione oggi e si potrà tornare a leggere nel tempo. Come Manzoni. Meritoriamente viene ripagata l’ostinata determinazione dell’autore a pedinare passo passo il grande lombardo.
AUTOBIOGRAFIE SCOLASTICHE
Amos Oz
di Mario Bertin
Amos Oz (1939-2018) è lo pseudonimo di Amos Klausner, giornalista, scrittore, saggista, protagonista di primo piano della vita intellettuale e politica israeliana. È stato anche docente di letteratura nella Università Ben Gurion. Egli ha narrato le vicende della sua famiglia in quello che è considerato il suo capolavoro Una storia di amore e di tenebra, da cui sono tratti i due brani che proponiamo in queste pagine. Brani che è stato difficile scegliere tra i molti dedicati alla sua giovinezza e alla sua formazione. Esse, infatti, appaiono polarizzate attorno a due eventi che le hanno segnate profondamente: il suicidio della madre, quando Amos aveva soltanto dodici anni, e il contrasto con il padre che lo indussero ad abbandonare la famiglia e a intraprendere la vita e il lavoro nei Kibbutz. Questi avvenimenti sono, tra l’altro, all’origine della decisione di cambiare il cognome originario in “Oz”, che in ebraico significa “forza”.
Una storia di amore e di tenebra è un romanzo autobiografico nel quale la storia personale si intreccia tanto strettamente con la storia del nascente Stato di Israele, a partire dalla fine del protettorato britannico fino all’attualità, che non è possibile comprendere l’una senza l’altra. Le minuscole vicende quotidiane dell’autore sono narrate, nella loro nascita e nel loro svolgimento, dentro gli avvenimenti del paese. La vita quotidiana appare inscindibile da questi ultimi.
Oltre ai suoi romanzi, Oz pubblicava regolarmente saggi di politica e sulla pace per il giornale laburista “Davar” (termine ebraico che significa contemporaneamente “parola” e “fatto”). Negli uni e nell’altro, enfatizzò fin dall’inizio l’attività colonizzatrice dello Stato ebraico, sostenendo le posizioni conciliatrici sia nella sfera politica che nella sfera socio-economica (“Il nostro problema più grande è la scomparsa della solidarietà sociale. Qui si sta sviluppando un grande egoismo che non ha vergogna nemmeno di sé stesso”).
Oz fu uno dei fondatori del movimento “Peace Now”.
Il suo “modesto libro”, come lo definì lui stesso è percorso da una sottile vena umoristica.
Una storia dentro una storia

In ogni aula d'asilo, delle elementari e del liceo al Tarbut erano appese una grande immagine di Herzl, una grande mappa che andava da Dan sino a Beer Sheva, con gli insediamenti dei pionieri in rilievo, il bossolo con le offerte al “Keren Kayemet” (“Fondo nazionale”), alcune foto di pionieri al lavoro e diversi slogan con citazioni di poesie. Due volte Bialik venne in visita a Rovno e due volte fu tra noi anche Saul Černichovskij, e anche Asher Brash mi pare, o forse era un altro scrittore. Anche dei dirigenti d'Israele venivano quasi ogni mese, Zalman Rubashov, Tabenkin, Yaakov Zerubabel, Zeev Jabotinsky.
Preparavamo in loro onore delle grandi parate con tamburi e bandiere, decorazioni e lampade di carta, con entusiasmi e slogan e fascia intorno al braccio e poesie, il sindaco polacco in persona veniva apposta per loro, e così a volte potevamo quasi sentire che anche noi eravamo un popolo ormai, non più solo feccia. Forse fai un po' fatica a capirlo, tu, ma in quegli anni tutti i polacchi erano intossicati di polacchità, gli ucraini di ucrainità, e i tedeschi, e i cechi, persino gli slovacchi e i lituani e i lettoni, mentre poi non avevamo posto dentro questo carnevale, noi eravamo degli esclusi, degli indesiderati. C'è di che stupirsi, dunque, che anche noi -ambissimo a diventare un popolo, come tutti gli altri? Che scelta avevamo?
Ma non era un'educazione sciovinista. Il contesto del Tarbut era umanistico, progressista, democratico, e anche artistico, scientifico. A maschi e femmine si cercava di dare parità di diritti. Imparavamo a rispettare gli altri popoli: ogni uomo è creato a immagine divina, anche se lo dimentica continuamente. Fin da piccoli con il pensiero eravamo già in terra d'Israele, conoscevano come le nostre tasche i villaggi agricoli, che cosa cresceva nei campi di Beer Tuvia e quanti abitanti aveva Zikhron Yaakov, chi aveva tracciato la strada Tiberiade-Tzemach e quando si era saliti al Monte Ghilboa. Sapevamo persino che cosa mangiavano lassù, e come si vestivano. Cioè, pensavamo di saperlo. Gli insegnanti in fondo non conoscevano tutta la verità, e perciò anche se avessero voluto raccontarci i lati brutti non avrebbero potuto: non ne avevano idea. Chi arrivava dalla terra d'Israele, inviati, istruttori, dirigenti, chiunque gridasse e tornasse, ce ne dipingeva un ritratto affascinante. E se qualche volta qualcuno tornò e raccontò cose non così belle, noi non eravamo disposti a sentirle. Insomma, lo mettevamo a tacere. Lo trattavamo con disgusto.
*
Il preside del nostro liceo era un signore incantevole, charmant, un fantastico educatore dotato di un'intelligenza spiccata e della sensibilità di un poeta. Si chiamava Reis, dottor Reis, Issachar Reis. Arrivò a noi dalla Galizia e ben presto divenne un idolo per la gioventù. Tutte le ragazze erano segretamente innamorate di lui, anche mia sorella Haya, che durante il liceo si distinse per il suo attivismo e una naturale propensione al comando, anche Fania tua madre, su cui il dottor Reis esercitava un'influenza mistica, e. con gentilezza la spinse verso gli studi di letteratura e arte. Era un uomo così bello e virile, un po’ alla Valentino o Navarro del cinema, pieno di calore ed empatia, non si arrabbiava quasi mai, e se lo faceva non esitava poi a convocare lo studente e chiedergli scusa per quel suo sfogo.
Tutta la città era affascinata da lui. Penso che le madri lo sognassero e le figlie si struggessero. Anche i ragazzi, del resto, non solo le ragazze: cercavano di imitarlo. Di parlare come lui. Di tossire come lui. Di interrompersi a metà di una frase, come faceva lui, e fermarsi qualche istante davanti alla finestra, immersi nei pensieri. Avrebbe avuto un grande successo come seduttore. E invece: per quel che ne so, era sposato, non proprio felicemente, con una donna che non meritava nemmeno di baciargli i piedi e si comportava come un marito modello. Avrebbe fatto carriera anche come dirigente; era infatti di quel genere di persone per le quali gli altri sono disposi a buttarsi nel fuoco e nell'acqua, a far qualunque cosa pur di strappargli un sorriso di approvazione, un complimento. Le sue idee erano quelle di tutti noi. Il suo humour fu adottato da tutti noi. E lui era convinto che solo in terra d'Israele gli ebrei sarebbero guariti dai loro disturbi mentali e avrebbero potuto dimostrare a se stessi e al mondo che hanno buone qualità.
Oltre a lui avevamo altri fantastici professori: c'era Menachem Gelerter che ci insegnava la Bibbia come se lui fosse stato presente in quei luoghi e in quei momenti. Lui ci faceva anche letteratura ebraica e letteratura degli altri popoli, ricordo che un giorno in classe ci dimostrò, testi alla mano, che Bialik non aveva nulla da invidiare a Mickiewicz, il poeta nazionale polacco. Menachem Gelerter ogni settimana ci portava in gita in terra d'Israele: una volta in Galilea, un'altra nei villaggi di Giudea, una volta nella Valle di Gerico, o per le strade di Tel Aviv. Portava carte e fotografie, ritagli di giornale e brani di poesie e testi, pagine della Bibbia e di geografia, storia, archeologia, cosi che poi sentivi una piacevole fiacchezza, come se davvero fossi stata lì non solo con i pensieri ma proprio con le gambe, a camminare sotto il sole e nella polvere, fra gli alberi di agrumi e la capanna nella vigna, fra i cespugli di fichi d'India e le tende dei pionieri. E così, sono arrivata in terra d'Israele molto prima di arrivarci.
(…)
A circa una mezz'ora di buon passo di bimbo da casa nostra si trovavano due scuole elementari, una troppo socialista e l'altra troppo religiosa: “Casa dell'Educazione per i figli della classe operaia Berl Katzenelson”, a nord di via Ha Turim, sul cui tetto sventolava, accanto alla bandiera nazionale, anche un'altra rossa. Lì si festeggiava con parata e cerimonie il Primo maggio. Il direttore lo chiamavano “compagno”, tanto gli insegnanti quanta gli allevi. Gli insegnanti indossavano d'estate dei pantaloni cachi corti e sandali in stile biblico. Nell'orto in cortile i bambini venivano formati alla vita dei campi e alla realizzazione personale attraverso il lavoro. Nei laboratori ci si impratichiva con mestieri quali quello del falegname e del fabbro, meccanico e maniscalco, e anche un'altra cosa di cui si sapeva poco ma che incuriosiva, chiamata meccanica di precisione.
In classe i bambini potevano sedersi dove volevano, persino i maschi vicino alle femmine. Quasi tutti portavano camicie celesti con dei nastri rossi o bianchi. I ragazzi avevano i pantaloni corti ripiegati fin quasi al cavallo, mentre quelli delle femmine, anch'essi corti in un modo inverecondo, erano stretti alle gambe con degli elastici. Gli scolari si rivolgevano agli insegnanti chiamandoli sempre e solo per nome, Nadav, Alichin, Edna o Haghit. Lì si studiavano: matematica e patria e letteratura e storia, ma anche materie quali storia della comunità in terra d'Israele e del movimento operaio, principi del movimento operaio, fasi nell'evoluzione della lotta di classe. Cantavano anche a squarciagola tutti gli inni proletari, a cominciare dall'internazionale per finire con Saremo tutti pioniere e pioniere o Camicia blu...
In quella scuola per figli della classe operaia la Bibbia era materia d'insegnamento in quanto collezione di argomenti d'attualità: i profeti erano combattenti per il progresso e la giustizia e lo stato assistenziale, mentre sovrani e sacerdoti erano i rappresentanti dell'ingiustizia sociale vigente dominante. Il giovane Davide, pastore del gregge, era un guerrigliero coraggioso nelle file del movimento per la liberazione nazionale dal giogo filisteo, ma in tarda età diventava anch'egli un re colonialista-imperialista, conquistatore di terre e oppressore di genti, indegno sfruttatore della classe operaia.
A quattrocento metri di distanza da questa rossa Casa dell'Educazione, nella via parallela, c'era invece la scuola tradizional-nazionale Tachmoni del movimento religioso “Ha Mizrach”, che prendeva solo maschi, e solo con la papalina in testa. Si trattava per lo più di bambini di famiglie povere, a parte alcuni figli della buona borghesia sefardita insediata da sempre a Gerusalemme ma rimasta esiliata fuori con la diffusione dell'inflessibile cultura ashkenazita. In questa scuola i bambini erano chiamati sempre e solo per cognome, Bozo, Valero, Danon, Cordovero, Saragasti, Alfassi, mentre gli insegnanti erano rispettivamente signor Neimann, signor Alkalai, signor Mikhaeli, signor Avisar, signor Benvenisti e signor Ophir. Il direttore era chiamato illustre signor direttore. Ogni mattina la prima ora iniziava con la preghiera, dopo la quale veniva l'ora di Bibbia o di commento, e altre lezioni in cui gli allievi ripetevano i “capitoli dei padri” e studiavano la tradizione dei maestri, il Talmud, le leggende e le norme e la storia delle preghiere e della poesia religiosa, e poi precetti e opere edificanti, capitoli tratti dal codice “Shulchan Arukh” e dal formulario di preghiere e storia dell'esilio d'Israele e biografie dei grandi eruditi e alcune gesta e opere edificanti, un poco di Yehudah Ha Lewi e altrettanto di Bialik, e fra questi e quelli qualche rudimento di grammatica ebraica e di matematica, inglese e canto, storia e un briciolo di geografia. Anche d'estate gli insegnanti portavano la giacca, mentre l'illustre signor direttore Ilan aveva sempre un completo a tre pezzi.
Mia madre avrebbe voluto mandarmi sin dalla prima alla Casa dell'Educazione, vuoi perché non approvava la rigida separazione dei sessi del modello religioso, vuoi perché il vecchio Tachmoni, con i suoi grevi edifici in pietra costruiti ancora ai tempi del dominio turco, le sembrava troppo antiquato, esilino e triste al confronto con la scuola della classe operaia, le sue grandi finestre, le aule luminose, il suo orticello, e quell'allegria perpetua, frizzante. Forse quella scuola le ricordava in qualche modo i tempi del liceo Tarbut a Rovno.
Quanto a mio padre, si mostrava non poco incerto sul da farsi: la sua massima ambizione era che io andassi a scuola insieme ai figli dei professori di Rechavia o almeno con quelli di medici, insegnanti e impiegati residenti a Bet Ha Kerem, ma a quei tempi non erano rari gli incidenti e le sparatorie, e tanto Rechavia quanto Bet Ha Kerem erano distanti due autobus da casa nostra a Kerem Abraham. I principi del Tachmoni erano affatto estranei al suo animo laico-nazionalista e al suo spirito illuminato e scettico. La Casa dell'Educazione, per contro, la considerava quale una torbida fonte di indottrinamento comunista e di lavaggio del cervello proletario. Non gli restò pertanto altro da fare che soppesare l'uno di fronte all'altro tanto il rischio nero quanto quello rosso e alla fine scegliere il minore dei mali.
Dopo tante titubanze papà decise, contrariamente all'opinione di mamma, di mandarmi al Tachmoni: riteneva che, anche qualora mi fossi trasformato in un bambino religioso, tutto ciò non rappresentava un grosso rischio dal momento che comunque la religione aveva i giorni contati, giacché il progresso la spingeva via rapidamente, e se anche supponiamo loro fossero riusciti a farmi diventare per un certo periodo un chierichetto, ben presto sarei comunque rinsavito, scrollandomi via di dosso tutta quella polvere arcaica, e anche la rigida osservanza dei precetti religiosi sarebbe passata senza fare danni, destinata com'era a estinguersi nel giro di pochi anni insieme ai bigotti e alle loro sinagoghe, di cui non sarebbe rimasto altro che un pallido ricordo nel folklore.
Mentre nella Casa dell'Educazione si prospettava, secondo l'opinione di papà, il rischio di un'autentica minaccia ideologica: l'onda rossa infatti andava montando nella nostra terra, e si stava diffondendo in tutto il mondo. L'indottrinamento socialista era insomma un abisso da cui non si risaliva mai. Se gli mandiamo il bambino, in un attimo gli riempiranno il cervello e lo monteranno con tutte quelle frottole di Marx, trasformandolo rapidamente in un bolscevico, in un soldatino di Stalin, lo spediranno in uno dei loro kibbutz e di là non c'è ritorno (“quanti vi entrano non ne ritornano”, citava papà dal libro dei Proverbi).
Amos Ox, Una storia di amore e di tenebra, Milano, Feltrinelli 2003. Edizione speciale per Corriere della sera, RCS, Milano 2020, pp. 240-242 e 342-344)
ZIBALDONE MINIMO
Tradimento
di Gianni Gasparini

Il verbo tradire, da cui il sostantivo tradimento, mantiene nell’origine latina tradere il doppio significato di trasmettere in genere e di “consegnare con inganno qualcuno al nemico”: il tradimento di Giuda di cui leggiamo nei Vangeli è appunto una consegna di Gesù nelle mani dei capi dei Giudei. Il tradimento nel significato odierno si può considerare il venir meno della fede data, con riferimento a impegni di particolare importanza o gravità: come nel caso, ad esempio, della fedeltà alla patria o alla Costituzione suggellata da un giuramento. In termini più ordinari di vita quotidiana, il tradimento è una realtà che può riguardare tra l’altro la fedeltà coniugale, o l’impegno preso nei confronti di un amico. Tradire può significare anche, in termini ampi, il deludere l’aspettativa non solo di singoli – il coniuge, l’amico, il congiunto – ma di un insieme più o meno vasto di persone che si aspettavano qualcosa di positivo da un altro, ad esempio un artista o un politico: si può tradire la propria vocazione, si possono tradire i valori in cui si aveva dichiarato di credere.
Il tradimento delle aspettative legate a una situazione socioculturale consolidata è particolarmente poignant come si dice in francese, è un pugno nello stomaco o sulla faccia, è una pugnalata alla schiena, qualcosa che ti sorprende e ti lascia senza parole, in preda alla rabbia cocente o alla costernazione. Ricordo, l’11 settembre 2001, il reportage su una donna in lacrime davanti alle torri distrutte che diceva “Credevo che noi fossimo sicuri”. Come centinaia di milioni di americani e di cittadini del mondo, questa donna esprimeva insieme l’illusione e la delusione riguardo al vivere in un paese sicuro, al riparo dal terrorismo e dalle guerre. .
Ci sono diversi livelli di fiducia, così come tipi diversi di tradimento. Certo il venir meno tra due persone di un rapporto personale profondo, costruito nel tempo, condiviso e fondato persino sull’intimità crea grandi sofferenze. Ma ci sono altri tradimenti che sono ugualmente apportatori nelle persone e nei gruppi sociali di disagi, tensioni, patimenti prolungati. .
Proviamo ad immaginarci nella fantasia un continente che dopo oltre due millenni di conflitti politici e religiosi di ogni genere abbia deciso di porre fine alle guerre tra paesi, popoli, nazioni. Un continente che contenga decine di etnie, lingue e nazionalità diverse e nel quale si pronunci la parola PACE: non solo la si pronunci, ma si cerchi di costruirla con solide strutture di tipo economico, giuridico, culturale, sociale che impediscano di fatto le guerre al suo interno, che creino una moneta comune (fatto quasi miracoloso!), che adottino misure volte ad assicurare l’eguaglianza tra paesi membri grandi e piccoli, che considerino le diversità culturali una ricchezza anziché un motivo di contrapposizione. .
Continuando ad immaginare, figuriamoci nella mente un continente che sia riuscito per 77 anni a scongiurare guerre al suo interno e ai suoi confini, che sia riuscito nonostante ovvie tensioni interne a costruire gradualmente una cultura della pace, a voltare decisamente e “per sempre” pagina rispetto ai nazionalismi perversi che hanno causato le guerre del XX secolo con le loro decine di milioni di morti, con i loro dittatori sanguinari e disumani. Un continente consapevole del pluralismo e delle diversità ideologiche nel mondo, ma in cui si guarda ai conflitti (reali e potenziali) non con la metodologia sinistra della guerra e del sopruso ma con quella del dialogo, del rispetto del diritto internazionale, della diplomazia, dell’incontro, del compromesso costruttivo. .
Ebbene, continuando a immaginare, proviamo a pensare a un gesto dirompente e del tutto inatteso dalla quasi totalità degli appartenenti a questo continente in pace. Il gesto di un dittatore senza scrupoli che organizzi con mezzi militari inauditi l’occupazione di un paese limitrofo, un paese indipendente e pacifico che vive in questo continente, se pure ai suoi margini. Il dittatore – continuiamo a fare esercizio di immaginazione - non ha alcuna motivazione reale e oggettiva, richiama la favola eterna del lupo e dell’agnello a una medesima fonte, con la conclusione del sopruso del lupo che dopo aver cercato motivazioni per aggredire l’agnello e non avendone trovate lo sbrana ugualmente, forte della sua forza bruta. Il dittatore non si accontenta del primo pasto, ma non esclude altre invasioni e guerre per aumentare il suo potere e quello del suo paese. Il tiranno sanguinario minaccia in modo ricattatorio non solo i cittadini del paese invaso proditoriamente, ma tutti i paesi e gli abitanti di quel continente – che fino a quel momento si poteva considerare “felice” per l’assenza di guerre al suo interno – e degli altri continenti del mondo. .
Che cosa succederà al paese invaso con mezzi debordanti, forieri di morte e distruzione? Come reagiranno i paesi e i cittadini di quel continente che è stato tradito brutalmente nella sua fiducia, nelle sue sicurezze di base riguardo ai rapporti con il paese del dittatore-tiranno? .
Ora, i paesi di quel continente si rendono conto – ed è una sorta di risveglio brutale alla realtà – che il Novecento non è ancora finito, che la storia per così dire sembra essere tornata indietro di molti decenni. Ma insieme a questa consapevolezza ne coltivano un’altra, più profonda e più semplice, che richiama magari quella della canzone di tanti anni fa cantata da Joan Baez We shall overcome: noi ce la faremo, noi alla fine vinceremo, noi faremo trionfare la pace e la giustizia nel nostro paese, nel nostro continente, nel mondo. Nonostante tutto. .
Come ben intenderanno i lettori, ogni somiglianza di questo breve racconto di fantasia con l’invasione dell’Ucraina e la guerra scatenata dalla Russia nel febbraio 2022 è puramente casuale, pardon causale.

