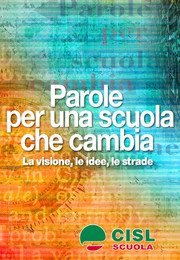
In questa pagina:
Pensieri a voce alta: Totem e tabù. A proposito degli ultimi scioperi (Maddalena Gissi)
La parola di questo mese: Motivazione (Dino Cristanini)
La scuola è viva. W la scuola: Recuperiamo la gentilezza perduta (Lorenzo Fabiano)
Hombre vertical: Missione n. 4: dipende da noi (Emidio Pichelan)
Storia contemporanea: 1922-2022: il centenario della marcia su Roma (Paolo Acanfora)
Un autore: Aperti al soffio di ogni cosa (Leonarda Tola)
Autobiografie scolastiche: Albert Camus (Mario Bertin)
Zibaldone minimo: Volto (Gianni Gasparini)
Scrivici, se vuoi, a redazione@cislscuola.it
PENSIERI A VOCE ALTA
Totem e tabù. A proposito degli ultimi scioperi
di Maddalena Gissi

Lo sciopero non è un totem, di fronte al quale prostrarsi in adorazione. A scanso di equivoci, e prendendo ancora a prestito il titolo del noto testo di Sigmund Freud, non è nemmeno un tabù. Per noi non lo è mai stato: tanti ne abbiamo proclamato nella nostra storia, altri ne faremo, se e quando sarà necessario. Perché qui è il punto: lo sciopero è solo uno strumento dell’azione sindacale. Strumento importante, significativo e credibile anche per il sacrificio che comporta il parteciparvi, ragione della nobiltà che gli si riconosce, giustamente, rispetto ad altre azioni meno impegnative e che qualcuno ritiene più efficaci perché più "disturbanti". Ma sempre uno strumento rimane, lo sciopero: funzionale a un obiettivo; sempre un mezzo, mai un fine. Strumento che può essere utilizzato bene e meno bene. A volte malissimo. Dunque non basta di per sé a stilare classifiche tra sindacati più o meno combattivi, più o meno arrendevoli; e dovrebbe essere sempre considerato possibile e lecito criticare azioni di sciopero non condivise, senza ricevere per questo accuse di “intelligenza col nemico”.
Oggetto della mia riflessione a voce alta, come credo sia chiaro a tutti, sono le vicende del mese scorso, con l’effettuazione di due scioperi nel giro di una settimana, non condivisi dalla CISL. Entrambi qualificati come “generali” (anche se il primo riguardava solo la scuola), entrambi con un riscontro che definire poco esaltante è un eufemismo, al punto che un noto giornalista, descrivendolo come “uno sciopero generale di minoranza”, e conoscendo esattamente – a differenza di altri – il significato del termine ossimoro, come tale lo ha definito (Dario Di Vico, Corriere della Sera, 17 dicembre 2021).
I dati, laddove effettivamente e obiettivamente misurabili, sono impietosi: se nella scuola il 10 dicembre ha scioperato il 6,78%, negli altri comparti del lavoro pubblico lo sciopero generale del 16 dicembre ha raccolto un’adesione che supera di poco il 4%. Lecito allora chiedersi se tra i “rematori contro” (così siamo stati più o meno liquidati) sia compreso anche il 90 e passa per cento di lavoratrici e lavoratori non scioperanti. Tutti insensibili, disimpegnati, indifferenti, rassegnati? Tutti classificabili e condannabili come crumiri?
Farebbe sorridere, se non fosse preoccupante, il tentativo di leggere come un successo le adesioni allo sciopero del 10 dicembre prendendo a paragone gli esiti di un altro sciopero di cinque anni fa – già allora definiti diplomaticamente “non esaltanti” – e aggiungendo, a sovrappeso della soddisfazione per aver “quasi” raggiunto quella percentuale (in realtà mancano quasi due punti e mezzo), un’ardita acrobazia aritmetica, tesa a dimostrare una presunta irrilevanza della CISL, quando i numeri, se correttamente analizzati, attestano esattamente il contrario. Ma ha davvero ben poco senso attardarsi su polemiche del genere: ne avrebbe senz’altro molto di più interrogarsi a fondo sul perché di un esito (non imprevedibile) che non rafforza certamente l’azione del sindacato, mettendone in discussione la rappresentatività con dati sui quali la politica potrebbe essere indotta a far leva per accrescere le sue pretese di autosufficienza. Davvero un bel risultato, se si considera con quanta insistenza stiamo tutti da tempo rivendicando più spazio al dialogo e al confronto, più valore alle relazioni sindacali, più ascolto del mondo del lavoro nell’ottica di una governance del Paese improntata al dialogo sociale.
Si rifletta, si ragioni, ci si confronti su questo, evitando di trasformare lo sciopero del 10 dicembre (ma anche quello del 16) nello spartiacque tra sindacati buoni e cattivi, “veri” e “meno veri”, pugnaci e remissivi. Si abbia la capacità, il coraggio, l’onestà di guardare i fatti nella loro evidenza e di trarne, se possibile, qualche insegnamento. Si cresce anche facendo tesoro dei propri errori.
Non è certo la prima volta che l’unità d’azione fra le organizzazioni sindacali incontra difficoltà ed entra più o meno profondamente in crisi. Il pluralismo dei sindacati è in Italia un dato consolidato, fin da quando nel 1950 CISL e UIL si costituirono in organizzazioni autonome e indipendenti ponendo fine all’esperienza della CGIL unitaria; un pluralismo sfociato in alcuni settori, tra cui il nostro, in una proliferazione – circa 170 sigle! – che sembra non incontrare e non concepire limiti.
In un simile contesto, l’unità non può mai darsi per scontata, ma va sempre costruita con intelligenza e la necessaria pazienza.
Non sono state poche, né di poco conto, le occasioni in cui sono emerse, anche recentemente, divisioni e contrasti fra i sindacati; basta pensare alle firme mancanti nell’accordo sulla Didattica Digitale Integrata, o sullo stesso Patto per la scuola. Andando più indietro nel tempo, tra le più significative ricordo la rottura del 1984 sull’accordo per la modifica della scala mobile, sostenuto dalla CISL di Carniti e dalla UIL di Benvenuto e osteggiato dalla CGIL, o più esattamente dalla sua componente comunista (quella socialista era favorevole). Il percorso tracciato da quell’accordo sarà poi portato a compimento da quello del 1992 (sottoscritto anche dalla CGIL con grande personale travaglio di un suo prestigioso segretario, Bruno Trentin) e da quello del 1993, che avviano la stagione della concertazione sociale. In tempi più recenti si registrano le divisioni sul “Patto per l’Italia” del 2002, firmato solo da CISL e UIL, mentre dal 2008 al 2011, dopo il grande sciopero unitario della scuola del 30 ottobre 2008 (quasi 64% di adesioni), le azioni e le intese sindacali volte a recuperare il taglio degli scatti di anzianità e a ridurre l’entità del precariato vedono insieme tutte le sigle rappresentative, ma non la CGIL.
A conferma di come lo sciopero non sia un tabù, ricordo quello del 5 maggio 2015, che ci vide protagonisti insieme a tutte le altre sigle rappresentative, addirittura più riuscito di quello già ricordato del 2008, con una percentuale di adesioni vicinissima al 65%. Certo non è solo per questo, ma se negli anni successivi è stato possibile rimuovere la più rilevanti criticità della legge 107 lo si deve anche all’efficacia di uno sciopero così ben preparato e così ampiamente partecipato.
Il breve excursus che mi sono concessa punta, inutile negarlo, a rintuzzare qualche accusa che ci è stata rivolta (andando talvolta, a mio avviso, un po’ oltre misura), ma serve ancor più a giustificare l’ottimismo con cui, nonostante tutto, voglio guardare a una prospettiva di auspicabile ricucitura dei rapporti unitari.
Non va certo sottovalutata la distanza che passa tra modelli diversi di intendere e praticare l’azione sindacale, segnati dal prevalere di un approccio conflittuale e antagonista o al contrario, come nel nostro caso, dal primato riconosciuto alla contrattazione e al confronto fra le parti, specie in una fase storica dove si impone la massima coesione perché il Paese possa vincere le sfide straordinarie che ha di fronte. Si giocherà in gran parte su questo la possibilità di ricomposizione di un fronte unitario, magari a partire dagli esiti dell’incontro col Ministro in programma fra pochissimi giorni [sindacati convocati il 4 gennaio, n.d.r.].
Altro fattore che incide sulla possibilità di agire insieme, costituendone un presupposto fondamentale, è il riconoscimento reciproco di pari dignità fra le diverse organizzazioni. Nessuno detiene in esclusiva, fra i sindacati, un marchio di autenticità, come si potrebbe invece desumere dal modo in cui, non di rado, vien fatta informazione sulle vicende sindacali nel nostro Paese, con testate e commentatori che faticano a nascondere, nella distribuzione dei tempi e delle attenzioni, ben evidenti preferenze.
Auguri di cuore a tutti, perché il 2022 sia un anno migliore (ne abbiamo proprio bisogno!) e, se possibile, più attento ed equilibrato nel racconto dei fatti sindacali.
LA PAROLA DI QUESTO MESE
Motivazione
di Dino Cristanini

La parola motivazione echeggia spesso tanto nelle aule quanto nella letteratura scolastica, sia per attribuire agli studenti una elevata o scarsa motivazione, di solito correlata a più o meno soddisfacenti risultati nell’apprendimento, sia per sollecitare gli insegnanti a ideare e proporre esperienze di apprendimento coinvolgenti e motivanti.
Un costrutto complesso
Ma in cosa consiste esattamente la motivazione? Si tratta di un tema che nell’ultimo secolo è stato ampiamente esplorato dalla ricerca psicologica, per cercare di spiegare cosa attiva e orienta il comportamento umano verso determinati scopi.
Attualmente gli esiti di tali ricerche portano a considerare la motivazione come un costrutto complesso, spiegabile attraverso l’azione concomitante di diversi fattori che, interagendo in modo diverso nei vari soggetti, danno origine a differenti forme di motivazione.
Le teorie
Proviamo a passare rapidamente in rassegna le principali teorie e i fattori su cui ciascuna di esse focalizza l’attenzione, con riferimento all’apprendimento scolastico; si tratta di una precisazione necessaria, perché sarebbe assai diverso parlare di motivazione in relazione ad altri campi.
Le prime teorie, elaborate tra le fine dell’‘800 e l’inizio del ‘900, individuavano la fonte del comportamento umano in pressioni esercitate da forze innate, comprese nel patrimonio genetico, orientate a garantire la sopravvivenza. La motivazione all’apprendimento può ancora oggi essere considerata innata, ma diversa è quella riguardante l’apprendimento scolastico, i cui obiettivi non sono determinati da forze interne al soggetto.
Una evoluzione di queste concezioni è rappresentata dalla teoria del bisogno, secondo cui la motivazione nasce da un bisogno e attiva un comportamento diretto al raggiungimento di un obiettivo idoneo a soddisfare il bisogno stesso. I bisogni possono avere diversa natura (organica, affettiva, cognitiva, sociale), alcuni hanno una origine naturale e altri sono invece appresi. È famosa ad esempio la scala, o, meglio, la piramide di Maslow, che individua cinque tipi di bisogni (bisogni fisiologici; bisogno di sicurezza; bisogno di appartenenza; bisogno di stima, di riconoscimento; bisogno di autorealizzazione) classificati in modo gerarchico, nel senso che il bisogno del livello superiore agisce efficacemente da stimolo solo quando sono stati soddisfatti quelli dei livelli inferiori. La motivazione all’apprendimento scolastico, secondo questo punto di vista, dipende dalla misura in cui l’allievo percepisce che questo possa soddisfare i suoi bisogni.
La teoria del rinforzo, di matrice comportamentista, si basa sull’idea che vengono appresi e consolidati i comportamenti associati a premi e abbandonati quelli legati a feedback negativi. In campo scolastico i benefici derivanti dagli apprendimenti previsti dal curricolo sono piuttosto lontani e quindi non sempre costituiscono dei rinforzi efficaci, e si ricorre ad altri tipi di rinforzi, positivi e negativi, come ad esempio le valutazioni. È facile intuire il valore motivante delle valutazioni quando sono positive, purché non siano inflazionate e si riferiscano a effettive conquiste; è invece più problematico capire se e in quali condizioni le valutazioni negative possano agire da stimolo per migliorare. Continue valutazioni negative in genere producono frustrazione e demotivazione, e vanno quindi compensate con valutazioni di tipo proattivo, che riconoscono e valorizzano i successi e i progressi, anche piccoli, compiuti dallo studente, con indicazioni su come migliorare e manifestazioni di fiducia sul fatto che lo riteniamo capace di superare i problemi.
Le teorie di matrice cognitivista, più recenti, evidenziano il ruolo dell’attività mentale del soggetto nell’attivare la tensione verso determinati obiettivi, attribuendo significato alle situazioni e alle proprie scelte. Sotto questo profilo sono diversi i fattori da prendere in considerazione.
Iniziamo con il concetto di sé e con quelli correlati di autoefficacia e di autostima. L’autoefficacia è la percezione che un soggetto ha di essere capace di svolgere bene determinate azioni, di affrontare con successo certi tipi di compiti e di superare le eventuali difficoltà che possono presentarsi. Una percezione positiva delle proprie capacità alimenta le aspettative di successo e l’impegno nei confronti del compito, aumentando così le probabilità di ottenere buoni risultati che a loro volta rafforzano il senso di autoefficacia e la motivazione, generando un circolo virtuoso. A tal fine è importante proporre sfide ottimali, compiti nuovi ma affrontabili, che si collocano nella vygotskijana zona di sviluppo prossimale.
Il modo in cui un individuo sviluppa la percezione di autoefficacia dipende anche dal modo in cui spiega le cause dei propri successi e insuccessi. La teoria delle attribuzioni causali individua tre dimensioni alla base di queste spiegazioni: il locus of control (causa interne o esterne); la stabilità nel tempo (cause stabili o instabili); la controllabilità da parte del soggetto maggiore o minore). La motivazione è positivamente correlata con spiegazioni riferiti a cause interne controllabili (es. l’impegno) anziché a cause esterne non controllabili (es. la fortuna).
Infine l’autostima, ossia il giudizio che una persona elabora su stessa, attraverso il confronto con gli altri e i feedback che riceve da questi. Una elevata autostima corrisponde a una limitata discrepanza tra il sé reale e il sé ideale, e porta a considerare oggettivamente le proprie risorse e le possibilità di riuscita in un compito, anche impegnandosi a migliorare il sé reale. Una bassa autostima può portare a considerare solo i propri punti deboli e ad arrendersi facilmente.
Una distinzione importante è quella tra obiettivi di padronanza e obiettivi di prestazione, che porta a considerare in modo diverso il successo e l’insuccesso, e si connette a quella tra comportamenti di approccio e comportamenti di evitamento. Lo studente che persegue obiettivi di padronanza è interessato all’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze e in genere è disposto a considerare l’errore come una ulteriore occasione di impegno e di miglioramento. Lo studente orientato a obiettivi di prestazione è invece mosso dal desiderio di mostrare agli altri le proprie abilità e competenze e di ricevere il riconoscimento di queste; il timore del confronto e dell’insuccesso può portarli a comportamenti di evitamento delle situazioni percepite come minacciose. Il fenomeno dell’abbandono scolastico può per certi aspetti essere letto anche in tal senso.
Motivazione intrinseca ed estrinseca
Molti dei concetti sommariamente esposti possono essere ricondotti alle due grandi categorie della motivazione intrinseca e della motivazione estrinseca. La prima si riferisce al fare qualcosa per il piacere di farlo, ed è correlata a fattori come l’interesse, l’orientamento a obiettivi di padronanza, l’autodeterminazione e l’attribuzione causale interna e controllabile. La seconda è invece legata al desiderio di ottenere un premio, un riconoscimento, oppure di evitare situazioni spiacevoli. Nella realtà i due tipi di motivazione possono anche coesistere (ad es. impegnarsi nello studio per non deludere i genitori, ricevere un premio, ma anche per poter in futuro svolgere il lavoro desiderato). Inoltre, le motivazioni possono cambiare nel tempo, e una motivazione inizialmente estrinseca può in seguito trasformarsi in una motivazione intrinseca.
Orientarsi nella complessità
Data la numerosità delle variabili che entrano in gioco, e la loro diversa incidenza sia in relazione alle fasi dell’età evolutiva sia in relazione ai singoli individui, non è facile suscitare la motivazione e ancor meno facile è mantenerla nel tempo. Un criterio generale di azione per l’insegnante è quello di conoscere i vari fattori che concorrono a determinare la motivazione, osservare i propri allievi per cercare di capire qual è la loro situazione motivazionale e agire opportunamente sulle diverse variabili a seconda della situazione.
Alcuni fondamentali punti di attenzione possono comunque essere i seguenti:
- rendere, per quanto possibile, gli spazi scolastici accoglienti;
- creare un clima sociale positivo e inclusivo, capace di rispondere al bisogno di appartenenza;
- definire obiettivi chiari, sfidanti ma raggiungibili;
- adottare un approccio didattico di tipo attivo;
- far emergere le connessioni tra apprendimento scolastico e problemi della realtà;
- utilizzare la valutazione in funzione proattiva e formativa;
- cercare di sviluppare negli allievi l’empowerment, ossia un abito mentale caratterizzato da consapevolezza, fiducia nelle proprie possibilità, controllo delle proprie scelte.
Bibliogafia
P. Boscolo (2012), La fatica e il piacere di imparare. Psicologia della motivazione scolastica, UTET Università, Torino.
K. Wentzel (2021), Motivare gli studenti ad apprendere, UTET Università, Torino.
LA SCUOLA È VIVA. W LA SCUOLA
Recuperiamo la gentilezza perduta
Intervista di Lorenzo Fabiano al nostro collaboratore Lorenzo Gobbi

Una vita in punta dei piedi, ad osservare e ad ascoltare. Mica facile in un mondo che nella frenesia corre sempre più veloce, sa solo gridare e a fermarsi un attimo ad ascoltare proprio non ce la fa: «Quando uno urla, tu devi abbassare la voce, non c'è altro modo. lo scriverei un libro sul silenzio» confessa Lorenzo Gobbi, poeta, scrittore e filosofo. «Sono socievole, ma me ne sto un po' in disparte nel “desiderio di nulla profanare” – aggiunge –, accarezzare e non afferrare; l'amore disinteressato è l'unica cosa che davvero può cambiare la vita. Si tratta di ascoltare per capire e ritrovare la delicatezza smarrita in dimensioni di cordialità e gentilezza disinteressate (è il messaggio del suo ultimo lavoro, “Nicodemo a San Pietroburgo – Dostoevskij, due donne e la laicità della grazia”)» spiega. Classe 1966, nato a Bussolengo e cresciuto sulle Torricelle, ha dedicato più di metà della sua vita all'insegnamento, dividendosi tra scuola (insegna italiano e storia la Liceo Musicale Carlo Montanari), scrittura di saggi, narrativa, traduzioni, libri In versi illustrati per l'infanzia, nonché poesie. Nel 2011 l'Accademia Mondiale della Poesia dell'Unesco gli ha conferito il Premio Catullo.
Un uomo che il mondo lo osserva con il necessario distacco: «Ogni sera passeggio un paio d'ore per Verona, non mi stanco mai di contemplarla, ho un rapporto profondo e radicato con la città. Su Verona ho anche scritto molto» racconta mentre arpeggia con la chitarra, una Ramirez del 1977 dalla quale non si separa mai: «La musica è stata una grande campagna di vita. Insieme alla scrittura e alla lettura, mi ha nutrito anche in periodi difficili che ho attraversato» precisa. È il 1998, quando scrive «Il Lessico della Gioia», la sua opera Prima: «Nacque in un particolare momento di dolore della mia vita, per volontà di una giovane donna, Paola, allora la mia moglie che se ne stava andando per un tumore. Mi chiese di scriverle qualcosa sulla gioia. Nel 1999 – prosegue – mi scrisse una lettera una collega che aveva letto il libro e aveva saputo della morte di Paola; le telefonai, cominciammo a vederci e a frequentarci; diventammo profondamente amici condividendo passioni e ansie; Maddalena è oggi mia moglie e lavoriamo da tre anni nella stessa scuola». Così è la vita.
Lorenzo Gobbi e Maddalena Cavalleri hanno fondato Insieme un'associazione culturale, «Il Passero Blanco» (sciolta nel 2019), che si occupava di racconti in versi per i bambini. Insieme hanno tradotto e curato libri, uniti da uno spirito di condivisione fortissimo. Figlio di un noto psicologo, mancato durante la prima ondata della pandemia, e di un'insegnante, Lorenzo con le letture ha iniziato presto, «La Tempesta» di Shakespeare, alla fine delle scuole elementari; la poesia l'ha invece scoperta all'inizio del liceo classico grazie al libraio Alfredo Bonazzi in Piazza Erbe: «Il Liceo Maffei lo vivevo male. Lo sentivo arido. Nella sua libreria mi sentivo rinascere». Un giorno, prima di trasferirsi lontano da Verona, Bonazzi gli regala un tascabile, un'antologia di Emily Dickinson; «Ti aiuterà, con me l'ha fatto», gli dice: «Ne fui conquistato; la leggevo e la rileggevo, la tenevo nascosta sotto il sellino della mia Vespa 50 bianca. Spesso, d'estate, salivo sulle Torricelle e la leggevo osservando la città dall'alto, dal pianale di Castel San Pietro». A Emily Dickinson, Lorenzo Gobbi dedicherà tre lavori; il suo romanzo «Emily e il vento» si è classificato terzo al Premio Nabokov 2018 per la narrativa. Laureato in Lettere Classiche presso l'Università Cattolica di Milano, Lorenzo si sta attualmente formando come analista filosofo presso la Scuola in Analisi Biografica a Orientamento Filosofico «Philo» di Milano; si è profuso in un numero cospicuo pubblicazioni e collaborazioni con diverse riviste e case editrici; tuttavia, attualmente collabora stabilmente soltanto con «Scuola e formazione» di Cisl Scuola: «Curo una rubrica, “L’Anima e la Lim”; la Lavagna Interattiva Multimediale è il simbolo dell'innovazione della scuola: cerco di capire cosa succede nell'anima degli insegnanti». Dei suoi studenti dice: «Cerco di trattarli come vorrei che un insegnante trattasse un figlio mio. Il Covid è stato un colpo durissimo, la scuola è presenza e partecipazione. Sento delle vibrazioni di sofferenza e disagio. I ragazzi hanno bisogno di adulti che li guardino con stima. La scuola è per loro, prima che per noi. Questo è il vero spirito di servizio». E chi non lo vorrebbe un professore così...!
(Intervista di Lorenzo Fasoli a Lorenzo Gobbi, Corriere della Sera - Edizione del Veneto, 12 dicembre 2021)
HOMBRE VERTICAL
Missione n. 4: dipende da noi
di Emidio Pichelan

Dopo quarantatré anni di onorato servizio, per il docente di storia e filosofia prof. Pietro Carmina era suonata l’ultima campanella. Mentre i ragazzi sciamavano e in attesa del pullman, scriveva una lettera di saluto ai tantissimi alunni. Siete parte della mia vita, scriveva, mi sono preso cura di voi per quanto ho potuto e saputo, vi ho insegnato le parole giuste per conquistare la vita, aiutate chi non le ha, impegnatevi per migliorare il mondo. Ha preso e sconfitto il Covid-19, ma nulla ha potuto contro lo scoppio delle tubature del gas di Ravanusa, nell’agrigentino: 7 morti e 100 sfollati. La sua lettera corre gonfia di saggezza nella rete, a dimostrazione che la scuola c’è e ci sarà finché potrà contare su insegnanti che hanno più a cuore il percorso scolastico dei risultati.
Ha una vita piuttosto complicata e una vita sentimentale traballante il prof. Dante Balestra (serie televisiva “Un professore”), ma adempie al meglio il ruolo di insegnante: prendersi cura dei suoi allievi, specie di quelli che ne hanno più bisogno. Segue un suo ex allievo finito nel carcere minorile di Nisida; accorre per primo al capezzale di un suo allievo, vittima di una bevuta disordinata; scopre e incentiva il talento di Chicca, apparentemente l’alunna più demotivata allo studio e più disturbata dagli ormoni in subbuglio; convince a rientrare in classe un allievo che, bullizzato dai compagni, aveva deciso di murarsi nella sua cameretta; insegna camminando tra i banchi, in strada, nel maestoso catino del Colosseo. “Un professore” come tanti, la spina dorsale della scuola viva e del sistema scolastico reale.
Sappiamo troppo bene come, appesantito dai numerosi “buchi neri”, il sistema scolastico italiano non gira come dovrebbe, non dà i frutti sperati. E non per colpa del Covid-19. Ma nemmeno per colpa delle guerre puniche, come denunciato recentemente dal ministro della Transizione Ecologica. In un recente intervento pubblico, il ministro R. Cingolani, un fisico di formazione e dal pedigree prestigioso – insegnamenti in Italia, in Giappone, negli USA; direzione dell’IIT di Genova, Istituto Italiano di Tecnologia –, a ragione ha lamentato il nostro deficit culturale nei campi delle scienze e delle competenze linguistiche straniere, addebitandone la colpa alle guerre puniche. Insegnate più volte nei tredici anni del percorso formativo obbligatorio, a tutto danno delle scienze e delle lingue.
Il sistema scolastico nostrano ha molte cose da registrare, correggere, rifondare, rivedere. Ma non è un “disastro cognitivo”, come sostenuto recentemente da autori peraltro autorevoli, causato da responsabili dal voto noto: la legge 1859/62 (introduzione della scuola media unica), il 1968, don Milani di “Lettera a una professoressa”, un dichiarato e palese rifiuto del vecchio sistema. Un’analisi che, direbbe un mio vecchio amico scomparso troppi anni fa, confonde una doccia con un paracarro, le pere con le mele. I due sistemi – il gentiliano/selettivo/autoritario e il costituzionale - non sono comparabili perché radicalmente differenti negli obiettivi dichiarati, nella metodologia, nell’organizzazione del lavoro. In estrema sintesi, la Costituzione disegna un nuovo spazio-tempo del vivere civile: l’uguaglianza, la giustizia, la consapevolezza che il talento non è di classe e non è una variabile del censo.
Ma non siamo all’anno zero. Sul sistema scolastico scrive e interviene positivamente, con risorse e con progetti-obiettivi, la Missione 4 del PNRR, “Istruzione e ricerca”: l’analisi delle carenze del nostro sistema formativo (situazione edilizia, servizi all’infanzia, abbandono scolastico, offerta formativa, reclutamento e aggiornamento dei docenti, fuga dei diplomati e dei laureati verso altri lidi più attraenti - è seguita dall’allocazione delle risorse (30,8 miliardi dal Dispositivo per la ripresa e la resilienza, il PNRR, e 1 miliardo dal Piano complementare) e da proposte concrete di interventi, a iniziare dalla costruzione di nuovi edifici scolastici (un migliaio) all’altezza delle nuove esigenze di spazio e di agibilità, e continuando con il rilancio del tempo pieno – il modo migliore per dare il giusto valore alle guerre puniche, alle scienze, alla tecnologia e all’umanesimo. Tra parentesi, la scuola a tempo pieno era la scuola del priore di Barbiana.
Ovviamente, come sempre, tutto dipende da noi e dai tanti – è l’augurio di cuore – che credono nella scuola costituzionale. Come Mariapia Veladiano di “Oggi c’è scuola. Un pensiero per tornare, ricostruire, cambiare” (edizione Solferino, Milano 2021): 150 paginette di ricostituente per crederci e implementare il cambiamento.
*****
Questa la lettera scritta agli alunni della sua vita d'insegnante dal prof. Pietro Carmina nell'ultimo giorno di scuola prima della pensione.
Ai miei ragazzi, di ieri e di oggi
Ho appena chiuso il registro di classe. Per l’ultima volta. In attesa che la campanella liberatoria li faccia sciamare verso le vacanze, mi ritrovo a guardare i ragazzi che ho davanti. E, come in un fantasioso caleidoscopio, dietro i loro volti ne scopro altri, tantissimi, centinaia, tutti quelli che ho incontrato in questi ultimi miei 43 anni.
Di parecchi rammento tutto, anche i sorrisi, le battute, i gesti di disappunto, il modo di giustificarsi, di confidarsi, di comunicare gioie e dolori; di altri, molti in verità, solo il viso o il nome. Con alcuni persistono, vivi, rapporti amichevoli, ma il trascorrere del tempo e la lontananza hanno affievolito o interrotto, ahimè, quelli con tantissimi altri. Sono arrivato al capolinea e il magone più lancinante sta non tanto nell’essere iscritto di diritto al club degli anziani, quanto nel separarmi da questi ragazzi. A tutti credo di aver dato tutto quello che ho potuto, ma credo anche di aver ricevuto di più, molto di più. Vorrei salutarvi tutti quelli che incontro per la strada, quelli che mi siete amici, sui social e, tramite voi, anche tutti gli altri, tutti, ed abbracciarvi ovunque siate.
Vorrei che sapeste che una delle mie felicità consiste nel sentirmi ricordato; una mia gioia è sapervi affermati nella vita; una delle mie soddisfazioni, la coscienza e la consapevolezza di aver tentato di insegnarvi che la vita non è un gratta e vinci: la vita si abbranca, si azzanna, si conquista. Ho imparato qualcosa da ciascuno di voi, e da tutti la gioia di vivere, la vitalità, il dinamismo, l’entusiasmo, la voglia di lottare.
Gli anni del liceo, per quanto belli, non sono sempre felici né facili, specialmente quando avete dovuto fare i conti con un prof che certe mattine raggiungeva livelli eccelsi di scontrosità e asprezza, insomma … rompevo alla grande. Ma lo facevo di proposito, nel tentativo di spianarvi la strada evidenziandone ostacoli e difficoltà. Vi chiedo scusa se qualche volta non ho prestato il giusto ascolto, se non sono riuscito a stabilire la giusta empatia, se ho giudicato solo le apparenze, se ho deluso le aspettative, se ho dato più valore ai risultati e trascurato il percorso e i progressi, se, in una parola, non sono stato all’altezza delle vostre aspettative e non sono riuscito a farvi percepire che per me siete stati e siete importanti, perché avete costituito la mia seconda famiglia.
Un’ultima raccomandazione, mentre il mio pullman si sta fermando: usate le parole che vi ho insegnato per difendervi e per difendere chi quelle parole non le ha, non siate spettatori ma protagonisti della storia che vivete oggi: infilatevi dentro, sporcatevi le mani, mordete la vita, non “adattatevi”, impegnatevi, non rinunciate mai a perseguire le vostre mete, anche le più ambiziose, caricatevi sulle spalle chi non ce la fa: voi non siete il futuro, siete il presente.
Vi prego: non siate mai indifferenti, non abbiate paura di rischiare per non sbagliare, non state tutto il santo giorno a cazzeggiare con l’iPhone. Leggete, invece, viaggiate, siate curiosi (rammentate il coniglio del mondo di Sofia?). Io ho fatto, meglio, ho cercato di fare la mia parte, ora tocca a voi. Le nostre strade si dividono, ma ricordatevi che avete fatto parte del mio vissuto, della mia storia e, quindi, della mia vita. Per questo, anche ora che siete grandi, per un consiglio, una delusione, o semplicemente per una risata, un ricordo e un saluto, io ci sono e ci sarò. Sapete dove trovarmi.
Ecco, il pullman è arrivato.
Io mi fermo qui.
A voi, buon viaggio.
STORIA CONTEMPORANEA
1922-2022: il centenario della marcia su Roma
di Paolo Acanfora

Il 2022 sarà un anno ricco di anniversari dal notevole significato storico e dal forte valore simbolico. Dall'avvio dell'esperienza straordinaria dell'unificazione europea (il trattato istitutivo della prima comunità europea, la CECA, entrato in vigore il 25 luglio 1952) alla crisi più profonda e grave della Guerra fredda (la crisi di Cuba dell'ottobre del 1962), passando per un doppio cruciale trentennale: la “grande slavina” di Tangentopoli (il 17 febbraio 1992 venne arrestato a Milano il socialista Mario Chiesa e prese avvio la più rilevante indagine della magistratura sulla corruzione politica in Italia) e la nascita dell'Unione europea, con l'entrata in vigore del trattato di Maastricht. Ma non sarà su questi pur rilevantissimi avvenimenti che si concentrerà l'attenzione di questa rubrica.
C'è un altro anniversario, un centenario per l'esattezza, che farà da bussola durante l'anno: il 28 ottobre del 1922, i fascisti misero in atto il proprio progetto insurrezionale marciando su Roma. Partita sin dal giorno precedente in diverse zone d'Italia, la mobilitazione fascista mirava, attraverso l'uso della violenza politica, alla soluzione della crisi dello Stato liberale e della società italiana del primo dopoguerra. Il governo in carica, guidato dal piemontese Luigi Facta, inizialmente tentennante (anche di fronte alle molte segnalazioni e agli allarmi che venivano dalle prefetture), optò nelle prime ore della mattina del 28 per la richiesta dello stato d'assedio. Recatosi a colloquio da Vittorio Emanuele III per ottenerne la firma, si vide rifiutare irremovibilmente questa soluzione – nonostante nelle ore precedenti sembrava fosse questo l'orientamento del Re.
La Marcia su Roma divenne così l'inizio simbolico di una nuova stagione della storia italiana. Considerato l'avvio della rivoluzione fascista, l'evento ha rappresentato in quell'immaginario politico il momento fondativo di una nuova civiltà che avrebbe realizzato un nuovo Stato, una nuova società, un “uomo nuovo”. Similmente alla rivoluzione francese del 1789, a quella marxista-leninista nella Russia del 1917, la rivoluzione fascista avrebbe dovuto aprire la strada ad una nuova era nella storia dell'umanità.
Ora, questo anniversario non sarà naturalmente di tipo celebrativo (se non, va da sé, per i vari gruppuscoli nostalgici più o meno apertamente neofascisti) ma avrà comunque – o almeno questa è la speranza – un profondo significato civile. Non solo per l'ovvia ragione che conoscere il proprio passato è una condizione imprescindibile per comprendere adeguatamente il presente – tanto più quando si tratta di una pagina cruciale della nostra storia contemporanea – ma ancor di più perché il tema è tornato, nostro malgrado, in auge. Sentiamo quotidianamente parlare di fascismo e antifascismo, di azioni squadriste, di razzismo ed antisemitismo, spesso mettendo assieme cose diverse, con notevole confusione.
Senza volersi rinchiudere negli spazi angusti riservati agli specialisti degli studi e della ricerca storica, mi pare inequivocabile l'esigenza “civile” di fare chiarezza sulle categorie che si utilizzano per comprendere e descrivere la realtà. Non è una questione di lana caprina ma di un corretto utilizzo della “cassetta degli attrezzi” che qualsiasi analista si trova ad adoperare e che deve saper adoperare in modo adeguato. Un uso sbagliato o largamente approssimativo del linguaggio e dei concetti – è banale dirlo – può creare confusione e indurre a valutazioni improprie sulla realtà che osserviamo e viviamo. In una società complessa come la nostra, questa attenzione è un vero e proprio imperativo. Per intenderci, se utilizziamo la parola “fascista” per descrivere di volta in volta quel che giudichiamo antidemocratico, antiparlamentare, repressivo, autoritario – fino a metterci dentro, in ultima istanza, tutto ciò che non ci piace – non stiamo rendendo un buon servizio alla comprensione della realtà. Così come, allo stesso modo, glissare continuamente sulle responsabilità storiche del regime fascista, sui suoi caratteri totalitari, banalizzando il peso ed il significato di quella esperienza, penalizza la consapevolezza che un popolo deve avere del proprio passato, ne manipola la memoria storica attraverso rappresentazioni falsate, distorte, incomprensive.
È drammatico osservare quanto poco dei risultati della ricerca storica sia arrivato all'opinione pubblica e, di conseguenza, quanta scarsa consapevolezza si abbia di processi storici che pure hanno segnato così in profondità la nostra storia recente. Il grande storico francese Marc Bloch, nel suo capolavoro “Apologia della storia”, scriveva retoricamente con riferimento agli eventi della rivoluzione francese: “Robespierristi, antiroberspierristi, noi vi chiediamo grazia: per pietà, diteci, semplicemente, chi fu Robespierre”. In questa rubrica mensile si farà, appunto, un tentativo in questa direzione, così da contribuire a diradare un poco quella nebbia che ancora circonda il fenomeno fascista, in modo da provare a capire qualcosa di più sulla nostra politica, la nostra democrazia, le nostre istituzioni, la nostra società attuale.
UN AUTORE
FRANCO ARMINIO
"Aperti al soffio di ogni cosa"
di Leonarda Tola

“Ho sessant’anni e lavoro quotidianamente da oltre quarant’anni facendo di me stesso una perenne officina. Non spetta a me indicare il valore dei miei libri. Certo posso dire di averne scritti tanti, sempre un poco fuori dalle forme tradizionali. Posso dire di essere continuamente proteso a dare forma alla moltitudine che mi abita. Ci vorranno molti anni per capire se ho scritto pagine necessarie e durature. Io intanto cerco ancora, non mi fermo, non mi fermo neppure per un’ora, faccio carriera nella mia stanchezza, scrivo a oltranza, come se volessi sfondare il muro della mia fronte, come se volessi vedere un osso che nessuno ha mai visto”.
Risponde così Franco Arminio a chi gli domanda di fare un bilancio di sé e della sua opera letteraria. Ma chi è Franco Arminio? Maestro, scrittore, poeta e personaggio ignoto o poco noto solo ai non frequentatori della rete e dei social dove invece è una presenza molto seguita. Conosciuto come “paesologo”, da Bisaccia dove vive tra Campania e Puglia, meno di quattromila abitanti, senza posa si sposta a divulgare il suo sentimento di appartenenza all’Italia delle aree interne a rischio di spopolamento. La sua testimonianza di uomo di scrittura, almeno 20 libri e migliaia di copie vendute, soprattutto poesia ma anche prosa (poetica), è infatti messa al servizio di un instancabile impegno per contrastare la facile profezia della condanna all’abbandono e all’estinzione delle esangui comunità che ancora sopravvivono nei borghi e nei piccoli paesi della penisola.
Voglio bene ai paesi.
Voglio bene a quelle case sgraziate
che ti accolgono alla periferia.
Voglio bene ai paesi e a quella panchina
davanti alla chiesa e a quel cane
che rovista in una busta vuota.
Voglio bene ai paesi quando c’è un funerale,
voglio bene a chi si toglie il cappello,
a chi abbassa lo sguardo.
Voglio bene ai paesi e a tutta la terra
che hanno intorno, al grano che cresce
sulle frane.
(Resteranno i canti, Bompiani 2014)
Poesia dei luoghi ultimi e scartati. Il genere letterario è dare voce all’anima che si scopre sguarnita e in miseria, si dibatte tra le doglie fino a quando non fiorisce il prodigio della parola poetica, quella e quella soltanto, che sola può rivestire di luce i campi coltivati dell’intuizione e della bellezza che accende i vicoli dei remoti paesi. Cercare la parola che corrisponda al sommovimento dei pensieri e degli affetti è la pena del poeta che, trovatala, si muta in gloria. Per Arminio: “…questa contentezza/che mi visita ogni tanto e poi va via./Chiamatela poesia”. Una ‘felicità raggiunta’ attraverso la passione per la lingua, com’è di ogni scrittura. L’impegno civile e politico di Franco Arminio mira a restituire vita e futuro all’Italia povera dei paesi: “Non si tratta di smantellare le città, si tratta di lasciarle lentamente defluire verso i paesi, così come i paesi sono defluiti verso le città. Questa operazione è inevitabile”, dice nell’atto di fede appassionata di chi sogna il prodigio del Sud italiano da affidare ai giovani (“Lettera ai ragazzi del Sud” dal libro “Cedi la strada agli alberi” Chiarelettere 2017).
Tuttavia quel che è proprio del poeta Arminio non è l’ansia di una lotta, per quanto civilissima. Il molto che resta di una originale scrittura tra poesia e prosa è la sua concezione delle cose, la visione del mondo intesa come modalità di guardare: è infatti agli occhi, allo sguardo che nei suoi versi è dato il potere di una conoscenza intima vicina all’unione carnale.
Quando nessun essere umano ti cerca
accarezza un albero,
bevi a una fontana,
guarda le cose che stanno nel mondo
come se il tuo sguardo potesse salvarle.
Esci, cammina,
ricordati che prima di morire
puoi fare cose impossibili,
impensate.
Sono tornati i miracoli.
(“I miracoli” dal libro La cura dello sguardo. Nuova farmacia poetica, Bompiani 2021)
È una potente istigazione ad uscire dall’isolamento autoreferenziale, dalla timidezza, dalla refrattarietà per mettersi in contatto anche fisico con le cose che non aspettano altro che essere guardate da vicino e dentro. È la restituzione dell’attenzione affettuosa e fraterna che si deve ad ogni cosa che c’è, nel luogo e nell’istante in cui c’è. Un’apertura dello sguardo che è libertà dall’ossessione d’essere troppo spesso noi stessi, corpo e imperfezioni, il bersaglio dei nostri sguardi impietosi.
“Concedetevi una vacanza
Intorno a un filo d’erba,
dove non c’è troppo di ogni cosa,
dove il poco ancora ti festeggia
con il pane e la luce,
con la muta lussuria di una rosa”
(Cedi la strada agli alberi, Chiarelettere 2017)
Ritorna alla mente la novella di Pirandello “Canta l’Epistola”. Tommasino Unzio, ex seminarista oppresso dalla “vanità d’ ogni cosa”, s’innamora di un filo d’erba che vede crescere “tra due macigni grigi tigrati di mosco” e ogni giorno va a prendersene cura. Di lì si ferma una signorina che “distrattamente, allungando la mano”, strappa il filo d’erba e se lo mette tra i denti. “Tommasino s’era sentito strappar l’anima e irresistibilmente le aveva gridato: - Stupida!” Sfidato a duello dal fidanzato, in punto di morte confessa di morire “per un filo d’erba”.
Un’evocazione, un’analogia con i versi splendidi di Arminio che compendia la scoperta della felicità nella festa che si può ancora fare con il poco che è tutto: il pane, la luce, la rosa. E il filo d’erba.
Lettera ai ragazzi del Sud
Cari ragazzi,
abitate da poco una terra antica,
dipinta con le tibie di albe greche,
col sangue di chi è morto in Russia, in Albania.
Avete dentro il sangue il freddo delle navi
che andavano in America,
le grigie mattine svizzere dentro le baracche.
Era la terra dei cafoni e dei galantuomini,
coppole e mantelle nere,
era il Sud dell’osso, era un uovo, un pugno di farina,
un pezzo di lardo.
Ora è una scena dissanguata,
ora ognuno è fabbro della sua solitudine
e per stare in compagnia si è costretti a bere
nelle crepe che si sono aperte tra una strada e l’altra,
tra una faccia e l’altra.
Tutto è spaccato, squarciato, separato.
Sentiamo l’indifferenza degli altri
e l’inimicizia di noi stessi.
Uscite, contestate con durezza
i ladri del vostro futuro:
sono qui e a Milano e a Francoforte,
guardateli bene e fategli sentire il vostro disprezzo.
Siate dolci con i deboli, feroci con i potenti.
Uscite e ammirate i vostri paesaggi,
prendetevi le albe, non solo il far tardi.
Vivere è un mestiere difficile a tutte le età,
ma voi siete in un punto del mondo
in cui il dolore più facilmente si fa arte,
e allora suonate, cantate, scrivete, fotografate.
Non lo fate per darvi arie creative,
fatelo perché siete la prua del mondo: d
avanti a voi non c’è nessuno.
Il Sud italiano è un inganno e un prodigio.
Lasciate gli inganni ai mestieranti della vita piccola.
Pensate che la vita è colossale.
Siate i ragazzi e le ragazze del prodigio.
Franco Arminio: “Cedi la strada agli alberi”, Chiarelettere
AUTOBIOGRAFIE SCOLASTICHE
Albert Camus
di Mario Bertin
Il 4 gennaio 1960 Albert Camus moriva, a 47 anni, in un incidente d’auto. Tra i rottami della sua macchina fu rinvenuta una borsa che custodiva il manoscritto incompiuto dell’opera a cui stava lavorando in quel momento. Si trattava del racconto autobiografico intitolato Il primo uomo, in cui l’autore ricostruisce la storia della sua giovinezza come la storia di un uomo che si fa da solo con l’unico aiuto dei suoi due maestri: Louis Germain e Jean Grenier. Louis Germain nel periodo della scuola primaria e Jean Grenier durante il liceo. Due rapporti che durarono una vita all’insegna di una profonda amicizia. Tanto che soltanto queste due persone compaiono nel libro con il loro vero nome. Mentre lo stesso autore vi è presente con lo pseudonimo di Jacques.
Con riferimento ad essi, Camus dichiarò: “Parlerò di quelli che amavo e di nient’altro”. In proposito, vale qui la pena di citare per esteso una lettera che Camus scrisse a Louis Germain nel mese di novembre 1957, l’indomani del Premio Nobel che gli era stato assegnato:
“Caro signor Germain, ho aspettato che si spegnesse il baccano che mi ha circondato in tutti questi giorni, prima di venire a parlarle con tutto il cuore. Mi hanno fatto un onore davvero troppo grande, che non ho né cercato né sollecitato. Ma quando mi è giunta la notizia, il primo pensiero, dopo che per mia madre, è stato per lei. Senza di lei, senza quella mano affettuosa che lei tese a quel bambino povero che io ero, senza il suo insegnamento e il suo esempio, non ci sarebbe stato nulla di tutto questo. Non sopravvaluto questo genere d’onore. Ma è almeno l’occasione per dirle che cosa lei è stato, e continua a essere, per me, e per assicurarle che i suoi sforzi, il suo lavoro e la generosità che lei ci metteva sono sempre vivi in uno dei suoi scolaretti che, nonostante l’età, non ha cessato di essere il suo riconoscente allievo. L’abbraccio con tutte le mie forze.
Albert Camus”
Quanto al rapporto con Jean Grenier, basti ricordare quello che il raffinato intellettuale, divenuto poi docente alla Sorbona, dichiarò in margine ad un ritratto che egli traccia del suo alunno e amico scrittore: “Queste pagine portano semplicemente una breve testimonianza che nasce dalla vita quotidiana, quando non ci si interroga e non si viene interrogati, e si cammina insieme”.
Nel segno dell’amicizia
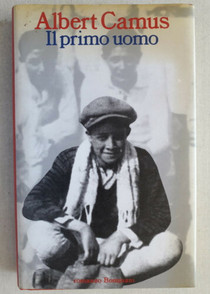
Il signor Bernard, suo maestro nel corso per la licenza media, aveva fatto valere in un certo momento tutto il suo peso di uomo per modificare il destino di questo ragazzo che gli era stato affidato, e di fatto era riuscito a modificarlo.
[…]
Col signor Bernard, le lezioni erano sempre interessanti, per la semplice ragione che lui amava appassionatamente il suo mestiere. Fuori il sole poteva strepitare contro i muri rossicci, e il caldo infuriare persino nell’aula, anche se immersa nell’ombra dalle tende a larghe strisce gialle e bianche. E poteva anche cadere la pioggia, come fa in Algeria, in cateratte interminabili, trasformando la strada in un pozzo buio e umido; la scolaresca si distraeva appena. Solo le mosche, all'avvicinarsi di un temporale, sviavano a volte l'attenzione. Venivano catturate e finivano ad attendere una morte lunga e orribile in quella melma violetta che riempiva i piccoli calamai di porcellana a forma di tronco di cono che erano stati infilati nei fori dei banchi. Ma il metodo del signor Bernard, che consisteva nel non concedere nulla in fatto di disciplina ma di rendere vivo e divertente l'insegnamento, trionfava anche sulle mosche. Al momento giusto sapeva sempre estrarre dal suo armadio dei tesori la collezione di minerali, l'erbario, le farfalle e gli insetti imbalsamati, le cartine o ... che risvegliavano l'interesse scemante degli allievi. In tutta la scuola era il solo che avesse ottenuto una lanterna magica e, due volte al mese, faceva proiezioni su argomenti di storia naturale o di geografia. In aritmetica, aveva inventato gare di calcolo mentale, che abituavano i ragazzi alla prontezza di spirito. Proponeva loro, che dovevano stare tutti con le braccia incrociate, i dati di una moltiplicazione, di una divisione o, a volte, di un'addizione un po' complicata. Quanto fa 1267 + 691. Al primo che dava la risposta giusta veniva attribuito un punto che sarebbe contato per lo scrutinio mensile. Per il resto utilizzava i manuali con competenza e precisione... I manuali erano quelli in uso anche nella Francia metropolitana. E quei ragazzi che conoscevano soltanto lo scirocco, la polvere, gli acquazzoni brevi e violenti, la sabbia delle spiagge e il mare infocato sotto il sole, leggevano con impegno, e facendo sentire bene i punti e le virgole, racconti, per loro mitici, in cui bambini con berretti e sciarpe di lana, e gli zoccoli ai piedi, tornavano a casa in un freddo gelido trascinando fascine su sentieri coperti di neve, finché non scorgevano il tetto innevato della casa, con il camino fumante ad annunciare che sul fuoco stava cuocendo la minestra di piselli. Per Jacques questi racconti erano puro esotismo. Li sognava, popolava i suoi temi di descrizioni di mondo che non aveva mai visto e non smetteva mai d'interrogare la nonna su una nevicata, che vent'anni prima era caduta per un'ora sulla regione di Algeri.
[…]
No, la scuola non offriva soltanto un'evasione dalla vita in famiglia. Almeno nella classe del signor Bernard, appagava una sete ancor più essenziale per il ragazzo che per l'adulto, la sete della scoperta. Certo, anche nelle altre classi si insegnavano molte cose, ma un po' come s'ingozzavano le oche. Si presentava un cibo preconfezionato e s'invitavano i ragazzi a inghiottirlo. Nella classe del signor Germain, per la prima volta in vita loro, sentivano invece di esistere e di essere oggetto della più alta considerazione: li si giudicava degni di scoprire il mondo. E anche il maestro non si occupava soltanto di insegnare ciò per cui era pagato, ma li accoglieva con semplicità nella sua vita personale, la viveva con loro, raccontava la propria storia e quella di altri ragazzi che aveva conosciuto, esponeva i propri punti di vista, ma non le proprie idee, perché, per esempio, pur essendo anticlericale come molti colleghi, in aula non diceva mai nulla contro la religione, né contro qualsiasi cosa che potesse essere oggetto di una scelta o di una convinzione, pur condannando con estrema energia ciò che non ammetteva discussioni, il furto, la delazione, la scorrettezza, la disonestà.
Ma, soprattutto, parlava della guerra, ancora recentissima, che aveva fatto per quattro anni, e delle sofferenze dei soldati, del loro coraggio, della loro pazienza e della gioia dell'armistizio. Al termine di ogni trimestre, prima di mandarli in vacanza, e ogni tanto, quando l'orario glielo permetteva, aveva l'abitudine di leggere lunghi brani delle Croix de bois di Dorgelès. Per Jacques anche queste letture aprivano le porte dell'esotismo, ma di un esotismo nel quale si annidavano paura e sventura, benché non gli richiamassero mai alla mente, se non in maniera astratta, quel padre che non aveva conosciuto. Si limitava ad ascoltare con tutto il cuore una storia che il maestro leggeva con tutto il cuore, e che gli parlava di nuovo della neve e del suo amato inverno, ma anche di uomini singolari, vestiti di stoffe pesanti irrigidite dal fango, che si esprimevano in una lingua bizzarra e vivevano in buche sotto un soffitto di granate, di razzi e di pallottole. Lui e Pierre [amico di Jacques] aspettavano queste letture con un'impazienza sempre maggiore.
[…]
“Aspetta, piccolo,” disse il signor Bernard. Si alzò a fatica e passò l'unghia dell'indice sulle sbarre della gabbia del canarino, che prese a pigolare con quanto fiato aveva in gola. “Oh, Casimir, abbiamo fame, abbiamo bisogno del babbo”, e si spostò verso il piccolo scrittoio da scolaro che era in fondo alla stanza, vicino al caminetto. Frugò in un cassetto, lo richiuse, ne aprì un altro. “Prendi,” disse, “è per te.” Jacques ricevette un libro avvolto in carta bruna da droghiere e senza dedica. Prima ancora d'aprirlo, sapeva che doveva essere Les croix de bois, la stessa copia su cui il signor Bernard faceva le sue letture in classe. “No, no,” disse, “è...” Voleva dire: “È troppo bello.” Ma non trovava le parole. Il signor Bernard scuoteva il vecchio capo. “L'ultimo giorno avevi pianto, te ne ricordi? Da allora questo libro ti appartiene.” E si voltò per nascondere gli occhi improvvisamente arrossati, Tornò ad avvicinarsi allo scrittoio, poi, con le mani dietro la schiena, si riaccostò a Jacques e, brandendogli sotto il naso un solido righello rosso, gli disse ridendo: “Ti ricordi dello zucchero d'orzo?” “Ah, signor Bernard,” disse Jacques, “vedo che lo ha conservato. Lei sa che adesso è proibito.” “Puah, era proibito anche allora. Ma tu puoi testimoniare che me ne servivo.” Jacques poteva testimoniarlo, poiché il signor Bernard era favorevole ai castighi corporali. È vero che di solito la punizione consisteva in punti negativi, da scontare alla fine del mese su quelli acquisiti dall'allievo, che scendeva così nella graduatoria generale. Ma, nei casi gravi, non gli veniva neanche in mente, come facevano spesso i suoi colleghi, di mandare il contravventore in direzione. Operava di persona, secondo un rito immutabile. “Mio povero Robert,” diceva con calma e senza perdere il buonumore, “bisognerà passare allo zucchero d'orzo.” Nessuno degli allievi reagiva (se non per ridere sotto i baffi, secondo l'eterna regola del cuore umano che vuole che la punizione degli uni sia percepita dagli altri come un godimento). Il ragazzo si alzava, pallidissimo, ma cercando in genere di fare buon viso a cattivo gioco (alcuni avanzavano dal banco già inghiottendo le lacrime e si avvicinavano alla cattedra, accanto alla quale, e davanti alla lavagna, li aspettava il signor Bernard). E, sempre secondo il rito, che comportava a questo punto un pizzico di sadismo, Robert o Joseph andava a prendere personalmente sulla cattedra lo “zucchero d'orzo” per consegnarlo al fustigatore.
Lo zucchero d'orzo era un grosso righello di legno rosso, macchiato d'inchiostro e deformato da tacche e incisioni, che il signor Bernard aveva confiscato molto tempo prima a un allievo ormai dimenticato; il reprobo lo porgeva al maestro, che lo riceveva di solito con aria beffarda e allargava le gambe. A questo punto, il ragazzo doveva mettere la testa fra le ginocchia del maestro, che la teneva ferma stringendo le cosce. E sulle natiche così offerte, faceva allora cadere, a seconda dell'infrazione, un numero variabile di colpi di righello, equamente ripartiti fra una natica e l'altra. Le reazioni a questa punizione differivano da un allievo all'altro. Alcuni gemevano prima ancora di essere colpiti, e il signor Bernard, impassibile, faceva loro notare che erano in anticipo, altri si proteggevano ingenuamente le natiche con le mani, che il maestro allontanava con un colpo svogliato. Altri ancora, sotto il bruciore dei colpi di righello, scalciavano frenetici. C'erano infine quelli che, come Jacques, subivano la punizione fremendo, ma senza una parola, e tornavano al proprio posto inghiottendo grosse lacrime. Nell'insieme, comunque, questo castigo era accettato senza amarezza, prima di tutto perché quasi tutti quei ragazzi venivano picchiati anche a casa propria e consideravano quindi la punizione corporale un metodo educativo normalissimo, poi perché l'equità del maestro era assoluta, e perché si sapeva in anticipo quale genere d'infrazioni, sempre le stesse, provocasse la cerimonia espiatoria, e chi varcava il limite delle azioni punite soltanto con punti negativi sapeva ciò che rischiava, e infine perché la sentenza veniva applicata ai primi come agli ultimi con calorosa equanimità. Jacques, al quale il signor Bernard voleva palesemente molto bene, subiva il castigo come gli altri, e dovette subirlo persino l'indomani del giorno in cui il maestro gli aveva manifestato davanti a tutti la propria preferenza. Mentre lui era alla lavagna e, in seguito a una sua buona risposta, il signor Bernard gli aveva accarezzato una guancia, una voce nell'aula aveva bisbigliato: “Il suo cocco.” Allora il maestro lo aveva stretto a sé e aveva detto, con una certa solennità: “Sì, ho una preferenza per Cormery, come per tutti quelli di voi che hanno perso il padre in guerra. Io, che ho fatto la guerra con loro padri, sono ancora vivo. E cerco di sostituire almeno qui i miei compagni morti. Ora, se qualcuno vuol dire che ho i miei ‘cocchi’, parli pure.” La predica fu accolta da un silenzio totale. All'uscita, Jacques domandò chi gli avesse dato del “cocco”. Accettare un simile insulto senza reagire significava infatti perdere l'onore. “Io,” disse Munoz, un ragazzone biondo, piuttosto flaccido e incolore che manifestava di rado ciò che pensava, ma aveva sempre mostrato per Jacques una certa antipatia. “Bene,” disse Jacques. “E allora merda a tua madre.” Era questa un'ingiuria rituale che comportava immediatamente uno scontro, poiché sulle rive del Mediterraneo l'insulto alla madre e ai morti era da tempo immemorabile il più atroce.
[…]
L'anno scolastico volgeva alla fine, e il signor Bernard aveva convocato Jacques, Pierre, Fleury, una specie di fenomeno bravo in tutte le materie, “una testa da politecnico», diceva il maestro, e Santiago, un bel ragazzo che aveva meno capacità naturali, ma riusciva altrettanto bene a forza d'applicazione: “Si tratta di questo,” disse il signor Bernard, quando l'aula rimase vuota, “Voi siete i miei allievi migliori. Ho deciso di presentarvi al concorso per le borse di studio per i licei e gli istituti superiori, Se lo supererete, potrete continuare gli studi sino alla maturità. La scuola elementare è la migliore delle scuole. Ma non vi porterà a niente. Il liceo vi apre invece tutte le porte. E preferisco che da quelle porte entrino ragazzi poveri come voi. Ma per questo mi occorre l'autorizzazione dei vostri genitori. Andate.”
Corsero via, interdetti, e si separarono senza nemmeno consultarsi. Jacques trovò la nonna in sala da pranzo, occupata a mondar lenticchie sulla tela cerata del tavolo. Esitò un momento, poi decise d'aspettare il rientro di sua madre, Che arrivò, visibilmente stanca, si mise un grembiule e venne ad aiutare la nonna. Jacques si offrì di dare una mano, e gli diedero il piatto di porcellana bianca sul quale era più facile separare le lenticchie dai loro granuli. Diede la notizia con il naso sul piatto, “Che cos'è questa storia?” disse la nonna. “A che età si farebbero gli esami?” “Fra sei anni,” disse Jacques. La nonna allontanò il suo piatto. “Hai sentito?” disse a Catherine Cormery. Lei non aveva sentito. Jacques ripeté lentamente la notizia, “Ah,” disse lei, “è perché sei intelligente.” “Intelligente o no, si doveva metterlo a bottega l'anno prossimo. Sai benissimo che non abbiamo soldi. Porterà a casa la sua settimana.” “È vero,” disse Catherine.
Fuori la luce e il caldo cominciavano a diminuire. A quell'ora le fabbriche lavoravano ancora a pieno regime e il quartiere era deserto e silenzioso. Jacques guardava la strada. Non sapeva quel che voleva, voleva solo obbedire al signor Bernard. Ma, a nove anni, non poteva e non sapeva disobbedire alla nonna. Che tuttavia esitava, visibilmente. “Che cosa faresti dopo?” “Non so, forse il maestro, come il signor Bernard.” “Sì, tra sei anni!” Ora lei stava mondando lenticchie più lentamente. “Ah,” disse, “ma siamo troppo poveri. Dirai al signor Bernard che non possiamo.”
L'indomani, gli altri tre annunciarono a Jacques che le loro famiglie avevano accettato. “E tu?” “Non so,” disse lui, e il sentirsi ancora più povero dei suoi amici gli stringeva il cuore. Dopo la lezione, si fermarono tutti e quattro. Pierre, Fleury e Santiago diedero le loro risposte. “E tu, moscerino?” “Non so.” Il signor Bernard lo guardava. “Bene,” disse agli altri. “Ma la sera dovrete lavorare con me dopo le lezioni. Me ne occuperò io, potete andare,” Quando furono usciti, il signor Bernard si sedette sulla sua poltrona e si attirò accanto Jacques. “E allora?” “Mia nonna dice che siamo troppo poveri e che l'anno prossimo bisogna che io vada a lavorare,” “E tua madre?” “È mia nonna che comanda.” “Lo so,” disse il signor Bernard. Rifletté, poi prese Jacques tra le braccia. “Senti, bisogna capirla. La vita è difficile per lei. Loro due vi hanno tirato su, te e tuo fratello, e hanno fatto di voi quei bravi ragazzi che siete. E adesso ha paura, per forza. Nonostante la borsa di studio, dovranno aiutarti ancora un po', e comunque per sei anni non porterai soldi a casa. Capisci?” Jacques scosse il capo dal basso in alto senza guardare il maestro. “Bene. Ma forse glielo si può spiegare. Prendi la cartella, io vengo con te!” “A casa mia?” disse Jacques. “Sì, certo, sarà un piacere rivedere tua madre.”
Pochi minuti dopo, il signor Bernard, sotto lo sguardo interdetto di Jacques, bussava alla porta della sua casa. La nonna venne ad aprire asciugandosi le mani con il grembiule, che con la sua cintura troppo stretta ne metteva in risalto il ventre di vecchia. Quando vide il maestro, si portò una mano ai capelli, per darsi una ravviata. “Allora, nonnina,” disse il signor Bernard, “al lavoro come al solito? Lei è davvero ammirevole.” La nonna fece entrare il visitatore nella camera da letto, che era necessario attraversare per arrivare in sala da pranzo, lo invitò ad accomodarsi al tavolo e tirò fuori i bicchieri e una bottiglia di anisetta, “Non si disturbi, sono qui per chiacchierare un po' con lei.” Cominciò interrogandola sui suoi figli, poi sulla sua vita alla fattoria, su suo marito, e le parlò dei propri figli. In quel momento entrò Catherine Cormery, che si agitò, chiamò il signor Bernard “Signor maestro” e corse in camera sua a pettinarsi e a mettersi un grembiule pulito, prima di sistemarsi su una sedia un po' discosta dal tavolo. “Tu,” disse il signor Bernard a Jacques, “va' a vedere in strada se io sono lì. Capisce,” disse alla nonna, “devo parlar bene di lui ed è capacissimo di credere che sia la verità...” Jacques uscì, scese la scala di corsa e si appostò davanti al portone. Era ancora lì un'ora dopo, e la strada cominciava ad animarsi e il cielo, attraverso i ficus, a colorarsi di verde, quando il signor Bernard sbucò dalla scala materializzandosi alle sue spalle. Gli grattò la testa. “Bene,” disse, “ci siamo messi d'accordo. Tua nonna è una brava donna. E in quanto a tua madre... Ah, non dimenticarla mai.” “Signore,” disse all'improvviso la nonna, comparendo dal corridoio, Aveva un grembiule in mano e si stava asciugando gli occhi. “Ho dimenticato... Lei mi ha detto che darà lezioni supplementari a Jacques.” “Certo,” disse il signor Bernard, “E non avrà da divertirsi.” “Ma noi non possiamo pagarle,” Il signor Bernard la guardò con attenzione. Teneva Jacques per le spalle, “Non si preoccupi”, e, scuotendo il ragazzo: “Mi ha già pagato lui,” Si allontanò subito, e la nonna prese Jacques per mano per risalire all'appartamento, e per la prima volta gliela strinse molto forte, con una sorta di tenerezza disperata. “Piccolo mio,” diceva, “piccolo mio.”
Per un mese, dopo la scuola, il signor Bernard tenne ogni giorno i quattro ragazzi a farli lavorare per due ore. Jacques tornava a casa la sera, stanco e insieme eccitato, e si metteva a farei compiti. La nonna lo guardava con un misto di tristezza e d'orgoglio.
[…]
“È andato tutto bene,” disse il signor Bernard, “E adesso al lavoro.” Ancora qualche giorno di dure fatiche, con le ultime lezioni nella casa dello stesso signor Bernard, e una mattina, alla fermata del tram vicino alla casa di Jacques, i quattro allievi, muniti di un sottomano, di un righello e di un portapenne, se ne stavano raccolti intorno al signor Germain, e Jacques vedeva la madre e la nonna che, affacciate al balcone, gli facevano grandi segni di saluto.
Il liceo dove si svolgevano gli esami era esattamente dall'altra parte della città, all'estremo opposto di quell'arco di circonferenza che Algeri descriveva intorno al golfo, in un quartiere un tempo tetro e opulento, ma divenuto in seguito, grazie all'immigrazione spagnola, uno dei più popolari e dei più vivaci. Il liceo in sé era un enorme edificio quadrato a strapiombo sulla strada. Vi si accedeva da due scale laterali e da una di fronte, larga e monumentale, fiancheggiata da giardini striminziti in cui erano stati piantati banani e con grate che li proteggevano dal vandalismo degli allievi. La scala centrale sfociava in una galleria in cui confluivano anche le due laterali e in cui si apriva la porta monumentale usata nelle grandi occasioni, mentre di solito si accedeva da una porta molto più piccola che dava sulla guardiola a vetri del portiere.
Era in questa galleria che, fra i primi allievi arrivati, la maggioranza dei quali cercava di nascondere la tremarella sotto un'aria disinvolta, a parte alcuni che rivelavano la propria ansia col pallore del viso e col silenzio, il signor Bernard e i suoi ragazzi aspettavano, nel fresco del primo mattino, davanti alla porta chiusa e di fronte alla strada ancora umida che il sole avrebbe presto coperto di polvere. Erano in anticipo di almeno mezz'ora e tacevano, stretti intorno al maestro, che non trovava nulla da dire e che li lasciò all'improvviso dicendo che sarebbe tornato subito. Lo videro in effetti ricomparire un attimo dopo, sempre elegante col cappello dalla tesa rialzata e le ghette indossate per l'occasione, e teneva in entrambe le mani due pacchetti di carta seta avvolti a tortiglione perché fosse più facile portarli, e quando s'avvicinò videro che la carta era macchiata di grasso. “Ecco dei croissant,” disse il signor Bernard. “Mangiatene uno adesso e conservate l'altro per le dieci.” Lo ringraziarono e mangiarono, ma facevano fatica a inghiottire la pesante pasta lievitata. “Non perdete la testa,” ripeteva il maestro. “Leggete bene l'enunciato del problema e l'argomento del tema. Leggeteli più di una volta. Il tempo l'avete.” Sì, li avrebbero letti più di una volta, gli avrebbero obbedito, a lui che sapeva tutto e accanto al quale la vita era sgombra di ostacoli, bastava che si lasciassero guidare. In quel momento si udì un vocio nei pressi della porticina. Tutti i candidati, una sessantina adesso, s'avvicinarono in quella direzione. Un bidello aveva aperto la porta e stava leggendo un elenco. Il nome di Jacques fu pronunciato fra i primi. Teneva ancora la mano del maestro. Esitò. “Va', figliolo,” disse il signor Bernard. Jacques, tremante, si diresse verso la porta e, prima di varcarla, si voltò verso il maestro. Era lì, alto e robusto, gli sorrideva tranquillo e faceva segno di sì con la testa.
A mezzogiorno, il signor Bernard li aspettava all'uscita. Gli mostrarono le loro brutte copie. Solo Santiago aveva sbagliato il problema. “Il tuo tema è ottimo,” disse concisamente il maestro a Jacques. All'una, li riaccompagnò. Alle quattro era di nuovo lì, a esaminare i loro lavori. “Andiamo,” disse, “adesso non resta che aspettare.” Due giorni dopo, alle dieci del mattino, si ritrovarono tutti e cinque davanti alla porticina. La porta si aprì e il bidello lesse un altro elenco, stavolta molto più breve, quello degli ammessi. Nel frastuono, Jacques non udì il proprio nome. Ma ricevette un allegro buffetto sulla nuca e sentì il signor Bernard che gli diceva: “Bravo, moscerino, ce l'hai fatta. Ti hanno preso.” Solo il gentile Santiago aveva fatto fiasco, e gli altri lo guardavano con una specie di distratta tristezza. “Non fa niente,” diceva lui, “non fa niente.” E Jacques non sapeva più dov'era, né che cosa gli stesse capitando, e tornarono tutti in tram. “Verrò a trovare i vostri genitori,” disse il signor Bernard, “ma passo prima da Cormery, che è il più vicino”, e nella povera sala da pranzo, adesso piena di donne, c'erano sua nonna, sua madre, che per l'occasione aveva chiesto un giorno di permesso, e le Masson, le loro vicine, e lui era accanto al suo maestro, respirando per l'ultima volta il profumo d'acqua di colonia, incollato al caldo tepore di quel corpo massiccio, e la nonna esultava davanti alle vicine. “Grazie, signor Bernard, grazie,” diceva, mentre il signor Bernard accarezzava la testa del ragazzo. “Adesso non hai più bisogno di me,” gli disse, “avrai maestri più sapienti. Ma, se ti servisse aiuto, vieni a trovarmi, sai dove sto.” Se ne andò, e Jacques rimase solo, smarrito fra tutte quelle donne; poi si precipitò alla finestra, per guardare il suo maestro che lo salutava ancora una volta e lo lasciava ormai solo, e anziché la gioia del successo, sentì un immenso dolore infantile che gli stringeva il cuore, come se sapesse in anticipo che quel successo lo sradicava dal mondo caldo e innocente dei poveri, un mondo chiuso in se stesso come un'isola nella società, ma nel quale la miseria sostituisce la famiglia e la solidarietà, per gettarlo in un mondo sconosciuto, che non era più il suo, e gli era impossibile credere che i maestri fossero più sapienti di quello che conosceva il suo cuore, e d'ora in avanti avrebbe dovuto imparare, capire senza aiuto, diventare uomo, insomma, senza l'appoggio dell'unico uomo che mai gli avesse dato una mano, crescere insomma e allevarsi da solo, a carissimo prezzo.
Albert Camus, Il primo uomo, Bompiani, Milano 2020, pp. 125-158
ZIBALDONE MINIMO
Volto
di Gianni Gasparini

Il volto di un uomo, di una donna è il vertice, il capolavoro di chi ha presieduto alla gestazione, alla nascita di un essere che è cresciuto nell’ombra di un utero. Il volto ci rende simili a ciascuno dei mortali che dall’inizio dei tempi si sono succeduti sulla scena del mondo fino ad oggi: simili ma assolutamente unici, riconoscibili nella nostra singolarità. Nessuno ha mai avuto né potrà avere un volto come il mio.
Una sevillana del Settecento, antico ballo e canto flamenco ripreso da García Lorca un secolo fa, mette in bocca a una donna di Siviglia queste parole: “Un volto come il tuo non l’ho trovato” (Cara como la tuya no la he encontrado). La donna ha percorso tutta la città, l’antico quartiere di Triana e la Macarena dove sorge la grande basilica dedicata alla Madonna, ma quel volto non l’ha trovato, non l’ha più rivisto tra mille persone incontrate e sfiorate per via.
È il volto dell’amato, dell’uomo di cui si è innamorata perdutamente senza dire a nessuno il suo segreto, neppure a lui, e ora lo va cercando tra la folla, animata dalla speranza ma temendo di non poterlo più rivedere. Il volto dell’amato è unico, non ha eguali; lei lo vede ora con gli occhi del sogno, della rêverie, dell’immaginazione aperta al compimento, alla pienezza perseguita ma non raggiunta. Questa donna di Siviglia richiama l’altra di Vigo sulle sponde estreme dell’Oceano, in terra di Spagna: quella di cui ha cantato Martin Codax alla fine del Duecento quando immagina che la donna stia davanti al mare e interroghi le onde per pregarle di portare a lei notizie dell’amato lontano.
Chi sa se l’ignoto scrittore e compositore a cui dobbiamo questi pochi versi, quelli di una donna di Siviglia che s’immerge muta in una folla per cercarvi l’unico volto che conta per lei, si è reso conto che questo canto avrebbe travalicato i secoli per parlarci non solo dell’amore tra una donna e un uomo ma dell’amor lontano dei trovatori, dell’amore romantico che si proietta con la sua forza irresistibile al di là di ogni ostacolo.
E ci avrebbe parlato, in fondo, della ricerca inesausta e mai compiuta di quel volto dell’Amato che sta oltre ogni sembianza ed esperienza umana: il volto cercato da Al-Hallaj e da Rumi, da Francesco di Assisi e da Giovanni della Croce.
Ci sono volti reali trasfigurati dal sorriso e volti che comunicano l’ansia del vivere. Giorni fa camminando nel centro di Milano ho incrociato una ragazza che era seduta su un gradino accanto a un supermercato: era vestita normalmente, jeans e giaccone, poteva essere una persona in attesa di qualcuno. Ma poi mi sono soffermato sul suo sguardo: mostrava il disagio di chi chiede l’elemosina per strada e senza neppure chiedere mette per terra davanti a sé un bicchierino di plastica per raccogliere le monete. È stato il volto, un volto segnato da un’abitudine alla sofferenza, a farmi capire che quella ragazza era una mendicante, a farmi intuire qualcosa forse dei suoi pensieri e delle sue preoccupazioni, a farmi riflettere sul mistero di profondità che un volto può celare.

