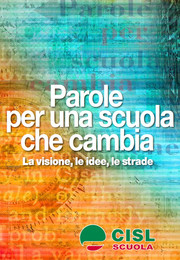
In questa pagina:
Pensieri a voce alta: Ritorno a scuola, un evento da festeggiare (Maddalena Gissi)
La parola di questo mese: Desiderio (Raffaele Mantegazza)
Con altro sguardo: Non possiamo abituarci all'orrore (Daniele Mencarelli)
Hombre vertical: “Si sbaglia perché imperfetti, si chiede scusa perché responsabili” (Emidio Pichelan)
La poesia dei luoghi: L’ogliastro millenario di Cùglieri (Gianni Gasparini)
Dibattito: Umanesimo (Marco Gatto)
Storia contemporanea: 1941 - L'anno della svolta (Paolo Acanfora)
Letture: “Da cielo in terra…” Come salvarsi la vita (Leonarda Tola)
Un anno con Pinocchio: Il dono di Pinocchio (Gianni Gasparini)
Rilanci e anticipazioni da Scuola e Formazione:
La parola agli insegnanti (M. Antonietta Vito)
Ritrovarsi (Lorenzo Gobbi)
Diario immaginario ma non troppo (Maddalena Cavalleri)
Scrivici, se vuoi, a redazione@cislscuola.it
PENSIERI A VOCE ALTA
Ritorno a scuola, un evento da festeggiare
di Maddalena Gissi

Mai come quest’anno le nostre scuole hanno bisogno, ma direi anche diritto, di vivere in modo festoso la ripresa delle loro attività. La pandemia purtroppo non può ancora dirsi vinta, ma l’andamento della campagna vaccinale, superate difficoltà e intoppi di una fase di avvio nella quale non sono mancati i problemi, accresce la speranza che se ne possa ridurre l’impatto, contenendone le conseguenze più gravi e riconsegnando al Paese, dopo un periodo lunghissimo di sofferenze e restrizioni, una normalità di vita di cui la scuola avverte in particolare la necessità.
Sin dall’esplodere dell’epidemia da coronavirus si è capito quali fossero i fattori decisivi su cui fondare un’azione efficace e in prospettiva vincente di resistenza e di contrasto alla diffusione del contagio: le indicazioni sorrette dalle competenze della comunità scientifica, l’adeguatezza delle scelte compiute nelle sedi di decisione politica e l’autorevolezza di quest’ultime, la responsabilità nei comportamenti individuali. Il tutto nella dimensione globale di una pandemia diffusa a livello planetario.
Avvertire e vivere più intensamente l’intreccio fra il proprio destino individuale e quello della comunità cui si appartiene dovrebbe essere una delle lezioni più importanti da trarre dall’esperienza vissuta in questi mesi lunghi, difficili e dolorosi. Speriamo che sia così, anche se non mancano segnali preoccupanti in direzione opposta, con cedimenti alla tentazione di tornare a uno status quo ante non sempre degno di apprezzamento. Col rispetto che abbiamo sempre avuto per le decisioni assunte da altre sigle, in un panorama sindacale così articolato e plurale come il nostro, non ci sembra per esempio un bel segnale quello dato con la proclamazione di uno sciopero nel primo giorno di lezione, mettendo insieme forzosamente una serie di motivazioni che ammantano l’intento realmente perseguito, quello di intercettare i malumori sollevati dalle disposizioni sul green pass (con connessi, immancabili risvolti sulle azioni di contenzioso legale che da sempre connotano in modo preminente l’attività della sigla che lo ha indetto). Perché si tratti di una decisione inopportuna l’ho detto in apertura di queste note: nel merito delle rivendicazioni, aggiungo che sono le stesse su cui le organizzazioni più rappresentative da tempo sono impegnate, non senza apprezzabili risultati, e continueranno ad impegnarsi, a partire dai tavoli di confronto attivati con la firma del protocollo sicurezza del 14 agosto. Né la ricerca ostentata dello scontro che sembra connotare molte prese di posizioni del presidente dell’ANP contribuisce a migliorare il clima, alimentando nella pubblica opinione una diffidenza e un’ostilità che il personale scolastico non merita nel modo più assoluto. Non è così che si favorisce quel contesto di serenità e pacatezza nel quale sarebbe oltretutto anche più facile affrontare e risolvere le criticità legate alla concreta gestione del green pass.
Abbiamo da subito denunciato come fosse sbagliato e anche un po’ fuorviante concentrare l’attenzione su questo tema (e ancor più su quello delle connesse sanzioni), trascurando altri fattori che incidono fortemente sulla possibilità di garantire uno svolgimento in sicurezza delle attività in presenza. Lo abbiamo detto in tutte le sedi e scritto a chiare lettere, come CISL Scuola e come CISL, con interventi in prima persona del segretario generale Luigi Sbarra. Ciò non ha mai significato, tuttavia, sostenere che il green pass sia misura inutile o inefficace: non sta a noi deciderlo, non ne abbiamo l’autorità e men che meno la competenza. Né avrebbe senso una posizione di rifiuto motivata da inadempienze o insufficienze riscontrabili su altri versanti: non regge l’argomentazione per cui una misura che aiuta a contenere la diffusione del contagio possa ritenersi non necessaria, solo perché da sola non sufficiente. Ragionamento assurdo, illogico e pericoloso.
Non si può, infine, definire “battaglia di libertà” quella di chi si oppone alla vaccinazione rivendicando al riguardo un proprio diritto soggettivo e assoluto di scelta (che in realtà lo stesso art. 32 della Costituzione non riconosce come tale), non esitando a paragonare le regole stabilite per legge, e le sanzioni in caso di inosservanza, ai provvedimenti liberticidi del ventennio. Che poi nel sostenere queste tesi ci si ritrovi in piazza, in nome dell'antifascismo, a fianco di chi professa un’esplicita nostalgia del fascismo e del nazismo aggiunge al quadro un tocco di paradossalità.
Si ha talvolta l’impressione che manchi una lucida consapevolezza del contesto in cui da quasi due anni ci si sta muovendo, con un’emergenza di dimensioni planetarie costata ad oggi milioni di morti e dal tremendo impatto sulle condizioni generali di vita, nell’immediato e in prospettiva. Arrestare il contagio, sconfiggere il virus, evitare che al disastro sanitario segua quello economico e sociale: questa la vera battaglia alla quale tutti dovremmo sentirci in dovere di contribuire. Non c’è da aggiungere proprio nulla alle parole che su questo hanno speso di recente il Presidente della Repubblica (a proposito di libertà e di responsabilità personale e collettiva) e papa Francesco (a proposito di amore per il prossimo): c’è solo da ascoltarle e farle proprie.
LA PAROLA DI QUESTO MESE
Desiderio
di Raffaele Mantegazza

I miei nonni non sapevano né
leggere né scrivere. I loro padri
nemmeno. Una delle mie zie, pure. I
miei genitori non hanno frequentato
le elementari e io le superiori. Ciò
nonostante ecco che io, Frances K.
Nolan, seguirò dei corsi all’università.
Capisci, Francie? Frequenti
l’università! Oddio mi sento male.
Betty Smith, “Un albero cresce a Brooklyn”
In una bella scena del film “Viaggi di nozze”, Claudia Gerini, neo-sposa del “coatto” interpretato da Carlo Verdone, commenta in questo modo il passaggio di una stella cadente: “ma che tte voi desiderà?”. “Ma che cosa vuoi desiderare?”; forse questa è una delle frasi più tristi del film, che mostra la crisi di un gruppo di giovani sempre alla ricerca dell’eccesso e della stranezza per poi ritrovarsi incapaci di un reale desiderio.
Che nella parola “desiderio” sia celata la parola “stelle” (“sidera”) è cosa nota: chissà se si tratta di “uscire a riveder le stelle”, ovvero della possibilità di scampare a un pericolo, di fare un passo fuori dall’inferno quotidiano; di essere “puri e disposti a salire alle stelle”, cioè di sentirsi pronti al grande salto verso nuove dimensioni, verso un “trasumanare” che porti l’essere umano oltre se stesso; oppure se si tratta di cogliere “l’amor che move il sole e l’altre stelle”, in una specie di contemplazione finale della bellezza dell’Universo.
Forse tutte e tre queste dimensioni del desiderio devono entrare a far parte dell’attività educativa e del pensiero pedagogico.
Anzitutto il desiderio di liberazione: l’educazione è una potente forza liberante, l’ha scritto Paulo Freire in modo definitivo. L’educazione porta nell’animo dello schiavo quel desiderio di libertà che gli mancava, e in questo senso il mito della caverna di Platone è la prima vera narrazione pedagogica. Lo schiavo che non sa di essere tale viene risvegliato dal suo mondo d’ombre e solo allora può in iniziare a desiderare la libertà. L’educazione dunque non lascia in pace gli schiavi, vuole pungolarli con il desiderio di poter essere liberi, e dunque nell’attività educativa c’è anche un elemento di fastidio, di sommovimento, di risveglio dai sonni dogmatici di qualsiasi tipo. Forse in questo senso il desiderio è anche legato alla percezione del dolore, o anche solo della mancanza di qualcosa, dell’incompiutezza. Chi si sente arrivato, chi si accoccola nella sua schiavitù davanti alla parete sulla quale vengono proiettate le ombre (quanta attualità rispetto al mondo degli schermi!) smette di desiderare, non percepisce più lo stimolo a uscire dalla sua situazione; qui l’educazione è la scossa da torpedine della quale sembra fosse maestro Socrate.
Ma poi c’è anche una dimensione del desiderio che è anelito a un grande salto, speranza di raggiungere una dimensione altra; sulla montagna del Purgatorio inizia un altro viaggio, che porterà alla Utopia, a dimensioni mai viste e mai udite. La purificazione che porta al desiderio consiste nel saziarsi della realtà materiale del mondo capendo però come questa sia solamente un’anticipazione di mondi lontanissimi rispetto ai quali possiamo immaginare e sognare. “Perché la pace che ho sentito in certi monasteri/o la vibrante intesa di tutti i sensi in festa/sono solo l’ombra della luce” (Battiato). Ogni elemento di apprendimento non è mai fine a se stesso, è sempre un gradino di una scala che porta al di là di ste stesso. Sarebbe un tradimento della scuola e soprattutto dei ragazzi se ci racchiudessimo nelle gabbiette delle conoscenze (magari con il furbo escamotage di chiamarle “competenze”) proponendo una scuola che funziona come una macchinetta del caffè, pronta a distribuire pezzettini di sapere che non accennano mai al di là di se stessi.
Infine c’è un desiderio che si potrebbe definire mistico, quello nel quale il soggetto e l’oggetto del desiderio si fondono. Vicino forse alla beatitudine che abbiamo vissuto nel grembo materno, questo desiderio non è attingibile solamente nelle esperienze religiose: guidare i bambini e i ragazzi a essere tutt’uno con quello che studiano, a fondersi con la poesia, il teorema matematico, il verbo nella lingua straniera, aiutarli a immergersi in ciò che studiano per poi riemergerne migliori, cresciuti, felici, è il senso del desiderio nella scuola. La mattina a scuola i bambini e i ragazzi devono dimenticarsi del mondo (anche quando lo studiano, se mai arriveremo a capire che è indecente che un ragazzo di diciannove anni non studi la storia degli ultimi 50 anni) e in parte anche di se stessi; come avviene nel teatro, nell’immersione nella natura, nell’amore.
È bello che i ragazzi desiderino stare insieme ai loro amici, rivedere gli insegnanti, divertirsi negli intervalli: ma una scuola che faccia loro desiderare Leopardi e le funzioni algebriche è una scuola che riporta il desiderio alle sue radici culturali. È la nostra cultura che ci porta a desiderare, e il desiderio è uno degli atteggiamenti più intelligenti che l’essere umano possa mettere in campo. Desiderare è un atto cognitivo ed emotivo allo stesso tempo. E la scuola che incrocia queste due dimensioni è una scuola desiderabile, una scuola che è un diritto di tutte e di tutti esattamente come la felicità.
CON ALTRO SGUARDO
Non possiamo abituarci all'orrore
di Daniele Mencarelli

Nel settembre del 2015 il mondo gridò di orrore. Una fotografia stravolse l’opinione pubblica, fermò di colpo tutte le questioni interne ai singoli Stati, sembrò quasi cancellare qualsiasi forma di ordinaria amministrazione.
La fotografia era quella del piccolo Alan Kurdi, ritrovato senza vita su una spiaggia dell’Egeo. La sua famiglia, in fuga dalla Siria, tentò come altre migliaia di profughi di raggiungere l’occidente attraverso le tratte clandestine, nel loro caso dalla Turchia verso la Grecia. Partirono da Bodrum, ma il loro viaggio durò poco, pochissimo, il gommone sul quale viaggiavano si capovolse per il mare grosso e il peso eccessivo. Della famiglia Kurdi sopravvisse solo il padre, mentre la madre e i due figli, Ghalib e Alan, affogarono.
La fotografia di Alan con il volto nella sabbia, bagnato dalle onde del mediterraneo, con la sua magliettina rossa, i pantaloncini blu, ci rimase negli occhi per settimane. Una civiltà che permette una simile sciagura non è più una civiltà. Questo dissero, dicemmo, tutti. Talmente forte lo sdegno collettivo, e sincero, che in molti pensarono che quel sacrificio potesse aprire un nuovo capitolo della Storia. Una nuova era. Dove i bambini, tutti, ma proprio tutti, avessero stessi diritti e possibilità. Poi l’umanità riprese la corsa, dimenticò quegli attimi di commozione, come succede sempre, in preda alla sua smania frenetica.
Qualche giorno fa, Oscar Camps, il fondatore della Open Arms, l’organizzazione non governativa che si occupa di aiuto ai migranti, ha diffuso delle fotografie scattate in Libia. Si vedono i corpi di tre bambini. Altre foto ritraggono adulti. Tre bambini, di cui uno neonato. Vittime di un naufragio, uno dei tanti.
Dalla foto di Alan Kurdi a queste sono trascorsi poco meno di sei anni. Un dato salta agli occhi, evidente per quanto preoccupante. Il piccolo siriano, la sua immagine straziante, divenne icona di una crisi che riguardava tutti, perché tutti hanno una coscienza e da che mondo è mondo i bambini si proteggono.
Perché tutto questo non è successo per quelli ritrovati in Libia? Perché quei tre corpi bambini non hanno prodotto nulla? Se ne è parlato per mezza giornata, poi basta. Qualsiasi spiegazione è a dir poco terribile. La prima cosa che viene in mente è questa: nel giro di poco meno di sei anni l’opinione pubblica, tutti noi, ha vissuto una specie di assuefazione-regressione all’orrore, al punto da rendere digeribile una foto che ritrae tre bambini morti su una spiaggia. Un’altra chiave di lettura potrebbe essere questa, forse ancora più disumana della prima. Le foto diffuse da Camps sono state scattate a Zuwara, in Libia, e si sa, la nostra coscienza ha oggi un confine geografico, e quel confine è proprio il Paese nordafricano, tutto ciò che accade da lì in poi e affare di altri, ed è sempre lecito. E poi, a guardare bene, quei tre bambini erano dalla pelle scura. Ma delle spiegazioni possibili interessa il giusto. Anzi niente.
L’orrore, un tanto al giorno, come una cura omeopatica somministrata ai nostri occhi, ci sta invadendo la coscienza e non ce ne accorgiamo. È la storia. La nostra storia. Quella che fa di ogni sciagura del passato, dai lager ai roghi, qualcosa che deve ancora avvenire.
HOMBRE VERTICAL
“Si sbaglia perché imperfetti, si chiede scusa perché responsabili”
di Emidio Pichelan

L’abbiamo incrociata piuttosto spesso in questi anni Wislawa Szymborska, la poetessa polacca Nobel per la Letteratura. Un nome un po’ ostico per una poetessa umile e saggia come un’amica della porta accanto. In “Chiedere scusa” sfoglia umilmente un lungo elenco di ragioni per chiedere venia: dal fatto di chiamare fato necessità alla dimenticanza dei morti, all’abbattimento di un albero per dotare il tavolo delle sue quattro gambe, ai limiti sostanziali dell’umana esistenza:
Chiedo scusa a tutti se non so essere
ognuno e ognuna.
So che finché vivo niente mi giustifica,
perché io stessa mi sento d’ostacolo.
Non avermene, lingua, se prendo in prestito
parole patetiche
e poi fatico per farle sembrare leggere.
Già nel 2017 è successo che Angela Merkel, figlia un pastore protestante dell’allora Repubblica di Bonn, emigrato nella DDR (la Repubblica Popolare dell’Est), scienziata per formazione, chiedesse scusa alla Namibia (Africa meridionale, tra Angola e Sudafrica) per i crimini commessi dai colonizzatori tedeschi contro le popolazioni Herero e Namia tra il 1904 e il 1908. Evidentemente, Angela aveva studiato responsabilmente la storia del suo Paese, inclusa la poco gloriosa storia coloniale. Il 28 maggio scorso il “suo” ministro degli Esteri Heiko Maas ha annunciato di aver raggiunto con la Namibia un accordo economico riparatore (1,3 miliardi di euro).
Anche il nostro Paese ha avuto un passato coloniale. Ce lo ha insegnato da molti anni un giornalista-scrittore curioso e impegnato, Angelo Del Boca. Se n’è andato in questi giorni, quasi centenario. Ma al di là di alcuni ambiti ristretti, preferiamo cullarci con una rimozione (ne è esempio convincente il mito autoassolutorio – caro assai alle destre – di “Italiani brava gente”, non a caso il titolo di un suo fortunato saggio che smonta la favola con la pazienza dell’investigatore attento ai fatti e alla ricerca della verità), e con veri e propri orrori. Vergognosi, imperdonabili.
Come il deprecabile Museo di Affile (nelle vicinanze di Roma), dedicato all’impunito gerarca fascista Rodolfo Graziani: un generale e un politico fascista che conquistava e sottometteva ricorrendo alle armi chimiche proibite dalle convenzioni internazionali (su questo preciso punto Del Boca sostenne, vittoriosamente, un’aspra diatriba con Indro Montanelli, che alle guerre coloniali aveva preso parte da soldato), alle stragi di civili (di abissini, nel 1937), alla costruzione di campi di concentramento (dove si moriva per fame e sfinimento), alle fucilazioni di massa (il massacro dei preti e dei diaconi copti di Debra Libanós: 449 vittime secondo i resoconti ufficiali, tra le 1.500 e le 2.000 secondo gli studi degli anni Novanta). E, infine, proprio per non farsi mancare niente, prendendo parte attiva nel rastrellamento (tedesco) dei 1.269 ebrei del ghetto romano (16 ottobre ’43).
Persino la teocratica Chiesa Romana ha sentito il bisogno, negli ultimi decenni, di chiedere scusa per i suoi errori. Ripetutamente. Per bocca di Paolo VI, Giovanni Paolo II, Papa Francesco.
L’ignoranza sui nostri trascorsi coloniali non è più tollerabile; lo sono ancor meno i tanti tentativi di rimuovere e/o ignorare e/o giustificare le pagine degli errori e degli orrori, con la conseguenza – inevitabile – di rimanere imprigionati nelle scorie e negli ingombri del passato. Schiavi di paure esorcizzabili solo con le armi della conoscenza e del perdono.
“Il perdono libera l’anima”, diceva Nelson Mandela, superesperto in materia di ingiustizia-perdono, “rimuove la paura. È per questo che il perdono è un’arma potente”.
Gli faceva eco Bob Marley, molto di più di un semplice chitarrista e cantautore, un altro che conosceva bene la tragicità della spirale ingiustizia/vendetta: “si sbaglia perché imperfetti, e si chiede scusa perché si è responsabili”.
LA POESIA DEI LUOGHI
L’ogliastro millenario di Cùglieri
di Gianni Gasparini

Gli spaventosi incendi e le devastazioni che hanno infierito a fine luglio scorso in Sardegna, bruciando case e distruggendo ventimila ettari di bosco e di macchia mediterranea, sono stati particolarmente impressionanti nella zona di Cùglieri e nei paesi circostanti, in provincia di Oristano, a poca distanza dal mare: qui le immagini apparse sui giornali mostravano fiamme altissime e fumi scuri che facevano da sfondo sinistro a case e strade.
In questa catastrofe locale, dove fortunatamente non ci sono state vittime umane, sono morti molti animali allevati nella campagna e sono andati in cenere innumerevoli esseri vegetali, del bosco e di quella macchia che qui riveste armoniosamente le sponde del mare di Sardegna. Ho pensato in modo particolare a un albero più che millenario che sono andato a conoscere pochi anni fa nella campagna di Cùglieri, quello di Sa Tanca Manna.
Dalla strada che unisce Alghero a Oristano si segue un’indicazione, ci si inoltra nella campagna coltivata soprattutto ad ulivi, ci si ferma a un certo punto e si lascia la macchina, proseguendo a piedi su un sentiero silenzioso che si apre tra i coltivi. Ed ecco apparire l’albero, lui, l’olivastro di ben più di mille anni che si erge completamente isolato e maestoso, in una posizione che dà risalto eccezionale ai suoi venti metri di altezza e ai dieci-undici di circonferenza.
È una vera apparizione. Quando gli arrivi vicino e poi davanti, e quando ne compi lentamente il giro attorno, è come se questo albero, che era scampato chissà come alle vicissitudini e ai tagli che hanno interessato tutti gli altri suoi consimili coetanei, ti dicesse di osservarne il portamento, di cogliere la bellezza del tronco rugoso e dei rami contorti, di osservare le foglie che si riproducono da innumerevoli stagioni, di gustare l’ombra che ti offre. L’ogliastro ti sfida a sfiorare il mistero del tempo che esso ti testimonia e quasi ti getta in faccia. Tempo dell’albero – dei vegetali, della natura – e tempo dell’uomo, di quella che viene chiamata storia e incede un secolo dopo l’altro, attraverso decine di generazioni.
Ho avuto modo negli anni di andare a conoscere gli olivastri monumentali e gli alberi più antichi della Sardegna. Ricordo tra gli altri i secolari ogliastri e carrubi che sono raccolti gradevolmente in una sorta di piccolo parco al cui centro sta l’antica chiesa di Santa Maria Navarrese, in Ogliastra; e gli antichissimi ogliastri di Luras in Gallura, che occorre andare a cercare all’interno di un bosco, quasi nascosti e protetti da molti alberi più giovani. Ma quando ho visto l’ogliastro antico di Sa Tanca Manna ho subito pensato che fosse il più straordinario tra tutti quelli che avevo già ammirato, che anzi rappresentasse una delle creature vegetali più meravigliose tra quelle che avevo avuto modo di visitare negli ambienti più diversi del nostro paese.
Mi accorgo che sto parlando di questo albero come se fosse vivo, come se ancora dominasse con la sua umile e fiera autorevolezza la campagna che precede coste dirupate e non molto accessibili come quelle di Porto Alabe, anch’esse raggiunte dalle fiamme nella catena di incendi di cui non è da escludere l’origine dolosa.
Anche l’albero antico della campagna di Cùglieri è bruciato nella catastrofe, è caduto come moltissimi altri vegetali toccati dalla furia del fuoco: non c’è stata nessuna considerazione per la sua età vetusta, per la sua rara bellezza.
Penso che anche per la morte di un albero, pur mantenendo le debite proporzioni rispetto alla vita dell’uomo, si possa provare sofferenza e persino dolore. Forse, perché la scomparsa di un monumento della natura come un essere vegetale millenario ci fa toccare con mano la realtà dell’impermanenza di tutto ciò che ci circonda, della caducità delle cose del mondo in cui abbiamo avuto la ventura di trascorrere il nostro viaggio, anche di quelle più antiche e resistenti all’usura del tempo.
DIBATTITO
Questo importante e solido contributo di Marco Gatto evidenzia la necessità di utilizzare questo tempo per una riflessione a tutto campo sui destini della scuola toccando nodi cruciali e delicatissimi come quello dell’Autonomia e di più ampie questioni sociali e politiche. Il dito dell’autore è puntato contro il rischio di una “ideologia pratico-competitiva che pone l’accento più sul saper operare che sul saper ragionare, distinguere, pensare”. Duro e senza sfumature o possibilità di appello è il giudizio su un processo che “vuole la scuola non come fabbrica di cittadini consapevoli, ma come perfetti ingranaggi di un mondo dominato dalla tecnica e dalla competizione”. Di qui il richiamo al recupero di quella radice umanistica che è identità e consegna preziosa della nostra tradizione educativa. L’analisi e il discorso di Marco Gatto sollecitano un dibattito ampio e sereno che, superando possibili rigide derive e contrapposizioni semplificatorie e ideologiche, colga e cerchi di sciogliere i nodi operativi, curricolari e didattici di un progetto di scuola all’altezza delle sfide complesse di questa difficile età di transizione.
Per questo invitiamo tanti altri amici ad arricchire e sviluppare questo dibattito partecipandovi direttamente.
Umanesimo
di Marco Gatto

Ci siamo lasciati alle spalle un anno scolastico complesso e difficile. Ne sta per iniziare un altro che pone sfide e interrogativi. Mai come in questo momento si rende necessaria una riflessione a tutto campo sui destini della scuola. Una riflessione che vada oltre l’assillo tecnocratico dell’ultimo decennio e che ripristini un alfabeto di pensieri capace di insistere sui valori, sui compiti, sulle speranze della scuola pubblica.
Il punto di partenza è, senza dubbio, la grande contraddizione scoperchiata dalla crisi sanitaria. All’illusione dell’autonomia – favorita dall’idea che la scuola possa rappresentare un organismo a sé, dotato di logiche proprie, magari legate a interessi locali e specifici, nonché orientate a un protagonismo aziendalistico – si è passati all’evidente nesso che stringe il sistema educativo, con i suoi meriti e le sue falle, alle questioni sociali nel loro complesso: il problema scolastico è anche il problema di un Paese a più velocità; è anche il problema di una disgregazione sociale che si fa più deleteria nelle aree povere e depresse, nelle periferie come negli spazi più segnati da un profondo disagio; è anche il problema di infrastrutture e servizi che non si limitano agli edifici deputati alla formazione, ma coinvolgono il sistema dei trasporti, degli ospedali, dei luoghi di aggregazione. La scuola è, insomma, il punto di incontro e di sintesi di un conflitto più vasto e generale. Il ripresentarsi di questa verità lapalissiana rappresenta un’opportunità da cogliere.
Il segno reale delle contraddizioni sociali, verso le quali sarà opportuno formulare nuove strategie di resistenza, coincide con l’abbandono scolastico. L’alto tasso di dispersione è una ferita da rimarginare ed è la cartina al tornasole della frammentazione sociale che colpisce il Paese. La pandemia ha chiaramente esasperato le disuguaglianze, che pure preesistevano ai dilemmi della didattica a distanza e del gap tecnologico. Ha mostrato il volto classista del sistema pedagogico, che si avvia ad essere sempre più strutturale. L’attenzione per gli ultimi troverebbe fondamento, del resto, in una scuola realmente aperta alla società. La trasformazione di quest’ultima in un luogo di competizione e di sedimentazione pervasiva delle differenze sociali ha ostacolato e continua a ostacolare, al contrario, qualsivoglia intervento di natura egualitaria. Sicché la scuola rischia di diventare, ancor più in un contesto di generale aggressività, un luogo in cui gli ultimi restano tali e un’istituzione in cui gli attori sociali – docenti e studenti – si ritrovano a lavorare per mezzo di predeterminate scelte progettuali. Non solo: il discorso sugli ultimi, ossia il discorso sui valori di una società che dovrebbe pensarsi coesa e solidale, diventa mera retorica umanistica da accantonare, a beneficio di un’ideologia pratico-competitiva che pone l’accento più sul saper operare che sul saper ragionare, distinguere, pensare.
La didattica fondata sulle competenze, del resto, ha rappresentato e continua a rappresentare il veicolo di un sentire epocale che all’apprendimento sostituisce l’abilità, al sapere basilare e indifferenziato lo specialismo concretamente indirizzato verso la risoluzione particolare di un problema. La natura strumentale ed efficientista di questo approccio è talmente evidente che sembra oggi largamente accettata senza grandi criticità. Dietro la narrazione di una scuola capace di dialogare con il mondo del lavoro si cela, insomma, una ristrutturazione consapevole del sistema educativo: non più il lungo percorso di costruzione di una consapevolezza insieme individuale e comunitaria, ma l’occasione per forgiare individui pronti a entrare, senza anticorpi, nella macchina infernale della precarietà, dello sfruttamento, del mercato occupazionale. Come ha mostrato recentemente Lucia Donat Cattin, in uno scritto contenuto nel bel numero sulla scuola che la rivista “L’ospite ingrato” ha recentemente licenziato, in un contesto simile, «dove l’autonomia lasciata alle singole scuole, lungi dall’essere l’istanza democratizzante nata negli anni Settanta, altro non è che l’autonomia di applicare un modello preconfezionato, declinato secondo le esigenze del mondo imprenditoriale, globalizzato, dove la libertà di insegnamento è sempre più un’illusione, è evidente che non è facile trovare spazi di azione possibili». Anche perché, ricorda ancora l’autrice, siamo di fronte a una sedimentazione valoriale di lungo periodo, fondata in larga misura su un modello didattico «performante», nell’alveo del quale si sono formate generazioni di insegnanti, spinte ad aderirvi per necessità(1).
Una probabile arma critica è dunque rappresentata dalla possibilità di vedere nella scuola il contenitore di un conflitto ideologico che può essere ancora alimentato. A patto di essere netti nel dire che la scuola sia oggi anzitutto una fabbrica antropologica, ossia la sede di una costruzione egemonica di pensiero, il luogo in cui si predeterminano individualità. Lo scontro è ancora una volta tra l’orizzonte dominante della tecnocrazia – un apparato che si esprime attraverso una normatività operativa fatta di parole-sintomo come “competenza”, “abilità”, “saper-fare” – e l’orizzonte residuale dell’umanesimo democratico. Non si tratta di agitare concetti-feticcio. È evidente che la dimensione scolastica sia invasa da logiche in larga parte aliene dall’edificazione consapevole di un sapere disinteressato, ma è pur vero che la classe resta il luogo possibile di un incontro differente con il mondo e con la realtà, mediato da una figura, l’insegnante, che è oggi costretta a cercare vie di fuga alternative, nuove e feconde possibilità di relazione, malgrado l’invasiva sensazione di operare in solitudine e in controtendenza. Un lavoro complesso e difficile, quest’ultimo, anzitutto perché non riconosciuto socialmente (per non parlare dei problemi che impone la continua precarizzazione del personale). Eppure, rafforzare un discorso resistenziale sembra oggi uno dei pochi strumenti a disposizione per dimostrare il possibile rovesciamento di ordine, per demistificare, cioè, quel processo che vuole la scuola non come fabbrica di cittadini consapevoli, ma come perfetti ingranaggi di un mondo dominato dalla tecnica e dalla competizione.
Qui il discorso incontra una riflessione più generale, che dev’essere, pur velocemente, lambita. Da almeno un trentennio, nel nostro Paese ma probabilmente in tutto l’Occidente, gli istituti di formazione sembrano indirizzati da sicure scelte governative verso una cancellazione della loro radice umanistica. Tra il “sapere” e il “fare” – due poli che andrebbero mantenuti in perenne reciprocità – è venuto a prodursi uno iato ideologico. Il fare non si è identificato più con la realizzazione effettiva di un percorso di emancipazione individuale, ma come mero momento di applicazione di una serie ristretta di conoscenze, del tutto disarticolate da un possibile quadro più generale. Questa profonda scissione ha risultanti antropologiche e sociali di grande evidenza. Rientra cioè in quel quadro più generale di particolarizzazione dell’esperienza individuale che descrive un mondo non solo de-socializzato, ma fondato sulla presunta autonomia del singolo: autonomia che non è conquista di uno spazio definito e coincidente con la propria realizzazione individuale, ma disponibilità perenne a riorientarsi costantemente in quella dimensione flessibile e cangiante, e per questo labirintica, che oggi caratterizza il mondo del lavoro. Per dirla in breve, è necessario costruire soggettività disposte al nomadismo per incontrare i favori dell’organizzazione produttiva del mondo neoliberale. E la scuola, a sua volta predeterminata da questo quadro valoriale, deve poter assolvere la funzione – paradossale – di agenzia formativa di individualità disorientate.
Cosa vuol dire, allora, possibile recupero di un’istanza umanistica? Se la critica alle pulsioni autonomistiche e particolaristiche della nostra società e alla sua tendenza a segmentare ulteriormente lo spazio sociale, dando vita a nuovi e pericolosi identitarismi, è reale e condivisa, se cioè dalla scuola può partire un discorso di costruttiva contestazione, a quale compito è chiamata quella minoranza – chiamiamola così – che ancora si sforza di insistere su un’idea di sapere democratico, inclusivo, non individualistico? La scuola può offrire oggi una risposta antropologica alternativa, nonostante il comprensibile sconforto che qualunque insegnante si porta dietro nella quotidianità della sua azione educativa. Ma come? È necessario, forse, ricostruire un discorso di consapevolezza critica, cioè diffondere il più possibile l’idea che sia indispensabile non arrendersi alla deriva efficientista. Ciò significa, almeno per me, ritorno a un’idea di pedagogia generalizzata che trova nella classe, intesa come comunità e microcosmo sociale, la sede di una costruzione alternativa di senso. È un lavoro sottile, perché alle logiche più generali che predeterminano mansioni e compiti, che pure ogni insegnante è necessariamente chiamato a osservare, privilegia l’intromissione benefica di un’istanza civile che penetra nella didattica, nella relazione con gli altri, nel sapere che viene trasmesso. La scuola non può perdere questa tensione ideale, e nello stesso tempo pratica, verso l’unità del sapere, alla quale si lega, ovviamente, una resistenza a quei particolarismi che generano competizione.
Un simile orientamento si identifica, insomma, col valore eminentemente umanistico dell’esperienza educativa. Di fronte al microcosmo della classe, l’insegnante è chiamato a un ruolo di mediazione costante. Non può sfuggire che questa idea – Romano Luperini parlava circa vent’anni fa, e giustamente, di professore come intellettuale – oggi sia aggredita da una più generale offensiva rivolta al concetto stesso di mediazione. Mediare significa giustificare il confronto, riempire di contenuti il già dato, problematizzare le questioni. Nello stesso tempo, significa rendersi parziale, quasi scomparire e mimetizzarsi nell’edificazione di un discorso collettivo. È forse la scuola oggi uno dei pochi luoghi in cui questa possibilità sembra potersi ancora dare, purché tali presupposti umanistici ridiventino patrimonio ideale condiviso. La parola “umanesimo”, è vero, può rivelarsi polisemica e ambigua, ma ha il vantaggio di assumere come radice inestirpabile la condizione umana, e dunque sociale, dell’agire: è l’idea di comunità che essa evoca e suggerisce a costituire una meta politica. La scuola può farsi veicolo di un’antropologia diversa da quella svuotata e appiattita dei nostri tempi, purché riparta dalla centralità della mediazione e della relazione. Riempire di concretezza queste parole significa, in fondo, svolgere l’umanesimo, porre al centro l’uomo nell’infinità dei suoi caratteri e delle sue determinazioni; lo strumento di tale svolgimento è il sapere come luogo ideale di incontro e di proliferazione di significati, che al contrario risulterebbero sviliti dal nozionismo autoreferenziale e dal diktat dell’efficienza a tutti i costi.
Come riassumere pertanto l’invito a un rinnovato umanesimo scolastico? In un’epoca che fa della superficie e dell’immaterialità una sorta di norma inaggirabile, il sapere ha bisogno di farsi sostanza: non però nel verso di una sua immediata e facile applicabilità – come una certa retorica funzionalistica ha cercato di suggerire, con esiti purtroppo effettivi –, ma nel verso di un recupero, nel campo pedagogico, della relazione umana e sociale e del confronto che nasce dalla trasmissione di idee, contenuti, storie. Del resto, una scuola libera e aperta presuppone l’inclusione di tutto ciò che appartiene alla dimensione umana. Non sarebbe il caso di evidenziare ulteriormente il valore alternativo di una siffatta pedagogia generalizzata, se non avessimo la sensazione, ahimè sempre più concreta, di una democrazia claudicante e forse mai come oggi serva di logiche disumanizzanti.
(1) Valutare per competenze. Il lungo declino della scuola pubblica, in “L’ospite ingrato”, n. 9, 2021, pp. 108-109.
STORIA CONTEMPORANEA
Ogni mese, con interventi affidati allo storico Paolo Acanfora, si propone la rilettura di alcuni avvenimenti o temi della vita italiana e internazionale che si ritengono particolarmente rilevanti ai fini della comprensione della storia contemporanea.
Si tratta di una serie di contributi occasionati da anniversari le cui date sono individuate ripercorrendo, con cadenza decennale, un vasto arco di tempo che parte dal 1901. In questo mese è la volta del 1941.
1941 - L’anno della svolta
di Paolo Acanfora

- Churchill e Roosevelt
Nella storia ci sono, ovviamente, date (giorni, mesi, anni) che segnano il corso degli eventi più di altre. Possono essere avvenimenti improvvisi – si pensi all’attacco giapponese alla base militare statunitense di Pearl Harbour del 7 dicembre 1941, che tanto peso ha ancora oggi nell’immaginario collettivo – oppure lunghi processi che arrivano a maturazione (tanto per fare un esempio, la proclamazione del Regno d’Italia del 17 marzo 1861). Sono eventi che consideriamo spartiacque, turning point per dirla con un linguaggio oggi internazionale. Il 1941 è senz’altro uno di questi. Non solo per l’attacco a Pearl Harbour.
Il contesto storico di cui parliamo è la seconda guerra mondiale, originata dalla sfida che il nazismo tedesco ha lanciato alle democrazie, ai regimi liberali, all’Europa, al mondo. Arrivato ai vertici della moribonda Weimar al principio del 1933 e divenuto “cancelliere e Fuhrer del Reich” (titolo, non dimentichiamolo, consacrato da un plebiscito popolare che riscosse il 90% dei consensi), Hitler aveva progressivamente mirato ai suoi tre fondamentali obiettivi: rivedere alla radice il sistema di Versailles (ossia, l’assetto internazionale uscito dal tavolo di pace dopo la I guerra mondiale); riportare dentro i confini del Reich tutti i territori abitati da tedeschi (Austria compresa); consentire al popolo ariano di conquistare il giusto spazio vitale (Lebensraum) al fine di costruire un ordine internazionale su basi gerarchicamente razziali. Realizzati i primi due, la guerra scoppiata nel 1939 con l’invasione della Polonia avrebbe dovuto condurre al compimento del terzo ed ultimo obiettivo. Questa era la posta in gioco.
Quando nel giugno del 1940 la Francia venne invasa, solo la Gran Bretagna rimase in piedi a combattere la Germania. Nel giro di poco tempo gran parte dell’Europa continentale fu sotto il controllo delle autorità naziste. Il 1941 fu l’anno in cui tutto inevitabilmente cambiò. Cambiarono i protagonisti, gli equilibri, le strategie della guerra. Non fu, in senso stretto, l’anno della svolta delle operazioni militari. A dirla chiaramente, le forze naziste continuarono a lungo a controllare e dominare gran parte dell’Europa. Tuttavia, erano entrati in scena nuovi protagonisti che si riveleranno decisivi non solo per le sorti belliche ma per tutta la seconda metà del Novecento.
Se dovessimo sintetizzare l’importanza del 1941 potremmo far riferimento a tre cruciali momenti. Due di questi riguardano, banalmente, l’ingresso in guerra di Unione Sovietica e Stati Uniti.
Nel primo caso, l’antefatto da richiamare è naturalmente il cosiddetto patto Ribbentrop-Molotov. In preparazione dell’invasione della Polonia (e quindi dell’avvio della guerra), la Germania aveva stipulato un patto di non aggressione con i sovietici. Questo patto prevedeva un accordo segreto di spartizione dei territori polacchi (non dimentichiamo che la Polonia era stata ricostruita nel 1919, dopo ben 123 anni, da regioni liberate dal crollo dell’Impero austro-ungarico, da quello tedesco e da quello zarista russo, in seguito alla rivoluzione comunista del 1917). In questo modo Hitler si copriva il fianco orientale e Stalin poteva riguadagnare ampie zone perdute prima con la pace di Brest-Litovsk del 1918 (per porre fine alla partecipazione russa alla prima guerra mondiale) e poi con la successiva guerra russo-polacca. La situazione cambiò nel giugno del 1941 con l’avvio dell’operazione Barbarossa. Infastidito da alcuni atteggiamenti sovietici e convinto di poter recuperare grandi risorse per poter far fronte alla sfida con la Gran Bretagna, Hitler decise che era venuto il momento di denunciare il patto di non aggressione ed invadere l’Urss. La tempistica era un dato decisivo. Fondamentale era infatti concludere le operazioni prima dell’arrivo dell’insostenibile inverno russo. L’invasione dei suoi territori portò il gigante sovietico a pieno titolo dentro la guerra.
Nel secondo caso, il teatro di riferimento non fu l’Europa ma il Pacifico. In questa regione il conflitto più rilevante era quello tra Stati Uniti e Giappone. Dopo la svolta militarista degli anni Trenta, il Giappone aveva avviato una politica aggressiva che la portava ad espandere la propria egemonia su un’area di notevole interesse strategico per la politica estera statunitense. La tensione tra le due potenze aveva portato a politiche di boicottaggio commerciale e ad una competizione sempre più palese e combattiva. L’attacco improvviso a Pearl Harbour era, dunque, il frutto di tensioni di lungo corso e una risposta militare alla guerra commerciale già in atto. Dato il patto d’acciaio che legava la potenza asiatica con la Germania nazista e l’Itala fascista, l’attacco nipponico contro gli Stati Uniti comportò l’ingresso in guerra degli Usa anche sul fronte europeo. Invero, la questione non era così meccanica. L’Unione sovietica, ad esempio, continuò fino a poche settimane prima della fine della guerra a non combattere contro il Giappone, creando, quindi, una sorta di asimmetria negli schieramenti. Nel caso statunitense, però, la logica fu diversa. L’atteggiamento dell’amministrazione Roosevelt, sin dall’inizio, non fu semplicemente neutrale – non, almeno, nel senso di una neutralità intesa come equidistanza tra i fronti combattenti. Anzi, gli Usa si presentarono come “l’arsenale delle democrazie”, come una potenza di sostegno allo sforzo franco-britannico di resistenza al nazifascismo. I finanziamenti e gli aiuti furono cospicui, in questa direzione (anche forzando non poco la mano sul piano legislativo).
E veniamo qui al terzo punto, se vogliamo meno ovvio, che ci aiuta a qualificare il 1941 come un anno di svolta. Ancor prima dell’ingresso in guerra (avvenuto a dicembre), gli Stati Uniti avevano definito, sin dal gennaio, uno strumento importante che avrebbe rappresentato una sorta di bussola ideale, di cartina di tornasole per le potenze firmatarie: la Carta atlantica. Si riprendeva in essa lo “spirito” dell’idealismo wilsoniano del primo dopoguerra, con la riaffermazione dei principi dell’autodeterminazione dei popoli, della cooperazione per la sicurezza internazionale, della libertà di commercio e delle cosiddette libertà “dalla paura e dal bisogno”. Era su queste basi che si immaginava di definire il nuovo sistema internazionale postbellico. La Carta fu firmata inizialmente da Roosevelt e Churchill e, successivamente, da Stalin. Nel momento in cui la guerra prese le forme di una contrapposizione politico-ideologica tra fascismo e antifascismo, la Carta atlantica rappresentò (in linea teorica) il comune riferimento dell’antifascismo. Un’alleanza, con tutta evidenza, assai fragile e con molte contraddizioni ma che, tuttavia, restò in piedi sino alla fine delle operazioni militari e, in vari contesti nazionali (Italia, Francia, Belgio), alle primissime fasi della ricostruzione.
I principi espressi nella Carta diventarono poi (anche qui, non senza contraddizioni) il riferimento di un nuovo atlantismo, quello della Guerra fredda, non più segnato dalla comune matrice dell’antifascismo ma da quella (nuova e antica allo stesso tempo) dell’anticomunismo.
Immagini:
Churchill e Roosevelt
Foto di TheOtherKev da Pixabay
LETTURE
“Da cielo in terra…”
Come salvarsi la vita
di Leonarda Tola

Francesco Fioretti (1960 Lanciano, Abruzzo) ha pubblicato nel 2013 un giallo su Dante (Il libro segreto di Dante, Newton Compton), sorprendendo se stesso e l’editore per il grande successo e le 20 ristampe del libro. L’autore vanta studi danteschi, approfonditi, dopo la laurea in Lettere a Firenze, presso l’Università di Eichstatt in Germania, all’origine dei suoi molti saggi critici e dell’ultimo romanzo “Non di solo amore. La via dantesca alla felicità” (Piemme 2021).
Bisogna dire innanzitutto che il libro riguarda in senso stretto la scuola.
È la storia di Stefano Deaglio, professore di italiano e latino in una scuola di provincia (Lombardia o Marche?): la trama tocca l’attualità della scuola che mentre evoca l’eterno ritorno dei suoi riti impatta e si contamina con un presente sconvolto da novità stranianti. Lokdown, didattica a distanza e maturità 2020 comprese.
Il libro è strutturato in due percorsi distinti: 15 capitoli, dopo uno introduttivo numero 0, differenziati anche nel corsivo, raccontano la scuola e le relazioni che vi si intrecciano; alunni con nome e cognome e le disastrose biografie degli adolescenti più disastrati. La scuola dentro e al centro, per esplicita ammissione del protagonista: “Non sono mai riuscito a sgusciare fuori dall’habitat scolastico in cui sono nato e che mi accoglie da sempre come una placenta virtuale”. Sullo sfondo, l’esperienza familiare del professore alle prese con un matrimonio che pur conoscendo crisi e fallimenti trova un esito di pacificazione e ricomposizione interiore dei conflitti.
Ma il libro non è solo né propriamente questo impianto narrativo: ad intervalli nella storia, è inserito un ciclo di dodici Lezioni sul tema: “La via dantesca alla felicità”; si intuisce l’ascolto degli allievi per i quali il prof. Deaglio del romanzo (che deve tutto, mente e cuore, al Francesco Fioretti studioso) insegue Dante con una domanda: “Che cos’è la felicità?”. Il professore comincia la sua prima Lezione con la storia della parola felicità: otto pagine di etimologie e intriganti rimandi tra le lingue (latino e greco soprattutto) che spalancano squarci di comprensione e mai si fermano alla sola evidenza terminologica.
“Prima di tutto dunque le parole. Per Dante sono importantissime. Ce ne accorgiamo già leggendo l’Inferno. Il linguaggio che usano i dannati parlando col personaggio-poeta è spesso una spia rilevante della loro condizione. Le deformazioni che infliggono alla loro sintassi sono, in molti casi, tutt’uno con la colpa e la pena… Il Paradiso invece è, prima di tutto, un paradiso linguistico”.
Il prof Deaglio (alias Fioretti) spiega, versi alla mano, che “il linguaggio dei beati è espressione del loro grado di espiazione e di beatitudine” perché “la felicità e l’infelicità sono (anche) questione di lessico e di sintassi”.
“E l’amore? Se si tratta di Dante non si può fare a meno di toccare questo tema”. Prevalenti e trascinanti le Lezioni incentrate sull’amore con le citazioni dalla Commedia (ma anche il Convivio) in cui le parole amor amato-amar (Inferno Canto V di Francesca) fioriscono e sono reiterate.
È osservato a trecentosessanta gradi l’universo conoscitivo dantesco che include filosofia e teologia con le diramazioni del sapere possibili tra Duecento e Trecento. Il richiamo implicito nella parola amore è alla felicità agognata o negata perché l’altro nome dell’amore (affezione, bene, inclinazione, predilezione) è (dovrebbe sempre essere) felicità. Così come l’altro nome dell’odio (disprezzo, rancore, ostilità, indifferenza) è infelicità.
Il prof. Deaglio nelle sue 12 Lezioni accompagna il testo poetico con ineccepibili versioni in una prosa limpida che fuga tutte le ombre interpretative. Fino alla dodicesima: “L’amor che muove il sole”. Uno straordinario e atteso finale, un crescendo di consapevolezza nell’accostamento di Dante (e nostro) al mistero divino e alla sua bellezza che vince ogni comprensione umana e che “solo il suo creatore può godere appieno”.
Respingendo come assurda e inverificabile l’ipotesi che “l’universo nel quale ci troviamo ad esistere sia un’accozzaglia casuale di materia scaturita per sbaglio da un rigurgito quantistico del Niente,” Dante (e noi) ce la vediamo con Dio: “parola di tre lettere il cui significato è di troppa ampia latitudine semantica per essere afferrato da qualsivoglia mente umana”.
“Volgiti e ascolta;/ché non pur nei miei occhi è paradiso” ordina Beatrice a Dante: non solo e non tutto negli occhi dell’amata. Ogni amore è “riflesso di una verità universale, traccia di un’energia e di una bellezza trascendenti”.
Il libro di Fioretti è di quelli che si leggono più di una volta: la prima per arrivare sino alla fine, le altre per imparare e insegnare, Lezione dopo Lezione, che studiare Dante e ogni buona letteratura “salva la vita”.
Per i settecento anni a venire.
UN ANNO CON PINOCCHIO
Riprende il nostro viaggio nel mondo di Pinocchio attraverso un racconto parallelo che si è sviluppato nel precedente anno scolastico per dieci puntate e che si avvicina ormai alla sua conclusione.
Il dono di Pinocchio
di Gianni Gasparini

- Foto di Lance Cleveland da Pixabay
Il dono è una delle categorie-chiave della vita personale e di quella sociale, ben diversa dalla logica del tornaconto utilitaristico che si è imposta nelle visioni economiche e da quelle del potere, che sono dominanti nelle prospettive politologiche.
Senza aderire alla logica interpretativa del dono è impossibile – credo – arrivare al nocciolo delle Avventure di Pinocchio. Molti si sono fermati a leggere in modo utilitaristico le trame di questa fiaba archetipica che – giunti verso la fine del nostro racconto parallelo di un altro Pinocchio articolato in dodici puntate – ci pare davvero straordinaria per la sua capacità di attraversare indenne il tempo, i luoghi e le culture differenti. Insomma, per dirla alla maniera di Giorgio Manganelli, in questo racconto bisogna cercare di leggere tra le parole, o almeno tra le righe.
Secondo le interpretazioni correnti, Geppetto sarebbe un povero falegname che in una modesta prospettiva di sopravvivenza si fabbrica un burattino semplicemente per buscarsi “un tozzo di pane e un bicchier di vino” (Cap. II). In realtà Geppetto con il suo gesto creativo e fondativo, che come abbiamo visto in precedenza rappresenta una costruzione e una “poesia” (poiein), entra pienamente nella logica del dono. Dono della vita a un essere che misteriosamente verrà al mondo per opera sua; e dono dell’arte al mondo attraverso un poeta quale sarà Pinocchio.
Prima ancora di coinvolgere Pinocchio, protagonista del racconto, il dono permea i sentimenti e i comportamenti esteriori dei comprimari: non solo Geppetto, con la sua affezione fedele al figlio ribelle o dimentico del padre, ma la Fata, che lungo tutto il racconto si adopera per fare di Pinocchio, secondo l’ardente desiderio del burattino, un ragazzo in carne ed ossa. E poi vi sono altre figure che, diversamente da quelle di segno negativo, esprimono al protagonista il loro dono disinteressato: come il Colombo che trasporta in groppa per mille chilometri il burattino fino al mare dove Geppetto si è imbarcato alla ricerca del figlio (Cap. XXIII), o il Tonno che salva Pinocchio e Geppetto esausti e li porta a riva, e ancora il Grillo-parlante che cede al burattino e a suo padre giunti a terra la propria dignitosa capanna (Cap. XXXVI).
In alcuni punti del racconto collodiano molti hanno voluto leggere in modo esplicito la logica del do ut des, che in effetti la stessa narrazione richiama, come nell’episodio del cane mastino Alidoro, il quale in un primo tempo viene salvato in mare da Pinocchio mentre sta affogando e poi a sua volta soccorre il burattino che sta per essere fritto in padella dal Pescatore verde. Congedandosi, Alidoro dice “Tu m’hai fatto un gran servizio: e in questo mondo quel che è fatto è reso” (Cap. XXVIII). In realtà, Collodi aveva scritto poco prima una frase rivelatrice, annotando che Pinocchio, avendo un cuore eccellente, “si mosse a compassione”: è dunque la compassione, la misericordia il vero movente del gesto con cui Pinocchio, abilissimo nuotatore, salva il cane che lo inseguiva ed era ormai in procinto di affogare. E la compassione umana è quasi sempre la premessa del dono aperto, disinteressato e gioioso che una persona compirà verso un altro essere.
Un altro caso di apparente do ut des è quello del Tonno, quando Pinocchio uscito dal ventre del mostro marino sta nuotando con il padre a lui aggrappato e sta per soccombere. Il pesce in pochissimo tempo trasporta i due a riva e salutando il burattino gli dice di aver imparato da lui la via di fuga dal mostro, quella che lo ha portato a liberarsi; quindi, il Tonno afferma di sdebitarsi nei confronti di Pinocchio. È interessante osservare che il burattino che sta per annegare si rivolge al Tonno in toni commoventi, invocando semplicemente un gesto di aiuto e cioè di misericordia: “Tonno mio, ... Ti prego per l’amore che porti ai Tonnini tuoi figliuoli: aiutaci, o siamo perduti” (Cap. XXXVI). Ma è con Pinocchio che il dono rifulge, per così dire, nel racconto collodiano. Richiamo qui gli episodi a mio giudizio più significativi. Uno è quello della battaglia dei libri tra gli scolari in riva al mare, quando Eugenio viene ferito e rimane a terra inanimato: mentre tutti scappano, solo Pinocchio si ferma a soccorrere amorevolmente il compagno e a motivo di questo viene ingiustamente arrestato dai carabinieri (Cap. XXVII). E poi, è nel finale, nel lungo capitolo XXXVI, che possiamo vedere all’opera l’autentica capacità di dono di Pinocchio: essa si esprime anzitutto nel lavorare duramente e fedelmente al bindolo – un lavoro da animali, da asini – per ottenere come paga un bicchiere di latte al giorno da destinare a Geppetto vecchio e malaticcio. Proprio in questo frangente Pinocchio riconosce nel ciuchino morente ch’egli ha sostituito al bindolo il vecchio amico Lucignolo. Solo Pinocchio riesce a interpretare la lingua asinina e a portare un ultimo conforto al grande amico che non ha avuto come lui una Fata a proteggerlo e a consentirgli una strada di uscita dalla condizione degradata in cui entrambi erano caduti nel Paese dei Balocchi.
L’ultimo dono di Pinocchio è il più completo e il più emozionante. Il burattino sta andando al mercato per comprarsi un vestitino nuovo con i suoi quaranta soldi di rame risparmiati: incontra la Lumaca, l’antica cameriera della Fata che gli racconta la storia incredibile che la sua padrona, caduta in miseria, giace “in un letto di spedale”. Pinocchio ci crede (credulone, o uomo di fede e fiducia nell’altro?), senza pensarci un attimo consegna tutti i suoi soldi alla Lumaca per la Fata e le dà appuntamento tra qualche giorno, quando con il lavoro svolto di sera a fabbricare cesti di giunco potrà dare un altro contributo in denaro alla sua antica quasi-mamma. Ecco il dono nella sua espressione più pura: imprevisto e in grado di sovvertire progetti a lungo accarezzati, totale, senza riserve, creativo, responsabile nei confronti del futuro. A questo dono corrisponderà, non come un do ut des ma piuttosto nella logica di un altro dono, quello della Fata: essa apparirà in sogno a Pinocchio e opererà l’agognata metamorfosi del burattino in un ragazzino perbene e ben vestito, perdipiù con un borsellino ben fornito di monete d’oro.
E qui, come sappiamo, finisce la storia di Pinocchio, burattino-bambino.
RILANCI E ANTICIPAZIONI DA "SCUOLA E FORMAZIONE"
La parola agli insegnanti
di Maria Antonietta Vito
In un momento in cui il “problema scuola” è tornato ad essere materia di vasto interesse pubblico, anche in conseguenza della situazione emergenziale e di difficoltà provocata da una pandemia che ha pesato profondamente sul lavoro educativo e sui suoi risultati, ma più ancora per le prospettive di intervento e innovazione che potranno essere sostenute dal programma europeo Next Generation EU, è importante che la voce, l’esperienza e le competenze della comunità di pratica costituita dagli insegnanti e da tutto il personale scolastico vengano correttamente colte e valorizzate. Una necessità che non è nuova ma che troppo spesso — per non dire quasi sempre — è stata elusa dalla politica. Anche per questo ci sembra utile riproporre un bell’articolo della professoressa Maria Antonietta Vito che abbiamo pubblicato in Scuola e Formazione del giugno 2016.

Non vi è dubbio che la società italiana abbia un bisogno vitale di «buona scuola» e altrettanto indiscutibile è che questa, per prender vita, debba appoggiarsi a una seria volontà riformatrice da parte delle istituzioni competenti. Va però fatta una considerazione, scevra da qualsiasi polemica politica o rifiuto aprioristico: un cambiamento in profondità nel mondo scolastico, una radicale revisione del modo di insegnare, non sarà possibile se non grazie a un coinvolgimento diretto, un’assunzione del problema, da parte di chi in prima persona opera nella scuola. Questa sarà anche un’affermazione ovvia ma, di fatto, nella storia della scuola italiana un protagonismo vero dei docenti, non solo didattico, ma progettuale, capace di indicare linee d’orientamento e suggerire strategie complessive, non si è quasi mai realizzato, se non in qualche isola felice di sperimentazione ben riuscita. Questa subalternità, che genera sentimenti di marginalità, finora aggravati dal precariato, favorisce atteggiamenti di scetticismo, se non di chiusura, verso ipotesi di cambiamento sentite come estranee, in quanto calate dall’alto, e talvolta inutili o dannose.
Una sfiducia che non investe solo la classe politica e gli organi dirigenti, ma la stessa funzione docente, produce negli insegnanti una sorta di ripiegamento su se stessi, entro un orizzonte che diviene sempre più angusto, tra pesantezze burocratiche, crisi di legittimità del proprio ruolo, conflittualità con le famiglie, spesso ipercritiche tutrici dell’interesse esclusivo dei figli. Ai docenti più motivati, che si sentono coinvolti in prima per sona nel processo di formazione, resta il dato vitale della loro esperienza, il rapporto con gli alunni, fatto di trasmissione di conoscenze ma anche d’attenzione, empatia, ascolto, sostegno alle fragilità di cui ciascuno di loro è portatore.
E forse proprio da questo nucleo relazionale, rimasto integro, occorre partire per riflettere insieme, non dall’alto, ma dal basso e dall’interno, su quali siano le vere esigenze, quali i presupposti minimi, irrinunciabili, di un serio modello di «buona scuola» sul quale impegnarsi. Che la ristrettezza delle risorse investite di per sé sia un limite è scontato, ma l’ostacolo più grave è dato dalla povertà di analisi dei problemi e dalla fumosità o incoerenza di alcune proposte riformatrici. Impossibile, in poche righe, abbozzare l’agenda del cambiamento, sarebbe un’impresa velleitaria, ma una traccia minima occorrere darla.
Mi limito ad uno scheletrico quanto essenziale elenco delle questioni che mi sembrano imprescindibili. Anzi tutto, credo sia utile cominciare a interrogarsi, senza darlo per scontato, sul modello antropologico, l’idea di persona alla quale oggi gli insegnanti, entro un orizzonte pluralistico, ma non per questo indifferente ai valori, sono sollecitati a ispirarsi.
Proprio perché la visione del mondo nella nostra società non è più omogenea, il confronto tra prospettive culturali diverse si rende necessario. Ad esempio, bisognerebbe chiedersi se gli insegnanti operino solo per immettere nel mercato dei tecnici, il più possibile esperti in un certo settore, oppure se lo sviluppo del pensiero critico, la maturazione dei linguaggi, la crescita delle competenze sociali, sorretta da alcuni valori di fondo, irrinunciabili, siano ancora obiettivi primari sui quali vale la pena costruire un progetto educativo forte, distribuito su tutto l’arco della scolarità, dalla primaria alla superiore, dai licei agli istituti a indirizzo tecnico-professionale.
Un’altra questione problematica riguarda l’aggiornamento dei docenti. Possono ancora assolvere, adeguatamente, a un compito così complesso i corsi tradizionali d’aggiornamento, i cui lavori sono spesso coordinati da «esperti» portatori di modelli teorici concepiti in totale distacco dalle pratiche didattiche quotidiane e dall’interazione concreta con gli alunni?
Né appaiono occasioni migliori di scambio di saperi e delle esperienze gli organi collegiali, nei quali i docenti sono sempre più costretti a un lavoro meramente burocratico e in cui molte domande, specificamente culturali, non trovano adeguato spazio. Così, di fatto, sono eluse le questioni di fondo, quelle che metterebbero in discussione il modo stesso di fare scuola, in questo tipo di società.
Ma il confronto non accetta di essere procrastinato all’infinito. Sarebbe in primo luogo essenziale, benché tutt’altro che facile, ridefinire il rapporto tra modernità e tradizione, tra cultura umanistica di base e formazione tecnico-scientifica. Parallelamente, fra l’utilizzo delle tecnologie, sempre auspicabile, e la centralità della trasmissione diretta delle conoscenze da parte del docente, la cui figura corre il rischio di diventare sempre più sbiadita, meno attrattiva, agli occhi degli alunni.
Occorre insomma decidere se e come continuare a garantire la centralità del ruolo del maestro nel processo educativo. Inoltre, una società in rapida trasformazione, ma in grave crisi di valori, deve porsi la domanda su quali siano le nozioni irrinunciabili e quali i criteri di giudizio, ereditati dal passato, che è necessario e giusto continuare a trasmettere, traducendone il contento in linguaggi più accessibili ai giovani, e quali invece vadano considerati rami secchi, da tagliare, per lasciare spazio a «nuovi saperi». In campo strettamente cognitivo, l’impoverimento culturale della società è ormai così grave che la scuola non può illudersi di restarne illesa.
Le nuove generazioni rischiano di pagare un prezzo troppo alto se non le sollecitiamo, per tempo, a dare di più alla scuola, ma anche a chiedere di più, non in termini d’indulgenza o permissivismo, ma di rigore culturale e disciplina interiore. Farsi carico di questo vuol dire individuare vie di svolta che non ricalchino i soliti espedienti di piccolo cabotaggio né inseguano quello sperimentalismo velleitario che ha prodotto spesso solo confusione e danni. La parola agli insegnanti, dunque.
***************
Ritrovarsi
di Lorenzo Gobbi
Questo Contributo di Lorenzo Gobbi si collega al suo articolo di apertura della Rubrica Lettere alla Scuola nel numero Maggio – Agosto di Scuola e Formazione col titolo Ritrovarsi (pagina 23). In effetti era l’introduzione a tutto l’articolo e serviva a definire, in modo generale, preciso e sensibile la differenza fra l’idea di ritrovarsi e quella di ritornare. Il ritorno -precisa Gobbi- segna una cesura del tempo in cui si sente che “qualcosa si compie e qualcos’altro si inizia”. Il ritrovare, invece è “un’esperienza di congiunzione e trasformazione vitale, una resurrezione del tempo autentico e vero”. Questa idea di ri-generazione, fra il ricordo del triste e drammatico anno passato e la voglia di un rinnovamento necessario, maturo e possibile, ci sembra l’invio più bello e più giusto per il rientro che ci attende.

A fine e a inizio anno, mi tornano sempre alla mente alcuni versi del poeta Gottfried Benn, che non mi stanco di citare a me stesso e ai colleghi che come me sentono la stanchezza e faticano a nutrire in sé la speranza, così spesso delusa o contraddetta dallo sviluppo degli eventi, dagli imprevisti, dalla difficoltà a volte soverchiante delle relazioni: “Lunghe giornate. Tutto è superato. / Tu non chiedi se è fine o se è principio / e così le ore porteranno / te ancora fino a giugno con le rose”.
Ad aprile diciamo: sono tornate le rondini. A maggio ci rallegriamo perché sono tornate le rose, mentre a luglio affermiamo costernati che è tornato il caldo e sono tornate anche le mosche e le zanzare. Nulla è rimasto uguale a se stesso, eppure ci sembra che sia rimasto esattamente com’era prima, dopo un piccolo intervallo di assenza. Una rondine, per noi, vale l’altra: quelle dell’anno scorso saranno morte chissà dove e chissà quando e queste che volteggiano attorno ai tetti e ai campanili della città sono forse le loro figlie, ma a noi non importa; così, che le rose siano altre e non proprio quelle dell’anno scorso non ci sembra degno di nota perché il profumo e il colore delle rose sono gli stessi e nessuna di loro reclama il diritto di autore su ciò che offre a chiunque le passi accanto; quanto alle mosche e alle zanzare, ciascuna è molesta quanto basta ed è difficile distinguere un tratto di originalità personale nel ronzio fastidioso che ci esaspera. Raccontiamo, invece, di aver “ritrovato” un vecchio amico dopo quasi vent’anni e che nella settimana finalmente trascorsa in montagna “ci siamo proprio ritrovati”. Un ritrovamento è qualcosa di più e di diverso da un ritorno, che pure non è da disprezzare: quando torna in Italia un figlio che lavora all’estero, quando torniamo a rivedere i luoghi dell’infanzia o a insegnare nella scuola in cui siamo stati studenti, sentiamo che qualcosa si compie e qualcos’altro inizia, che il tempo vissuto subisce una svolta; però, è come se presto il divenire si arrotolasse presto su se stesso, come se tornasse sui suoi passi e si disponesse a percorrere ancora la strada che già aveva percorso ma con passo dolorosamente diverso. Sentiamo che quei luoghi non sono come li ricordavamo: vediamo che il chiostro immenso e l’atrio spazioso delle nostre ansie di adolescenti non sono nulla più che luoghi angusti, tutt’altro che luminosi e ampi; e sappiamo che il figlio fuggiasco, che il legittimo desiderio di un lavoro migliore ha spinto al di là del mare, partirà appena finite le ferie e tornerà quando potrà. La nostalgia – il “dolore del ritorno” – ha due volti che si implicano a vicenda: il desiderio struggente, da un lato; dall’altro, l’altrettanto accorata percezione che nessun ritorno, in realtà, è possibile: di ciò che è perduto, quasi nulla ci viene restituito; ciò che torna, spesso, non è che una pallida immagine di sé che presto svanisce tra le nostre braccia protese all’incontro; il tempo muore ancora una volta, ed esistono solo resurrezioni illusorie.
Ritrovare è un’altra cosa: un’esperienza di congiunzione e trasformazione vitale, una resurrezione del tempo autentica e vera, sorprendente e appagante. L’amico ritrovato ci porta un affetto imprevisto e traboccante che unisce in sé il tempo perduto e la vita presente: due sconosciuti che gioiosamente si incontrano e insieme si avviano verso un sole che sorge, verso un futuro che promette ricchezza di istanti. Tutto ci appare diverso da come l’avevamo pensato: l’inverno non sarà così triste e desolato, non si trascinerà più da un pomeriggio spento a un mattino pesante, proprio perché nell’estate “ci siamo ritrovati”; e l’amico ritrovato cancellerà con la sua presenza la solitudine che così tanto pesava su di noi, darà brio e vivacità ai mesi che verranno, agli anni che abbiamo davanti. “Ritrovare”, “ritrovarsi”: entrambi innescano in noi una fiducia istintiva – una stima del tempo vissuto: ha ancora tanto da darci, il tempo, e lo farà; saprà sorprenderci nel bene e nel giusto; sarà generoso con noi; saprà combattere per noi, schierarsi contro la tristezza e la caducità, sconfiggere il vuoto di senso e la fissità degli istanti tutti uguali, incapaci di vita liberata - fino ad ora, almeno: fino a questo “ritrovamento” miracoloso.
***************
Il dialogo fra docente curricolare e docente di sostegno.
Diario immaginario ma non troppo
di Maddalena Cavalleri
Nella sua Lettera alla scuola, proposta nell’ultimo numero di Scuola e Formazione col titolo Uno sforzo in più (pagine 29 e 30) Maddalena Cavalleri ci indica la necessità “di un cambio di passo riguardo alla cultura dell’inclusione”. Necessità e indicazioni puntuali, precise operative, un dialogo più responsabile e una collaborazione più forte, e intrecciata a diversi livelli, fra Docenti Curricolari e Docenti di Sostegno.
Quell’intervento che testimonia difficoltà e amarezza, denuncia di manchevolezze, ritardi e disconoscimento, ma anche impegno e passione, voglia e capacità di innovazione e sperimentazione, viene ripreso e si completa, qui, attraverso un immaginario ma non inverosimile dialogo tra un docente curricolare e un docente di sostegno.

Immagino – Una conversazione (tra infinite possibili) in una scuola superiore tra due docenti: docente curricolare (DC) e docente di sostegno (DS). DC è perplesso, DS lo è altrettanto ma vuole essere rassicurante.
DC: Perché un nuovo Pei? E cos’è questa cosa che dobbiamo fare almeno 25 ore di formazione obbligatorie? E non saremo nemmeno pagati…
DS: Ogni tanto degli aggiustamenti ci vogliono, sai com’è. Comunque, noi siamo già abituati a scrivere tutto in modo più che dettagliato per cui si tratta di aggiustare il tiro e di aggiornare lo sguardo e le parole.
DC: Di fatto, allora, cosa cambia?
DS: Se si è già abituati a condividere il percorso del ragazzo, non tantissimo – nella sostanza intendo – perché, in realtà, sono molte le cose nuove da rimettere in asse. Di fatto, si vuole fare in modo che nessuno se ne lavi le mani. Insomma, il ragazzo non è solo “nostro” ma è di tutti i docenti del cdc. L’eterna questione! I genitori vengono maggiormente coinvolti come il ragazzo stesso. Il percorso che la scuola propone deve essere chiaro e ben declinato. Come sai la scuola “propone”, la famiglia “dispone”. In altre parole, la famiglia può non firmarti una programmazione differenziata. Il Pei deve diventare un percorso dinamico che possa accompagnare i genitori a scegliere il meglio per il proprio figlio che va valorizzato, sempre e non mortificato a causa della disabilità. Ecco l’importanza dell’osservazione del contesto.
DC: Ho incontrato famiglie che pur davanti a limiti oggettivi del figlio non volevano firmare.
DS: Infatti. E per questo bisogna coinvolgerle ed accompagnarle. Soprattutto per quei ragazzi con disabilità grave che seguono una programmazione differenziata. Qui le famiglie sono spaventate per il futuro, e chi non lo sarebbe? Vanno accompagnate. Alle volte (così sembra), tutto era scritto ma in modo molto, troppo generico. “Legge con difficoltà" cosa vuol dire? Balbetta solo? O l’articolazione fonatoria è gravemente compromessa ma non l’aspetto cognitivo? Insomma, devi dire nel dettaglio come il ragazzo “funziona”, quali sono gli obiettivi che ti dai e quali sono quelli effettivamente raggiunti per tutte le discipline. I genitori devono essere coinvolti in tutto il processo di apprendimento.
DC: Certo, non si può andare a casaccio! E quando hai gli obiettivi minimi?
DS: Due parole da abolire (già da anni lo dicono): ora si parla di “percorso personalizzato” (con prove equipollenti) ovvero quello che va adattato nei contenuti e negli obiettivi e che dà accesso al diploma; di “percorso ordinario” (come quello della classe, nonostante qualche adattamento dovuto alla disabilità che va ben segnalato); e poi c’è il “percorso differenziato” – il solito di sempre come concetto – che non segue gli obiettivi della classe, che può prevedere l’esonero da alcune discipline.
DC: Un po’ come era prima…
DS: Ni. Un po’ di sforzo lo dobbiamo fare…
DC: Comunque, quando un ragazzo grave non può seguire la programmazione di classe, abbiamo sempre cercato di creare un legame con ciò che i compagni fanno a scuola.
DS: Sì, anche se a volte ci vuole molta fantasia! Se il ragazzo non è in grado di fare, che ne so, ragioneria, gli farai fare delle attività adatte all’autonomia della sua vita. A volte, alcuni docenti scrivevano per aree e non per disciplina, soprattutto alle elementari, da quel che ho capito… Anche imparare a scegliere i soldi per prendere la cioccolata alla macchinetta può essere utile. Basta che sia coerente al suo percorso e che abbia un senso.
DC: Certo, come abbiamo sempre fatto. Il problema, però, si pone soprattutto per quei ragazzi che sono tra un percorso personalizzato e differenziato.
DS: Già, come quando hai un Pei con obiettivi misti per assecondare le difficoltà del ragazzo. È qui che possono nascere i fraintendimenti. Il percorso deve essere chiaro, anzi chiarissimo sin dagli inizi e condiviso con la famiglia e con lo stesso ragazzo, perché non sempre egli è in grado di passare al percorso personalizzato, che dà accesso al diploma. Insomma, il nuovo Pei cerca di creare un maggior coinvolgimento di tutti. Il nuovo Pei si propone, da quel che ho percepito, di far fare un salto di qualità alla cultura dell’inclusione. Cambiare lo sguardo, l’uso delle parole. Aiutarci a mutare l’osservazione del contesto, tutti i tipi di contesto con barriere e facilitatori (altre parole chiave). Vuole che facciamo nostra la prospettiva bio-psico-sociale. E molto, molto altro.
DC: Immagino, immagino, basta che questo non ci arrivi sulla testa tra le mille altre cose. A dirla a chiare lettere – qui nessuno ci sente – a non dover chiedere di cambiare classe causa presenza alunno L. 104. La dico grossa? Ma se la mole di lavoro aumenta, quale può essere la reazione immediata di noi docenti? E poi non c’è già l’alternanza scuola lavoro?
DS: Pcto. Già mi viene l’ansia… Se poi penso ai ragazzi delle seconde…
DC: Cosa?
DS: Niente te lo dirò alla prossima…
DC: Un sogno sarebbe che ci venisse riconosciuto questo sforzo in più, perché ci vuole tempo. Ho sempre lavorato con i colleghi di sostegno che mi sono capitati ma mi sembra che qui ci chiedano un ulteriore impegno. Mah. Ho qualche perplessità, a dirla tutta. Il lavoro aumenta sempre di più…
DS: Le perplessità non mancano ma bisogna riconoscere che a volte c’è stata carenza di risorse e a volte, però, c’è stato anche spreco. Di cose da migliorare ce ne sono molte, penso non sia facile, questa volta, nemmeno per il legislatore.
DC: Di certo, non lo è per noi! Almeno per chi ha sempre lavorato! Porta pazienza…

