
In questa pagina:
Cose da fare: Che sia una buona estate (Maddalena Gissi)
Ricorrenze/1: 2 giugno: con uno sguardo e un ricordo legato alle donne (Emidio Pichelan)
Ricorrenze/2: 10 giugno 1940: un ricordo balilla (Luciano Corradini)
Con altro sguardo: Quello che ci aspetta, uno sguardo oltre il Covid (Daniele Mencarelli)
Storia contemporanea: 1931 La repubblica spagnola e le ripercussioni in Europa (Paolo Acanfora)
Hombre vertical: A pochi chilometri da Firenze c’è un paesino … (Emidio Pichelan)
La poesia dei luoghi: Sestri Levante (Gianni Gasparini)
Letture: Tratta Napoli - Modena (Leonarda Tola)
Sul filo del tempo: Il sole uccide le idee (Mario Bertin)
Un anno con Pinocchio: La fame, il lavoro, il denaro (Gianni Gasparini)
Scrivici, se vuoi, a redazione@cislscuola.it
COSE DA FARE
Che sia una buona estate
di Maddalena Gissi

Chiudiamo con questo numero gli appuntamenti mensili della nostra Agenda 2020/21, con i quali abbiamo seguito lo svolgimento di un anno scolastico che speravamo fosse meno tormentato, ma che invece ci ha visti ancora alle prese con un’emergenza pandemica lunga e dolorosa, con riflessi di non poco conto sull’organizzazione delle attività didattiche e in generale sulla gestione del nostro lavoro. Ora ci attendono i mesi estivi, che non saranno tuttavia un periodo di rilassamento, riposo e svago, come pure sarebbe legittimo attendersi. Non lo furono lo scorso anno, quando il personale della scuola, a partire dai dirigenti, spese molto del suo tempo per predisporre le condizioni di un ritorno in sicurezza alle attività in presenza, spesso dovendo farsi carico anche di insufficienze e latitanze di altri soggetti, il cui mancato apporto ha in qualche caso vanificato, almeno in parte, gli sforzi compiuti.
I buoni risultati che la campagna vaccinale sta producendo lasciano ben sperare in un ritorno alla normalità nel prossimo autunno, e si fa concreta la speranza di un anno scolastico finalmente in presenza per tutti, non solo per le fasce di età più bassa. Ma intanto saranno molte le scuole impegnate a realizzare, in proprio o in collaborazione con altri soggetti operanti sul territorio, progetti finalizzati al potenziamento delle competenze e della socializzazione, per i quali è stata resa disponibile una consistente quota di risorse; quelle attività che sbrigativamente sono state spesso definite come “recupero del tempo perso”, espressione infelice che induce a misconoscere, o quanto meno a sottovalutare, il grande lavoro che il personale della scuola si è sobbarcato nei mesi della pandemia, quando la sospensione delle attività in presenza non ha certo comportato un abbassamento del livello di impegno e di fatica. Confermo al riguardo il giudizio che avevo espresso sul Piano Scuola Estate 2021 al momento della sua presentazione: è stata una decisione saggia e opportuna quella di consegnare all’autonomia scolastica il compito di valutare se e quali attività svolgere nei mesi estivi (ma anche in quelli seguenti, come è stato chiarito), alla luce di un fabbisogno non definito dall’esterno e in astratto, ma concretamente rilevato e valutato da ogni singola scuola. Puntando sulla volontarietà di adesione (sia per gli operatori che per gli utenti delle attività) si è fatta giustizia, nel modo più ragionevole e sensato, rispetto alle tante banalizzazioni dette e scritte su un allungamento generalizzato e obbligatorio del calendario scolastico, che avrebbe complicato i problemi anziché risolverli. Ho valutato positivamente, e lo ribadisco, l’opportunità che il Piano offre di sperimentare, o consolidare laddove già ve ne sia esperienza, il coinvolgimento di altri soggetti nella progettazione di attività condivise nell’ottica dei patti di comunità, fondati su una rafforzata alleanza educativa tra scuola, famiglia e società civile.
Per la CISL Scuola i mesi estivi sono sempre stati un periodo di attività particolarmente intensa, essendo quelli nei quali si svolgono adempimenti fondamentali per predisporre l’avvio del nuovo anno scolastico: quello che correntemente si definisce (e si auspica) come “regolare”, ma che troppo spesso rimane tale solo sulla carta. Non c’è bisogno di spendere troppe parole per dire che non ci possiamo permettere il ripetersi di quanto avvenne l’anno scorso, con ritardi clamorosi nella copertura delle cattedre e posti rimasti scoperti fino a novembre e oltre. Completare in tempo utile tutte le operazioni di nomina sulla marea di posti scoperti è perciò la prima condizione da assicurare perché si possa immaginare una partenza a pieno regime fin dal primo settembre.
Sempre nell’ottica di garantire un ottimale funzionamento del servizio, avevamo chiesto scelte forti e decise per una drastica riduzione del lavoro precario, puntando a stabilizzare una quota quanto più possibile ampia degli oltre duecentomila contratti a tempo determinato cui si è fatto ricorso quest’anno. Non con improvvisate “sanatorie”, come ci accusavano di voler fare, ma semplicemente prevedendo procedure che in modo trasparente e oggettivo valorizzassero l’esperienza di lavoro acquisita, in coerenza col modello di reclutamento a due canali che la CISL Scuola sostiene e propone. La scelta di utilizzare le GPS come graduatoria per possibili assunzioni in ruolo potrebbe in sostanza costituirne un’anticipazione.
Le misure sul reclutamento contenute nel decreto legge “sostegni bis”, non tutte pienamente coerenti con le indicazioni e gli impegni contenuti nel “Patto per la scuola al centro del Paese” (finalmente sottoscritto a Palazzo Chigi il 20 di maggio), ci lasciano perplessi e per alcuni aspetti in netto dissenso. Troppo limitate le possibilità di utilizzo delle GPS, col rischio di replicare il flop delle assunzioni dell’anno scorso; discutibili o sbagliate le misure che, senza il minimo confronto, delineano una disciplina dei futuri concorsi ordinari per la docenza su cui vi è molto da eccepire, a partire dall’incredibile divieto di partecipare a un nuovo concorso per chi non abbia superato le prove del precedente. Rivendicare, attraverso opportuni emendamenti, le necessarie modifiche a quel decreto costituisce pertanto una delle più impellenti cose da fare nei due mesi entro i quali le Camere dovranno provvedere alla sua conversione in legge.
Un primo appuntamento importante è già fissato per il 3 giugno, quando si avvierà col Ministero il tavolo sul reclutamento previsto dal Patto: un tema cruciale, alla luce di quanto il decreto “sostegni bis” contiene sull’argomento e delle sostanziose correzioni da apportare al provvedimento, per noi assolutamente indispensabili.
La posta in gioco è alta, perché il rischio è di vedere compromesse alla radice le potenzialità di un Patto la cui attuazione può segnare una svolta attesa da tempo, riportando la scuola al centro di una strategia di forte investimento e di crescita. Non sarà un’estate di riposo, la speranza è che sia comunque, alla fine, una buona estate.
CON ALTRO SGUARDO
Quello che ci aspetta, uno sguardo oltre il Covid
di Daniele Mencarelli

Da più parti s’inizia a intravedere, finalmente, un giorno nuovo. Una ripartenza oltre questa Pandemia di Covid-19 che ha inciso indelebilmente l’ultimo anno e mezzo della vita di un pianeta intero. Primo vero evento globale della storia umana, o meglio, il prima dopo la rivoluzione digitale avvenuta negli ultimi anni.
Quando si scommette sul futuro, i rischi di valutazione sono tanti e temibili. In primis quella naturale tendenza che vive in ognuno di noi e che ci fa propendere, in maniera più o meno evidente, verso l’ottimismo o il suo contrario. E il pessimismo, si sa, è disciplina ben più frequentata rispetto a chi tenta di vedere il bicchiere sempre e comunque mezzo pieno.
Ma una visione di ciò che ci aspetta dopo il Covid dobbiamo iniziare a costruircela, anzi, forse siamo già in ritardo.
Un dato colpisce in modo preoccupante, per coglierlo non c’era nemmeno bisogno di attendere la fine agognata del virus.
Il distanziamento sociale a cui ci ha obbligato il Covid, realizzato attraverso attività da svolgere nella propria abitazione, dal lavoro alla scuola, rischia di rimanere un’eredità strutturale rispetto alla nostra esistenza.
La scuola, per fortuna, vede nella reazione dei ragazzi che aspirano alla presenza una forma di lotta e partecipazione che andrà a contrastare in modo spontaneo e pacifico chi vorrebbe mantenere il distanziamento.
Molto più difficile andare da un imprenditore, una grande azienda, un ente pubblico, e perorare la causa del lavoro in presenza. L’enorme crisi economica scatenata dalla Pandemia rende sin troppo facile il gioco di chi vorrà mantenere, stabilizzare, l’enorme fetta di lavoro in smart working. E come obiettare? Cosa dire a un industriale sull’orlo del fallimento che vuole, deve, abbattere i costi di gestione delle sue attività. Perché che il lavoro agile sia per le aziende una panacea c’è poco da discutere.
Ma quali sono i rischi? Quale cambiamento, sociale, antropologico, porta con sé questa rivoluzione vera e propria?
Per rispondere basta girare le nostre città, i tanti quartieri che ospitano centinaia, migliaia di uffici, attività professionali di ogni tipo.
Non è un film apocalittico, ma in pericolo è il concetto stesso di polis.
Luogo dove incontrarsi e fare comunità attraverso i gesti del vivere comune. Tra gli altri, in posizione dominante proprio il lavoro. I lavori.
Interi quartieri si svuoteranno di vita e di ogni forma di interesse commerciale, commercio già messo in ginocchio dagli store online. A chiudere non saranno più i piccoli negozi di abbigliamento e simili, già in buonissima parte chiusi da tempo, ma tutte quelle attività che lavoravano sul territorio puntando all’esercito di impiegati ogni giorno affollavano la zona, pensiamo solo alla ristorazione, ai tanti bar che per anni hanno vissuto accanto ad uffici pubblici o privati.
Oggi le grandi città, almeno alcuni quartieri, sembrano luoghi fantasma, dove sopravvivono reperti di un’epoca umana passata, come i centri commerciali oramai anacronistici, i tanti uffici vuoti, affollati solo di server dove scorre il lavoro degli umani rinchiusi nelle loro case.
Sembra la trama di un film apocalittico. Questa volta sì.
RICORRENZE/1
La nascita della Repubblica
2 giugno: con uno sguardo e un ricordo legato alle donne
di Emidio Pichelan

Panta rei, tutto scivola, la catastrofe come la gioia come quei momenti drammatici in cui l’essere umano è chiamato a scegliere, a schierarsi. Girare la testa dall’altra parte o adagiarla sotto la sabbia non allevia di un gramo la responsabilità singola e, tanto meno, quella collettiva. Capire, poi, il comportamento del singolo e della collettività è ancora un’altra cosa: a questo proposito, annota Eric J. Hobsbawm, “la maggior parte degli esseri umani si comporta come lo storico: riconosce la natura della propria esperienza solo alla fine, retrospettivamente”.
È questo il compito dello storico: ravvivare la memoria, massaggiarla come si fa con i muscoli, disseppellire il passato – selezionandolo –, comprendere le ragioni che hanno presieduto alle scelte umane, raccontare quanto accaduto. Perché la vita umana non è solo un presente piano e, magari, patinato. È questo il compito anche delle feste nazionali che invitano a ricordare da dove veniamo, quali siano stati l’humus e le radici che hanno permesso la fioritura di semi e il riapparire di fiumi e flussi carsici così numerosi e fecondi nella storia umana.
Il 2 giugno di 75 anni fa appartiene a un ingorgo di date e di avvenimenti fatali, nel senso di svolte storiche: il 25 luglio e l’8 settembre del 1943, il 25 aprile del 1945, il 2 giugno del 1946 – appunto – e il 18 aprile del 1948. Date e avvenimenti tutti – caduta di Mussolini ad opera del Gran Consiglio, cambio di alleanze militari in un conflitto in corso, definizione del sistema economico e politico e sociale e dei rapporti di forza tra gli attori della nuova Repubblica – imprescindibili per definire i tratti salienti della fisionomia della nuova Italia.
A proposito di uno di questi nodi cruciali, l’8 settembre, Luigi Meneghello, un venerato maestro non valorizzato quanto meriterebbe, descriveva la posta in gioco e il groviglio di domande che assediavano le teste delle donne e degli uomini alle prese con i nodi impigliati nel pettine di cui sopra con le seguenti parole dalla valenza generale:
“C’era la sensazione di essere coinvolti in una crisi realmente radicale, non solo politica ma quasi metafisica. […] Bisogna pensare che il crollo del fascismo (che ebbe luogo tra il ’40 e il ’42, dopo di allora era già crollato) era sembrato anche il crollo delle nostre bravure di bravi scolari e studenti, il crollo della nostra mente. […] Che cos’è l’Italia? Che cos’è la coscienza? Che cos’è la società? Tutto pareva che fosse quasi un nodo e questi nodi venivano al pettine”.
(L. Meneghello, I piccoli maestri, la prima edizione è del 1964)
È il secolo intero, nel racconto di Eric J. Hobsbawm, a rivelarsi come breve (75 anni, dallo scoppio della Grande Guerra alla Caduta del Muro) e degli estremi (The Age of Extremes è il titolo originale del saggio dello storico inglese, tradotto con la fortunata espressione di “Il Secolo breve”): un’epoca di cambiamenti radicali, di rotture e discontinuità in tutti i campi. Stato, società, economia, cultura, diritti, movimenti sociali.
Il 2 giugno si ricorda la celebrazione di un referendum sistemico – Monarchia/Repubblica – e di un’elezione di assoluta eccezionalità: l’Assemblea Costituente. Nell’immaginario collettivo, un giorno indissolubilmente abbinato al volto giovane dal sorriso illuminato a giorno dal biancore di denti immacolati – un riuscito “sorriso Colgate” –, i capelli nerissimi di accurata pettinatura della ventiquattrenne Anna Iberti che sbuca da una pagina del Corriere della Sera, incoronata dal titolo giornalistico a nove colonne: “La nascita della Repubblica”.
Quel giorno, 13 milioni di donne e 12 milioni di uomini – la guerra incideva direttamente sul gap tra femmine e maschi –, equivalenti all’89,08% dei 28 milioni di italiani aventi diritto, si recavano alle urne per mettere una duplice croce: su una scheda semplice come l’evangelico Sì Sì/NO NO, e su una seconda scheda più complicata, affollata di simboli di partito e di nomi di candidati. Altissima, senza appello la posta in gioco: si trattava di scegliere tra continuità e discontinuità, tra conservazione e innovazione, tra l’accontentarsi di continuare a calpestare le vecchie orme o di avventurarsi, ebbene sì, un po’ alla cieca, su un tratturo tutto da inventare, fidandosi – nel secondo caso – dell’invito del gentile poeta andaluso di nome Antonio Machado: Caminante no hay camino, el camino se hace al andar. Viandante non c’è tratturo davanti a te, la strada te la fai tu mettendo un piede davanti all’altro.
Una scommessa acrobatica, senza rete. I maschi italiani non votavano da più di vent’anni; l’ultima volta risaliva al lontano 1924, erano state consultazioni celebrate in un clima incandescente di violenze impunite (una routine politica vecchia di almeno un paio d’anni) e di brogli spudorati, le une e gli altri denunciati dall’aristocratico e coraggioso Giacomo Matteotti, parlamentare e segretario del partito. Per il coraggio delle denunce nell’aula parlamentare – come si dovrebbe in democrazia –, rapito e ucciso e seppellito frettolosamente tra le sterpaglie di un boschetto fuori mano.
Il Paese del futuro si affidava a decisori piuttosto vergini al gioco impegnativo e responsabile della democrazia. Impensabile che ci fosse stato il tempo, nel brevissimo lasso intercorso dal maggio del ’45, fine delle ostilità, e l’apertura delle urne, per rielaborare anche uno solo dei nodi gordiani citati più sopra. Si chiamava ricostruzione, voleva dire rimettere in piedi un Paese letteralmente distrutto, collassato: ferrovie inutilizzabili, strade impraticabili, porti bombardati, commerci da ripristinare, fabbriche da rimettere in piedi e/o da riconvertire, sanità da riattivare, tasse da riscuotere, macchina statale da rimettere in moto … Su un panorama cupo di suo, incombeva la paura delle paure: della bomba atomica che H. Truman, il Vice Presidente succeduto al Presidente F.R. Roosvelt passato a miglior vita – così si diceva allora –, aveva deciso di sperimentare su Hiroshima e su Nagasaki il 6 e il 9 agosto del ’45. Gli stessi americani se n’erano tanto spaventati da nascondere per decenni le foto raccapriccianti del micidiale fungo velenoso. Nell’arena politica, mentre declinavano le fortune del Partito d’Azione, si ingrossava impetuosa l’onda suscitata dall’Uomo Qualunque: lasciateci in pace, strillava sarcastico il movimento qualunquista, la politica è sporca (evidentemente, uno slogan di successo duraturo), è malaffare, abbiamo altro a cui pensare, le energie rimasteci – poche, flebili – le riserviamo al nostro, privato interesse.
“Come allora, staremo di sentinella
perché nell’alba non ci sorprenda il nemico.
Quale nemico? Ognuno è nemico di ognuno,
spaccato ognuno dalla sua propria frontiera.
La mano destra nemica della sinistra.
In piedi, vecchi, nemici di voi stessi:
la nostra guerra non è mai finita”.
(P. Levi, Partigia, 23 luglio 1981)
Le sentinelle non si erano addormentate, le donne in fila ordinata, i capelli a posto, le giovani – pudiche assai – con le camicette bianche inamidate e le bluse abbottonate ma rigorosamente – come da raccomandazione – senza rossetto e senza smalto sulle unghie per non inficiare il voto, le donne mature e di un certa età rigorosamente in nero, dalle mie parti – le terre basse venete – molte si erano consigliate con i parroci e i cappellani, allora gli uomini di chiesa godevano d’un prestigio a prova di scandali e di condotte inappropriate, erano santi ed erano colti, sapevano il latino e benedivano i campi e i raccolti, andavano a consulto dal parroco anche le mogli dei comunisti e dei socialisti e dei mangiapreti, il marito è il marito ma il prete bazzica con il sacro, si prende cura dell’anima, lo spirito vale pur sempre molto di più della carne, e poi è suo dovere prendersi cura delle sue pecorelle fino a mettere in pericolo la sua stessa vita.
Vinceva la Repubblica con uno scarto di due milioni di voti, l’Assemblea Costituente individuava il Gruppo di 75 (tra cui 5 donne) che in 17 mesi scrivevano il testo della nuova Costituzione repubblicana. Evidentemente un buon testo se è riuscito a sopravvivere ai venti e alle maree e agli ingorghi – non mancano mai nella storia umana – e ai cambiamenti degli ultimi, sorprendenti settant’anni.
Più che alle acrobazie delle Frecce tricolori che si divertono, il 2 giugno, a portare a spasso per i cieli nostrani linee azzardate e figure spericolate, inseguiti dagli sgargianti colori della bandiera nazionale, la riflessione storica non può che focalizzarsi sul voto femminile. Una vera rivoluzione pacifica che si portava in dote una storia gonfia di lotte e di traguardi da conquistare. Le sentinelle del 2 giugno non si lasciarono sorprendere dal nemico, allertate da sempre. Sotto i cieli più diversi e incredibili.
Sentite questa e sorridete. Il 9 febbraio del 1906 si riuniva la Commissione elettorale di un piccolissimo comune – meno di 2000 anime – sul Bacchglione, tra Padova e Venezia. Con l’obiettivo di rivedere le liste elettorali politico-amministrative. Si chiamava – e si chiama – Pontelongo quel paesello, lo guidava un signore chiamato Luigi Ostani, fittavolo dei signori Da Zara, latifondista, di professione faceva il sensáe, il mediatore, andava per aie e fattorie, comprava e vendeva paglia e fieno e semi con una semplice stretta di mano, un gesto che contava tanto quanto se non di più di una firma in calce a un assegno. Alla fine governerà il suo paesello per trent’anni filati, piagato – come il territorio circostante – dalla pellagra, dall’alcolismo, dall’analfabetismo e dall’emigrazione. Almeno fino a uno sgargiante 26 giugno 1910 – quattro anni dopo quello che stiamo raccontando – quando aprirà i battenti uno zuccherificio che assomigliava molto a un’arca di Noè (per la cronaca ancora in funzione, uno dei pochissimi salvati dalla strage di zuccherifici italiani degli anni Novanta). Quel 9 febbraio del 1906 il nostro umile eroe voleva mettere in lista i nomi di sei donne: “è una lacuna che riesce indispensabile riempire per dar campo pure al sesso femminile di esplicare la sua attività in una sfera d’azione che esula dal tetto domestico, ma si estrinseca nella vita politica”. Tempi prematuri, se così si può dire, mancavano quarant’anni al 2 giugno del 1946. Luigi Ostani non si dava per vinto al primo ostacolo, ricorreva alla Commissione provinciale di Padova, prima, e alla Corte d’Appello di Venezia: si può negare, scriveva nell’istanza di accompagnamento per la revisione del rigetto della revisione proposta, il suffragio alle donne “senza manifesta ingiustizia tanto più che una maggior e più razionale attività delle donne non importa certamente un abbassamento delle sue condizioni rispetto alla famiglia ma significa invece una migliore coscienza di educatrici e di compagne che le donne acquistano a vantaggio della società come mogli, madri, come conforto e gioia della vita”.
Politicamente parlando, l’Ostani era un eterodosso, un seguace di Romolo Murri. Non è noto, ma nulla vieta di pensare che anche a Pontelongo, il paesello sul Bacchiglione, arrivasse una stampa impegnata, poniamo “Critica Sociale”. Come noto, per il voto delle donne si batteva da tempo quella straordinaria figura di donna emancipata, origine russa e studi filosofici e di medicina tra Zurigo, Berna, Torino e Padova, divorziata da Andrea Costa, il primo socialista ad arrivare in Parlamento (per questo bollato, dai suoi, come “traditore”) e successivamente compagna di vita, di idee e di ideali e di impegno politico con il secondo marito, Filippo Turati. Ma, come pure noto, del voto alle donne il grande capo del riformismo socialista italiano non ne voleva sentir parlare: non interessava a nessuna (delle donne), diceva e continuava imperterrito nella perenne disquisizione dei diritti sindacali.
Le donne non dovevano votare, diceva con un gioco di parole Papa Sarto, San Pio X, veneto anche lui, ma “votarsi a una causa superiore”. “Lo dise anche lo Spirito Santo che la dona forte l’è quela che fila el lin. E quelo che è necessario l’è che la dona la resta sempre sotomesa, non la meta su arie”, spiegava ancor meglio lo stesso Pio X a Elena da Persico in un colloquio del maggio di quello steso 1906 (L. Gazzetta, “Elena da Persico”, Cierre Edizioni, pag. 86, nota 3).
Non c’è un happy end in questa piccola storia: l’istanza avanzata da Luigi Ostani veniva respinta sia dalla Commissione elettorale della provincia di Padova (27 aprile 1906) che dalla Corte d’Appello di Venezia (14 e 19 luglio 1906), in nome e per conto delle argomentazioni dell’ex guardasigilli (e futuro Presidente del Consiglio) Giuseppe Zanardelli, autore della riforma elettorale del 1882 (di 24 anni prima!): “la donna vince veramente l’uomo e per le quali è ammirata e ammirabile, virtù di tenerezza, di passione, d’impeto, ma che traggono nascimento dal fatto incontrastabile che in esse prevalgono il cuore alla mente, l’immaginazione al raziocinio, il sentimento alla ragione, la generosità alla giustizia, quelle stesse virtù non sono quelle che ai forti doveri della vita civile maggiormente convengono”.
Da una parte, le virtù “maschili”: la mente, il raziocinio, la ragione, la giustizia; dall’altra, quelle “femminili”: il cuore, l’immaginazione, il sentimento, la generosità. Era l’umanità a essere divisa in due parti, diverse e complementari ma non uguali. Le “regnicole”, cioè abitanti del Regno d’Italia, come le chiama la sentenza di rigetto del ricorso del sindaco Ostani, saranno pur “capitaliste”, autosufficienti, produttive, soggetti attivi e impegnati nella professione, ma non potevano fare politica: un sostantivo femminile che, per essere esercitata, richiede virtù maschili. Soprattutto – ma questo è più sottinteso che esplicitato –, il potere è maschile e i maschi non avevano nessuna intenzione di rinunciarci, come denunciato, in una celeberrima conferenza al circolo filologico di Milano il 27 aprile del 1890 da Anna Kuliscioff, la “dottora dei poveri”.
Battaglia persa, dunque, quella di Luigi Ostani? Non proprio, le vie del Signore e della storia sono – spesso – carsiche e intriganti: succedeva, infatti, che quarant’anni dopo, in occasione del 2 giugno 1946, nella Provincia di Padova, unica eccezione tra le Regioni del Nord indubbiamente repubblicane, prevalessero i voti per la Monarchia. Nonostante l’impegno antifascista della città e, in particolare, della Università, in prima linea sul fronte della Resistenza per la Liberazione, per questo insignita della Medaglia d’oro al valore militare. Ma a Pontelongo vinceva la Repubblica con il 63% dei voti.
Ben scavato, vecchia talpa, avrebbero detto i nostri antenati: la crosta terrestre del presente viene scossa e mossa da spiriti e forze che agiscono nel sottosuolo. Vengono da distante e lontano vanno. Come evidente, di vecchie talpe e di sentinelle vigili l’umanità ha avuto e ha sempre bisogno: per uscire dagli ingorghi, andare avanti, cambiare lo stato presente delle cose.
RICORRENZE/2
L’Italia entra in guerra. Parte da lì il ricordo/riflessione di Luciano Corradini per riportarci a leggere impegni da assumere oggi.
10 giugno 1940: un ricordo balilla
Linguaggio e retorica nell'educazione degli anni Quaranta
di Luciano Corradini

In uno dei webinar che hanno cercato di sostituire o d’integrare, con alterne fortune, gli incontri scolastici di studenti e docenti durante il recente lockdown anti-Covid, sono stato invitato dal Collegamento studenti Monza Consonni, a parlare dei miei ricordi del tempo di guerra, a cominciare dal fatidico 10 giugno 1940, quando avevo poco meno di 5 anni e frequentavo, a Castellazzo di Reggio Emilia, la seconda elementare, per meriti speciali, dato che ero figlio della maestra.
Una delle sere di quel giugno gli adulti di casa mi portarono a vedere, dalla finestra del bagno, un cielo illuminato di notte, che mi spaventò, perché si diceva che sarebbe scoppiata la guerra. Seppi poi che si trattava di un’aurora boreale, ma allora ero terrorizzato dall’invasore, tanto che mi misi a correre col cuore in gola, quando venne un frate a chiedere l’elemosina.
Per incoraggiarmi, quando mi sbucciavo un ginocchio, mi dicevano che non dovevo piangere, ma imitare quell’«intrepido Balilla che sta gigante nella storia», di cui si cantava in classe, aggiungendo «ai nemici in fronte il sasso, agli amici tutto il cuor».
Del resto avevo anch’io la divisa da piccolo soldato di Mussolini. In casa mia avevamo un portacenere regalatoci da uno zio su cui era scritto: «Molti nemici molto onore». Evidentemente bastava solo un cuore per gli amici, ma per i molti nemici occorrevano molti sassi. I nemici erano sia quelli interni, i socialisti, che «bruciavano i campi di grano», come era scritto in un libro di lettura (e sui muri c’era un manifesto minaccioso: «Taci! Il nemico ti ascolta»), sia quelli esterni, che stavano al di là delle Alpi. In particolare erano gli inglesi, guidati dal ministro Ciurcillone, una specie di Gambadilegno col sigaro, personaggio del giornalino «Il Balilla», che dovevamo comprare a scuola, al costo di mezza lira. Mia madre cercava di commuoverci leggendo il libro Cuore, ma due amici più grandi di me mi associarono ad un progetto segreto che prevedeva la costruzione di una bomba fatta con capocchie di fiammiferi, che sarebbe esplosa sui binari per far deragliare un treno. Il resto lo avrebbe fatto il padre di questi Lucignoli, che, dissero, aveva una pistola.
Un mio cugino mi propose una gara più simbolica e meno cruenta: sfidarsi a chi mangiasse più in fretta il risotto. Questo rappresentava gli inglesi, il piatto bianco gli italiani; e il vincitore, con la forchetta alzata, avrebbe cantato vittoria. Del resto cantavamo «Vincere, vincere, vincere, e vinceremo in cielo in terra e in mare: è la parola d’ordine di una suprema Volontà».
Nella nostra tessera della Gil, Gioventù italiana del Littorio, c’era scritto: «Nel nome di Dio e dell’Italia giuro di eseguire senza discutere gli ordini del Duce e di servire con tutte le mie forze e se è necessario col mio sangue, la causa della Rivoluzione Fascista». Oggi il sangue si pensa di darlo all’Avis per salvare le vite, non a un Duce per perdere le guerre. E sappiamo che molti nemici vuol dire molti pericoli e molta miseria: perciò la Scuola di Barbiana ha sostituito il «me ne frego» col «me ne importa».
Martin Luther King ha scritto che l’unica forza che può trasformare un nemico in un amico è l’amore. Il futuro (anche la cronaca lo insegna) non sta nei bianchi che soffocano con un ginocchio un nero, come ha fatto negli Usa un poliziotto con George Floyd, divenuto un’icona dei diritti umani, ma nei bianchi e nei neri che s’inginocchiano di fronte alle vittime, per cambiare il cuore e la mente di chi pensa la salvezza come liquidazione degli avversari reali o presunti.
Il futuro non sta nel «prima gli americani, gli italiani, i brasiliani, gli ungheresi… e gli altri si arrangino, perché l’importante è che ci salviamo noi»; ma nel selezionare gli amici per farsi nuovi amici, nella prospettiva voluta dalla Dichiarazione universale dei diritti dell’Onu, in modo che ciascuno si senta il più possibile «a casa sua», «in spirito di fratellanza», nell’unica Terra che abbiamo. Oltre che un principio etico, questa sta diventando un’evidenza empirica.
STORIA CONTEMPORANEA
Ogni mese, con interventi affidati allo storico Paolo Acanfora, si propone la rilettura di alcuni avvenimenti o temi della vita italiana e internazionale che si ritengono particolarmente rilevanti ai fini della comprensione della storia contemporanea.
Si tratta di una serie di contributi occasionati da anniversari le cui date sono individuate ripercorrendo, con cadenza decennale, un vasto arco di tempo che parte dal 1901. In questo mese è la volta del 1921.
1931 La repubblica spagnola e le ripercussioni in Europa
di Paolo Acanfora

Le vicende storiche spagnole hanno rappresentato un aspetto centrale della storia europea del Novecento. Nonostante la marginalità della Spagna nella cerchia delle grandi potenze europee, frutto di un lungo e progressivo declino nel passaggio dall’età moderna all’età contemporanea, le crisi internazionali che hanno portato l’Europa al collasso della seconda guerra mondiale passarono, in modo significativo, anche per la questione spagnola. Per capire la portata di questi eventi occorre fare innanzitutto riferimento alla fine della dittatura di Primo de Rivera (iniziata nel 1923 e fortemente sostenuta da Alfonso XIII) che preluse alla fuga del re e alla instaurazione della Repubblica nel 1931. Furono i successi dei partiti repubblicani e democratici a spingere verso questa soluzione, in una nazione che – come, d’altronde, molte altre in quegli anni – aveva palesato una strutturale fragilità del suo sistema democratico e parlamentare. La fine della dittatura ed il successo delle forze progressiste sembravano poter avviare un nuovo processo di democratizzazione che, tuttavia, si infranse dopo soli 5 anni in virtù dello scoppio di una drammatica e sanguinosa guerra civile.
In realtà, dal 1931 al 1936 la democrazia spagnola era risultata tutt’altro che stabile. Già nel 1932 si era tentato un colpo di stato autoritario mentre a sinistra la componente anarchica (di gran lunga la maggiore) aveva insistentemente sollecitato moti di piazza ed azioni condotte soprattutto contro i proprietari terrieri (in una Spagna, val la pena di notare, in larghissima parte agricola). La situazione ebbe una svolta con le elezioni del febbraio del 1936. L’anno precedente l’Unione sovietica di Stalin aveva lanciato, attraverso il Comintern, un’inedita politica di unione con le forze progressiste borghesi che sarebbe sfociata nella costituzione di fronti popolari (l’alleanza di tutte le forze progressiste nei diversi paesi). Alle elezioni spagnole di febbraio il fronte vinse creando, da una parte, aspettative rivoluzionarie nelle masse proletarie e, dall’altra, una reazione nei ceti imprenditoriali, nei proprietari terrieri, nel clero. Fu così che a partire soprattutto dal luglio dello stesso anno la situazione si radicalizzò in modo irreversibile avviando una vera e propria guerra civile tra le forze repubblicane (comprensive di socialisti, comunisti e anarchici) e le forze fasciste e reazionarie. Naturalmente, anche gli ambienti monarchici – ancora presenti in modo significativo nella giovanissima repubblica spagnola – si schierarono con la Chiesa cattolica, i notabili conservatori, i grandi proprietari terrieri.
Tuttavia, pur nella sua rilevanza, la guerra civile sarebbe rimasta una pagina drammatica della storia spagnola se non vi fosse stato un interessamento europeo che incise profondamente nella sua evoluzione. Il confronto spagnolo palesava, per la prima volta in modo chiaro ed ineludibile in chiave internazionale, il conflitto tra fascismo e antifascismo. Nonostante l’impegno a non intervenire sottoscritto dalle principali potenze del vecchio continente (Gran Bretagna, Francia, Germania, Italia), il nazismo tedesco ed il fascismo italiano (ed in particolare quest’ultimo) inviarono non pochi aiuti al generale Francisco Franco che guidava i militari antirepubblicani. Sull’altro fronte, solo l’Urss sostenne la parte frontista, sollecitando, tra le altre cose, la formazione di brigate di volontari. Questa dimensione internazionale rese la guerra civile spagnola, in buona misura, paradigmatica della frattura fascismo/antifascismo nell’Europa tra le due guerre. In un’ottica teleologica, si trattò di una chiara anticipazione di quel che fu la seconda guerra mondiale a partire dal 1941 (cioè dall’ingresso di Unione sovietica e Stati Uniti nell’alleanza antifascista con la Gran Bretagna).
Ancor più rilevante fu l’impatto generazionale che essa ebbe. L’eco della guerra civile fu mondiale e divenne una sorta di turning point politico per una parte importante delle nuove generazioni. Uno dei maggiori storici del Novecento, George Mosse, ha scritto di un vero e proprio “political awakening” paragonabile a quello che la generazione degli anni sessanta ha vissuto con la guerra del Vietnam. La spinta ad un interessamento attivo alle vicende politiche nazionali ed internazionali fu fortemente sollecitato dal fascino di questa contrapposizione ideologica. Peraltro, la questione spagnola si inseriva in un clima globale di tensione crescente. Mentre si combatteva la guerra civile (1936-39) l’Italia aveva appena completato la conquista dell’Etiopia e proclamato la nascita dell’Impero (maggio 1936) e la Germania andava ad aprire quelle crisi internazionali (l’unificazione con l’Austria prima e lo smembramento della Cecoslovacchia poi) che sarebbero state il preludio all’invasione della Polonia e al conseguente scoppio della seconda guerra mondiale. L’Europa era in subbuglio ed i totalitarismi fascista e nazista si apprestavano a lanciare la loro sfida definitiva alle democrazie europee. Una sfida sistemica che si concluse solo con la fine delle ostilità e la vittoria dell’alleanza antifascista. Fu in un certo senso paradossale che proprio la Spagna franchista, uscita vittoriosa dalla guerra civile e simbolo del fronte fascista, sopravisse per lungo tempo alla sconfitta di quella proposta politica.
HOMBRE VERTICAL
A pochi chilometri da Firenze c’è un paesino …
di Emidio Pichelan

Il pio Alessandro Manzoni credeva nella Provvidenza e nei miracoli; quanto accaduto nella capitale Ue in questi giorni gli dà ragione. Da vendere. Più prosaicamente, non si poteva non trasalire per la sorpresa e la meraviglia allorquando, di questi tempi pandemici ed è tutto dire, nel prendere la parola per illustrare lo stato della Ue la Presidente Ursula von der Leyen scandiva: “A pochi chilometri da Firenze c’è un paesino, Barbiana, dove don Lorenzo Milani sul muro della scuola scrisse in inglese I care. Lui disse agli studenti che quelle erano le due parole più importanti da imparare. I care significa assumere responsabilità. Gli europei hanno dimostrato con la loro azione cosa significa. Questo deve essere il motto dell’Europa: We care”.
Già abbiamo ricordato come don Milani abbia attraversato l’Atlantico per andare a pescare e adottare quel motto in un mondo significativamente distante dal mondo cattolico e da quello patinato dell’establishment dell’epoca, e di come W. Veltroni l’abbia rispolverato e scelto come pietra miliare a fondamento del nuovo partito battezzato nel congresso del Lingotto a Torino.
Quella scritta dalla signora von der Leyen è un’altra pagina di una saga umile e poco appariscente ma, evidentemente, vincente.
“Così stupiti di noi stessi,
cos’altro ci può mai stupire?
Né arcobaleno la notte,
né farfalla sulla neve.
Ma addormentandoci
in sogno vediamo l’addio.
Però è un buon sogno,
però è un buon sogno
perché c’è un risveglio”
Wislawa Szymborska
Il miracolo non è dato solo dall’approdo in bocca della signora UE dei nomi di un priore esiliato in un villaggio invisibile sui monti della Toscana, ma anche dalla svolta che quei due nomi e quello slogan segnalano ai credenti e ai pagani: dall’Europa dell’austerità, dei conti in regola, della supremazia dei mercati all’Europa del Recovery Fund e della solidarietà, così come messa in moto a grandi linee e con grandi numeri a Porto (ma anche Oporto, in italiano), in Portogallo, sulle rive ricche di storia e di fascino del Duero. Un fiume condiviso con la Spagna, cantato con versi di pacata melanconia dal grande andaluso Antonio Machado. Dove, dopo le rivoluzioni verde e digitale, il “vertice sociale” – istituzioni e parti sociali – ha lanciato la rivoluzione dell’educazione permanente, lifelong learning nella moderna lingua franca.
Non è una novità, da decenni ormai le frenetiche evoluzioni moderne hanno relegato in soffitta la vecchia ripartizione dell’esistenza del “sapiens”: studio, lavoro, pensione. Ma, si diceva, il superamento di quella tripartizione arrugginita dal tarlo implacabile del tempo non poteva avvenire, rimaneva dichiarazione e sogno: la cultura dominante – il neoliberismo, la globalizzazione – relegava lo Stato sociale nella geenna dell’assistenzialismo, dello spreco, delle spese inutili.
Stavolta l’impegno è solenne, l’hanno preso 27 Capi di Stato, il sindacalismo e il patronato europei. Tutti “uomini d’onore”, per scomodare Shakespeare, e gentiluomini devono essere e da gentiluomini si devono comportare: la nuova Europa, quella della solidarietà, ha capito che non si possono celebrare le nozze con i fichi secchi e che da soli nessuno si può salvare. Sul tavolo il vertice sociale ha calato un assegno di 49 miliardi, in dieci anni. Non c’è alibi per dar vita alla terza rivoluzione, quella del sapere e della cultura e del bello e del gratuito.
LA POESIA DEI LUOGHI
Sestri Levante
di Gianni Gasparini

Un luogo di mare memorabile, unico nel suo genere in Liguria per la struttura, per la posizione.
Una penisola modellata da rocce accartocciate e protesa nel Tigullio verso il faro di Portofino, che al tramonto spicca sul mare e di notte brilla con le sue intermittenze regolari.
Se si sale alla punta Manara, che chiude il golfo verso levante, si coglie come fosse nel cavo della mano il distendersi quasi fiabesco della cittadina dalla penisola fino alla strada che separa le due rive opposte, con le case dipinte di rosa, con l’imponente chiesa collegiata al punto d’incontro della via che sale verso il parco dei Castelli. Qui, dove sorge un esclusivo hotel fondato dal finanziere Gualino nel periodo tra le due guerre, più di un secolo fa Marconi fece con successo i primi esperimenti di radiotelegrafia attraverso il Tigullio.
Molti anni fa gli anziani di Sestri chiamavano questa zona l’isola, perché tale era stata in effetti anticamente, separata dalla terra; e del resto le violente mareggiate di fine estate riuscivano talvolta a far sì che le acque della spiaggia di levante (quella che è chiamata oggi la Baia del Silenzio) si congiungessero occasionalmente con quelle di ponente (provenienti dall’attuale Baia delle Favole), prima di ritirarsi. Io stesso ne ho un ricordo da bambino: ho ben presente il torbido spumeggiare delle lingue finali delle onde di levante, il loro progressivo avanzare verso quelle di ponente e finalmente l’incontro tra le acque, la fusione che a un certo punto si verificò, per breve tempo.
Chi percorre oggi l’elegante carruggio centrale di Sestri, o la lunga passeggiata a mare con le palme che costeggia la grande spiaggia di ponente e gli stabilimenti balneari, fa fatica ad immaginare che questo era un borgo di pescatori. Alla sera uscivano con le lampare per la pesca del pesce azzurro, o con i tremagli e altri attrezzi: fra essi i cesti dei palamiti, che si lasciano tutta la notte ad attendere che i pesci abbocchino agli ami distesi ad intervalli su un lungo supporto di lenza, a una certa profondità. Ricordo che alla mattina i pescatori, che naturalmente erano tutti uomini, riparavano le loro reti al sole del lungomare, e lo facevano in un modo caratteristico: seduti per terra con le gambe distese, tenevano la rete con un piede, mentre le mani cucivano con ago e filo la riparazione.
C’era anche chi non lo faceva per mestiere ma andava a pescare per diletto, appostandosi con la canna fissa da certi punti sugli scogli o lasciando scendere il filo di nailon del bolentino da una barca ormeggiata al largo. Credo che il gusto della pesca non sia tanto quello di assicurarsi qualcosa di commestibile da portare a casa ma un senso dell’avventura, dell’incertezza riguardo al fatto se il pesce abboccherà, e di che pesce si tratterà, e di che dimensioni sarà. Pescare è sempre una questione aperta e avvincente, come ci insegnano – si parva licet - anche i classici della letteratura di mare da Moby Dick di Melville a Il vecchio e il mare di Hemingway, soprattutto quest’ultimo. Quando ero ragazzo avevo conosciuto a Sestri un pescatore con la canna che era diverso dagli altri e incuteva un senso di rispetto e di timore: lui riusciva quasi sempre a tirar su dall’acqua i pesci più grossi, specialmente i grandi saraghi che sono diffidenti ad abboccare ma che erano attirati dalle sue esche e dalle pasture particolari che preparava. Il Nani portava spessi occhiali scuri, era cieco da un occhio, non era né giovane né vecchio: attendeva paziente e inflessibile per ore davanti allo specchio d’acqua dove aveva proteso la sua canna fissa di cinque o sei metri con il gavitello e l’amo coperto dall’esca. Sembrava inseguisse inconsciamente un sogno di perfezione, quello di pescare nel modo più intelligente che fosse possibile e di essere il più bravo di tutti.
Prescindendo dalla pesca, occupazione tradizionale dei sestresi oggi non più praticata, va detto del bello dell’osservazione subacquea, che la varietà dei fondali di Sestri e dei suoi dintorni rende ancora oggi particolarmente interessanti: pesci anche non comuni come i cavallucci di mare, molluschi come polpi e seppie, crostacei dai granchi alle granceole, posidonie e alghe, madrepore e anemoni di mare…
Il genius loci di Sestri si esprime in una radiosità e solarità mediterranea che tiene insieme il mare e le spiagge, le coste rocciose e l’immediato entroterra. Lo si percepisce bene percorrendo i sentieri che si dipanano accanto al borgo e che raggiungono anche la frazione di Riva, con la sua spiaggia racchiusa tra punta Manara e capo Baffe in vista della punta del Mesco e delle Cinqueterre. La vegetazione offre in questo ambiente, accanto ai pini e ai lecci, esemplari di sughero e terebinto, oltre ad una abbondanza di corbezzoli, gli arbusti che d’inverno prodigano allegramente sui rami i loro frutti eduli di colore giallo e rosso, insieme a grappoli di delicati fiori bianchi.
Dalla Mandrella, località a metà strada del sentiero che da Sestri porta a Punta Manara e a Riva, ci si trova proprio di fronte al promontorio roccioso dell’antica isola diventata penisola: qui spicca tra la vegetazione un edificio bianco, l’antica chiesa romanica di San Nicolò con il suo campanile del XII secolo. Viene da chiedersi che cosa pensassero e credessero le persone che abitavano a Sestri molti secoli fa, come vivessero nel loro quotidiano tra mare ed entroterra. E ci si domanda se traessero gratificazione e forse persino gioia dalla bellezza raccolta di questo luogo singolare.
LETTURE
Tratta Napoli - Modena
Il viaggio di un bambino intorno al Mondo
di Leonarda Tola

Il treno dei bambini (Einaudi 2019) è il terzo romanzo di Viola Ardone (1974) docente di latino e italiano in un Liceo: un successo di edizioni, traduzioni (ne sono annunciate 25) e di lettori che in rete ne consigliano la lettura commentando: “Delicato, crudele, profondo. Una storia straziante che si legge tutto di un fiato. Commuove e fa pensare. Leggetelo”.
Di quali bambini e di quali viaggi in treno si parla? Di uno dei tanti convogli ferroviari che a partire dal 1946 e fino al 1952 trasportarono dal meridione d’Italia verso l’Umbria, le Marche, ma soprattutto l’Emilia Romagna (Bologna, Modena), 70.000 (!) bambini destinati ad un soggiorno più o meno lungo presso famiglie accoglienti verso l’infanzia povera del dopoguerra, lacera e affamata che viveva nel Sud in Ciociaria, nelle campagne pugliesi, ma soprattutto nei Quartieri spagnoli di Napoli. La trama storica del romanzo è il progetto di solidarietà e di ricostruzione sociale ideato dal Partito Comunista che, nella mente di donne appassionate, come la costituente Teresa Noce e di politici consapevoli (Giorgio Amendola), immaginò una risposta concreta che salvasse dalla miseria i bambini affamati di quella devastata Italia postbellica. Furono chiamati treni della felicità, lunghi lunghi e quasi nuovi, dove furono aiutati a salire bambine e bambini, ripuliti e rivestiti, da affidare alla cura di nuovi genitori disponibili ad allargare il desco e aprire le loro case ad un’ospitalità speciale. Bambini di madri e padri (quando c’erano) sconosciuti da aggiungere ai figli naturali, sentendoli come figli, sia pure per un tempo determinato che in tanti casi fu per sempre e per la vita.
È questa la storia di straordinaria solidarietà a cui Viola Ardone attinge con tutto quello che c’è da sapere nella dichiarata bibliografia e attraverso le testimonianze. La sfida per la scrittrice è se e come l’avventura di quei tanti bambini possa essere raccontata in un ordito narrativo convincente e magari avvincente; se quella vicenda comune a “creature” senza nome possa diventare la narrazione compiuta di un’esistenza nell’intreccio singolare del suo farsi e fluire. Come il viaggio di Ulisse. Come un romanzo. Che infatti comincia così: “Mia mamma avanti e io appresso. Per dentro ai vicoli dei Quartieri spagnoli mia mamma cammina veloce: ogni passo suo, due miei. Guardo le scarpe della gente. Scarpa sana: un punto; scarpa bucata: perdo un punto. Senza scarpe: due punti. Scarpe nuove: stella premio. Io scarpe mie non ne ho avute mai, porto quelle degli altri e mi fanno sempre male”. A parlare è Amerigo che va dietro alla madre Antonietta per le strade di Napoli ed entra in “un palazzo grigio e rosso” dove lui non è mai stato ; sono le prime pagine del libro dove Amerigo, protagonista e voce narrante, racconta l’incontro con l’incaricata di raccogliere le adesioni dei genitori alla partenza dei figli sui “treni speciali” e comprende che ci sarà da mangiare “pane zucchero e ricotta”; il trasferimento al Nord è un regalo e le mamme coraggiose che lasciano partire i figli lo fanno “per il loro bene” … “Mia mamma si abbassa e mi guarda fisso: Ormai sei grande, stai per compiere otto anni . La situazione nostra la sai”.
Il libro alza il velo su una realtà sociale di vite difficili segnate da stenti e privazioni nella Napoli dei bassi dove la sopravvivenza per i poveri era acrobazia di ogni giorno: duro mestiere di vivere, da apprendere appena si viene al mondo, contando su una dotazione di genio che è l’arte di cavarsela. Luoghi, situazioni e persone, scene da esistenze familiari nude e compromesse, consuetudini, vicinanze ma soprattutto altri bambini interpretati dai pensieri di Amerigo. Il mondo intravisto con gli occhi, gli incubi e il coraggio, i ragionamenti di un bambino e la sua verità.
Decisiva per la corrispondenza tra forma e contenuto è la lingua messa in bocca al narratore: invenzione geniale della scrittrice napoletana, frutto certamente di studio pur nella naturale padronanza dell’Italiano di Napoli che le appartiene; una lingua ‘giusta’ che riduce il lessico e la sintassi e dunque immaginifica, portentosa per la resa espressiva ed empatica. Fraseggio musicale che tinge di colori suoni odori, commuovendo e aprendo e al sorriso, il mondo dipinto con ingenua e sorgiva freschezza: ad altezza di bambino.
Il romanzo nelle sue tre parti è il viaggio della vita di un bambino e della sua strenua e dolorosa crescita fino all’età adulta: fuga e scoperta, il prima e il dopo, andata e ritorno, nell’oscillazione tra due mondi che da piccolo lo ha diviso a metà. Dove l’esperienza del nuovo e la conquista lasciano aperto il varco attraverso cui, alla fine, si fa largo la fedeltà a se stessi nel riscatto delle origini.
SUL FILO DEL TEMPO
Il sole uccide le idee (“anche se scalda le ossa”)
di Mario Bertin
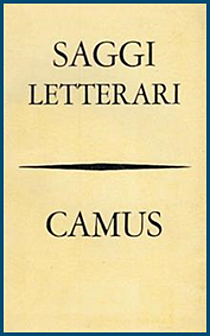
Ci sono due brevi saggi giovanili di Albert Camus (1913-1960) dove si può individuare la sorgente del suo pensiero e della sua arte, che, secondo quanto dichiara lui stesso, si collocano “a mezza strada fra la miseria e il sole”. Questi due saggi si intitolano rispettivamente Nozze ed Estate e non si possono considerare separatamente perché l’uno non può prescindere dall’altro, perché l’uno presuppone l’altro. Insieme tracciano il percorso di una ricerca profondamente radicata nell’esistenza dell’autore, che prende avvio dal contesto poverissimo della periferia di Algeri (da una famiglia “senza parole”) per raggiungere, nel breve tempo della sua vita (Camus morirà in un incidente d’auto a 46 anni) un grandissimo successo, coronato, nel 1959, dal Premio Nobel.
Da Nozze è tratto il brano che proponiamo qui di seguito (“Nozze a Tipasa”), in cui l’autore celebra le sue nozze con il mondo sotto il sole e nel “voluminoso odore” dell’estate nella città algerina che sorge sulle sponde del Mediterraneo e che fu importante insediamento romano, come stanno a dimostrare le numerose rovine che vi si possono ammirare (il tempio, il teatro, l’arco di trionfo, le piazze, la selva di colonne…).
Nei confronti del valore letterario di questi saggi, Camus fu sempre critico severo, ma non nasconde neppure che in queste pagine “sgraziate” vi è più amore che in quelle, più famose, venute poi. In esse infatti è presente un importante valore di testimonianza. Una testimonianza “a sé”, nel senso che esige una fedeltà a quello che lì si dice. E cioè che il mondo non ha senso e non ha bisogno di senso. Che ad esaurire il senso è l’essere. L’uomo – prosegue Camus – è finito, ma è capace di pensare l’infinito e di desiderarlo. Di qui nasce l’assurdo, “che non è nell’uomo né nel mondo, ma nella loro comune presenza”. Compito dell’uomo – come peraltro di tutti gli esseri esistenti – è di “diventare ciò che si è, di ritrovare la propria misura profonda”. Condizione imprescindibile è “una certa nudità” che, per l’autore, “non ha mai cessato di coincidere con il maggiore dei lussi”, e che è l’unica custode della vita interiore.
Lontano dalla confusione, dal chiasso della città, c’è una luce alle nostre spalle. Bisogna guardarsi indietro e cercare di darle un nome. “Bisogna saper pazientare. Ancora un po’, e il sole tapperà le bocche”.
NOZZE A TIPASA
Albert Camus
Arriviamo dal villaggio che s'apre già sulla baia. Entriamo in un mondo giallo e turchino dove ci accoglie l'alito odoroso e acre della terra algerina d'estate. Dovunque, buganvillee rosate traboccano dai muri delle ville; nei giardini l'ibisco dal rosso ancor pallido, una profusione di rose tea dense come crema e delicate bordure di lunghi giaggioli azzurri. Tutte le pietre sono calde.
[…]
Dopo pochi passi, gli assenzi ci prendono alla gola. La loro lanugine grigia copre le rovine a perdita d'occhio. La loro essenza fermenta sotto il caldo, e dalla terra al sole si leva su tutta la distesa del mondo un alcool generoso che fa vacillare il cielo. Andiamo incontro all'amore e al desiderio. Non cerchiamo insegnamenti, né l'amara filosofia che si cerca nella grandezza. All'infuori del sole, dei baci e dei profumi selvaggi, tutto ci sembra futile. Quanto a me, io non cerco di rimaner solo. Ci sono andato spesso insieme a quelli che amavo e leggevo sui loro lineamenti il luminoso sorriso che vi assumeva l'immagine dell'amore. Qui, lascio ad altri l'ordine e la misura. È il gran libertinaggio della natura e del mare che si impossessa completamente di me. In questa unione dei ruderi e della primavera, i ruderi sono tornati ad essere pietra, e perdendo il lustro imposto dall'uomo, sono rientrati nella natura. Per il ritorno di questi figli prodighi, la natura ha prodigato i fiori. Fra le pietre del foro s'innalza la testa bianca e rotonda dell'eliotropio, e i gerani rossi versano il loro sangue su ciò che furono case, templi e piazze pubbliche. Come quegli uomini che molta scienza riconduce a Dio, i molti anni hanno riportato le rovine alla casa della madre. Oggi finalmente il passato le abbandona, e nulla le sottrae a quella forza profonda che le riporta al cuore delle cose che cadono.
Quante ore passate a calpestare gli assenzi, ad accarezzare le rovine, a tentare di accordare il mio respiro con il sospirare tumultuoso del mondo! Immerso negli odori selvaggi e fra i concerti d'insetti assonnati, apro gli occhi e il cuore alla grandezza insostenibile di questo cielo saturo di calore. Non è cosí facile diventare ciò che si è, ritrovare la propria misura profonda.
[…]
Qui capisco quel che chiamano gloria: il diritto di amare senza misura. C'è un solo amore in questo mondo. Stringere un corpo di donna è anche tenere contro di sé questa gioia strana che scende dal cielo verso il mare. Fra poco, quando mi getterò negli assenzi per farmi entrare il loro profumo nel corpo, sarò cosciente, contro ogni pregiudizio, di compire una verità che è quella del sole e sarà anche quella della mia morte. In certo senso, è proprio la mia vita che io recito qui, una vita che sa di pietra calda, piena dei sospiri del mare e delle cicale che cominciano a cantare adesso. La brezza è fresca e il cielo turchino. Amo questa vita con abbandono e voglio parlarne liberamente: essa mi dà l'orgoglio della mia condizione d'uomo. Pure, spesso mi è stato detto: non esiste nulla di cui essere fiero. Sí, qualcosa c'è: questo sole, questo mare, il mio cuore che balza di giovinezza, il mio corpo che sa di sale e l'immenso scenario dove s'incontrano l'amore e la gloria nel giallo e nell'azzurro. È per conquistare questo che devo adoperare la mia forza e le mie risorse. Qui tutto mi lascia integro, non abbandono nulla di me stesso, non indosso alcuna maschera: mi basta apprendere pazientemente la difficile scienza della vita che vale certamente tutto il loro saper vivere.
Albert Camus, Nozze a Tipasa, Nozze, Saggi letterari, tr. di Sergio Morando, Bompiani Milano 1958, pagg. 63-67
UN ANNO CON PINOCCHIO
La fame, il lavoro, il denaro
di Gianni Gasparini

Nel mondo di Pinocchio la dimensione economica non è affatto secondaria: essa si esprime spesso – sia in Pinocchio che in Geppetto e altri personaggi – in un modo diretto e primordiale, in quanto esigenza di soddisfare la fame.
È la fame a rappresentare la condizione normale o prevalente del burattino e del suo babbo, così come la situazione diffusa di povertà o indigenza costituisce un tratto fondamentale del quadro sociale che emerge in filigrana dal racconto, in accordo con la situazione di una società quale era rappresentata dalla Toscana e dall’Italia rurale che fa da sfondo alla scrittura di Collodi. Sembrerebbe a prima vista, questo, un tratto ben lontano dalle società industrializzate contemporanee, dove vigono sistemi di Welfare o sicurezza sociale che non erano ancora stati inventati ai tempi di Pinocchio; eppure, quello a cui stiamo assistendo oggi, anche in un paese come il nostro, è un grande aumento di persone e famiglie in gravi difficoltà economiche e bisognose di aiuti alimentari diretti e di interventi economici di base.
Si può ricordare qui la situazione di grande povertà di Geppetto, che va a mendicare un pezzo di legno da mastro Ciliegia e che non ha in casa assolutamente nulla da mangiare, come verifica puntigliosamente Pinocchio in assenza del babbo-falegname: “Magari un po’ di pan secco, un crosterello, un osso avanzato al cane, un po’ di polenta muffita, una lisca di pesce, un nocciolo di ciliegia, insomma qualche cosa da masticare: ma non trovò nulla, il gran nulla, proprio nulla” (Cap. V). Pinocchio si sente morire di fame e decide di andare a chiedere l’elemosina facendo una scappata al paese vicino: purtroppo anche questo tentativo andrà a vuoto e il burattino potrà calmare i morsi della fame soltanto al ritorno di Geppetto, il quale gli offrirà generosamente le tre pere che avrebbero dovuto rappresentare la sua colazione (Cap. VII).
Per ovviare alla fame, o se vogliamo per risolvere il problema-chiave della sopravvivenza economica, occorre lavorare. I ragazzi devono andare a scuola e imparare un mestiere, come recita il Grillo-parlante nel suo sermone al burattino, il quale aveva dichiarato apertamente di non aver punto voglia di studiare: “E se non ti garba di andare a scuola, perché non impari almeno un mestiere, tanto da guadagnarti onestamente un pezzo di pane?” (Cap. IV). Gli fa eco il Pappagallo incontrato al Campo dei miracoli: egli spiega al burattino che “per mettere insieme onestamente pochi soldi bisogna saperseli guadagnare o col lavoro delle proprie mani o coll’ingegno della propria testa” (Cap. XIX).
Esemplare nell’adesione a questa etica ottocentesca del lavoro appare l’isola delle Api industriose alla quale approda ad un certo punto Pinocchio: qui la sua riluttanza al lavoro, che gli permetterebbe se superata di sfamarsi, si scontra con una moltitudine di persone “che correvano di qua e di là per le loro faccende: tutti lavoravano, tutti avevano qualche cosa da fare” (Cap. XXIV). In questo paese in cui non sembra esistere la disoccupazione Pinocchio, affamato ma allergico al lavoro e propenso a chiedere l’elemosina, medita alla fine sugli insegnamenti del padre Geppetto, secondo il quale la carità possono chiederla soltanto i vecchi e gli infermi, quelli che non si possono più guadagnare il pane con il lavoro delle proprie mani.
All’isola delle Api industriose si oppone specularmente, nel prosieguo del racconto, il Paese dei Balocchi, che – come si è visto in una puntata precedente (La scuola di Pinocchio, marzo 2021) – viene presentato a Pinocchio da Lucignolo come il luogo assolutamente ideale per i ragazzi: un paese dal quale lo studio è rigorosamente bandito e anche il lavoro non appare in alcun modo. Il Paese dei Balocchi è il luogo benedetto, esempio luminoso di “come dovrebbero essere tutti i paesi civili”, nel quale non si studia mai e le vacanze iniziano il primo di gennaio per terminare il trentuno di dicembre. Se le “scuole” le sostituiamo con “aziende, fabbriche” e i “maestri” con “capi, dirigenti”, abbiamo in questo paese una prefigurazione di un luogo utopico nel quale alla soppressione del lavoro fa da pendant l’eliminazione della festa, che presuppone un’alternanza tra giorni ordinari o feriali di lavoro e giorni straordinari dedicati ad altre attività, di carattere civile o religioso. Si tratta peraltro di un luogo decisamente inquietante, espressione di una falsa utopia che si scioglie nel giro di pochi mesi e rivela i suoi tratti disumani: i ragazzi si trasformano in asini – metafora di un degrado e perdita della condizione umana – e vengono venduti al mercato, come se fossero una merce qualunque, per il profitto di personaggi criminali, come l’Omino di burro che conduce i ragazzi al Paese dei Balocchi di notte sul suo carro traballante.
Il denaro è normalmente il trait d’union tra l’esigenza di sfamarsi e il lavoro, anche se non sono rari nella società evocata da Collodi gli episodi di baratto o di retribuzione in natura: nell’ultima fase sappiamo ad esempio che Pinocchio per un certo periodo lavora duramente dall’ortolano Giangio in cambio di un bicchiere di latte al giorno che viene destinato a Geppetto anziano e malaticcio. Ma apprendiamo pure, sempre nelle ultime battute del libro, che Pinocchio svolge anche lavori di cesteria e riesce a un certo punto a risparmiare un piccolo gruzzolo, quei quaranta soldi di rame che dovrebbero servirgli per un vestito nuovo da acquistare al mercato ma che vengono invece donati alla Fata non appena il burattino viene a conoscenza delle condizioni difficili di costei, come gli fa credere la Lumaca per metterlo alla prova.
Resta da dire dei cinque zecchini d’oro, le preziose monete ricevute dal burattinaio Mangiafoco che saranno all’origine di tante pene e guai per il burattino. Questi zecchini rappresentano un dono incongruo, strano e in fondo non giustificato: per chi li ha ricevuti essi recano lo stigma del denaro non guadagnato con fatica. Essi diventano oggetto di brama malvagia per la Volpe e il Gatto, mentre in Pinocchio sollecitano sogni di avidità attraverso il miraggio dell’albero che dovrebbe moltiplicare a dismisura le monete d’oro.
Siamo ricondotti così, anche attraverso l’insegnamento offerto dalle vicende degli zecchini, all’equilibrio iniziale del racconto, dove vige un’etica socio-economica in cui il lavoro svolto onestamente è fondamento dei comportamenti sia degli adulti che dei giovani ad esso si preparano attraverso la scuola.

