
In questa pagina:
Cose da fare: Dilemmi di maggio (Maddalena Gissi)
Festa del lavoro: 1° maggio, gli uomini sanno... (Emidio Pichelan)
Con altro sguardo: Quanto è grande la gioventù di oggi (Daniele Mencarelli)
Storia contemporanea: 1921- La fondazione del partito comunista d’Italia (Paolo Acanfora)
Hombre vertical: Il coraggio delle sfide (Emidio Pichelan)
La poesia dei luoghi: Un giardino di Parigi (Gianni Gasparini)
Letture: Adolescenza: istruzioni per l’uso (Leonarda Tola)
Sul filo del tempo: Maggio. La rosa fiorisce senza un perché (Mario Bertin)
L'anima e la LIM: I demoni di questa primavera (Lorenzo Gobbi)
Un anno con Pinocchio: Bugie, inganno, violenza (Gianni Gasparini)
In memoria: Giancarlo Cerini, una vita per la scuola
Scrivici, se vuoi, a redazione@cislscuola.it
COSE DA FARE
Dilemmi di maggio
di Maddalena Gissi

Di quale lavoro celebriamo, oggi, la festa? Di quello che chiediamo, giustamente, di svolgere in condizioni di sicurezza, a tutela della salute nostra e di chi ci vive accanto? O di quello che semplicemente molti chiedono di svolgere, non potendolo fare da mesi, una condizione che rende sempre più difficile provvedere al sostentamento proprio e della propria famiglia? È un dilemma al quale è difficile sfuggire in questo primo maggio, senza cedere alla tentazione di trascorrerlo solo nel segno di una retorica più o meno esaltante, più o meno consolatoria. Fare il processo alle intenzioni è una pratica di cui bisognerebbe quantomeno non abusare: ma non me la sento di escludere che fra quanti, analizzando gli effetti della pandemia sul mondo del lavoro, insistono nel tracciare linee di demarcazione fra garantiti e non garantiti, molti abbiano come obiettivo la riduzione di sicurezze e tutele, più che una loro estensione a chi ne ha di meno. Eppure quella differenza c’è, sarebbe inutile e - peggio ancora - sbagliato negarla, mentre è doveroso assumerla come premessa a politiche sociali conformi e coerenti al dettato di una Costituzione che pone il lavoro a fondamento della nostra Repubblica. Quando un diritto tende ad essere diffusamente negato, rischia di essere assimilato a un privilegio per quanti riescono a fruirne. Un’aberrazione inaccettabile, che minerebbe alla radice un fattore fondamentale di coesione sociale da confermare, anche in prospettiva, come una precisa scelta di civiltà. L’affermazione piena del diritto al lavoro non può non essere la stella polare del sindacato nel momento in cui si definiscono progetti e percorsi di ripresa economica e sociale.
Ma prima di quello appena richiamato vi è un altro dilemma, che lo precede e in qualche modo lo contiene, ed è quello che ci tormenta fin dall’esplodere della pandemia: se il primo bene da tutelare sia la salute o l’economia. Che produce ricchezza, che genera lavoro. Qualcuno l’ha ridotto, un po’ brutalmente, alla scelta fra morire di covid o morire di fame. Espressione brutta e comunque intrisa di disperazione. Ha prevalso giustamente, come scelta obbligata e drammatica, l’impegno a ricercare un difficile equilibrio fra esigenze da tenere entrambe in attenta considerazione.
Una scelta obbligata e drammatica: proprio per questo da fondare quanto più possibile su un robusto supporto di competenze scientifiche cui fare affidamento nel valutare opportunità e rischi. Questo si richiede alla politica, che dimostra di essere all’altezza solo se e quando non si limita a fare da amplificatore alle situazioni di disagio. Vale anche e ancor più per il sindacato, come ci richiama la lettura del primo maggio, articolata e suggestiva, offerta in questo mensile dell’Agenda da Emidio Pichelan.
E c’è inoltre, e ancora, il ruolo decisivo che in frangenti come questo giocano il senso di responsabilità e i comportamenti individuali. “Inutile scrivere regole, raccoglierle in cartelli e manuali, se poi non viene assunta da ciascuno di noi, in prima persona, la responsabilità di osservarle scrupolosamente”: lo scrivevo a marzo del 2020, quando ci stavamo rendendo conto che un fenomeno fino ad allora osservato “da lontano” stava irrompendo nelle nostre esistenze. Lo ripeto oggi con ancor più convinzione e lo metto senza alcun dubbio tra le cose più importanti, per tutti, da fare.
E infine un altro dilemma, meno drammatico ma di grande rilevanza perché implica una riflessione che investe l’identità professionale e di sistema, ed è legato alla discussione apertasi attorno al “Piano scuola estate 2021”, varato qualche giorno fa dal Ministero dell’Istruzione.
È scuola, o socio-assistenza, quella che le istituzioni autonome avranno l’opportunità di promuovere nei mesi estivi, costruendo quel “ponte formativo” con cui favorire “la restituzione agli studenti di quello che più è mancato in questo periodo”? Deficit di apprendimenti, per la condizione anomala in cui la scuola ha vissuto gran parte degli ultimi due anni scolastici, e deficit di socialità, tanto da far avvertire l’esigenza “di restituire, con ampiezza, spazi e tempi di relazione” ad alunne e alunni di ogni ordine e grado.
Difficile stabilire demarcazioni nette, pur con l’attenzione e l’impegno che abbiamo sempre speso, ad esempio, perché fosse chiaro il profilo di “vera scuola” per quel segmento – la scuola dell’infanzia – più di altri esposto ad ambiguità di ruolo. Difficile perché l’intreccio fra le diverse componenti di una professionalità (e di un sistema) cui si richiede di insegnare, formare, educare è complesso e arduo da sciogliere. Del resto, se quell’intreccio non esistesse, avremmo forse avvertito come meno gravoso e limitante l’obbligo di svolgere a distanza l’attività didattica.
Ritengo senz’altro molto positivo, dopo settimane di discussioni e polemiche su cosa fosse giusto fare per restituire ad alunne e alunni un po’ di quanto hanno perso in questi mesi, il fatto che siano state accantonate ipotesi sbrigative e di più facile presa per l’opinione pubblica, come un allungamento del calendario scolastico a prescindere da ogni valutazione delle reali ed effettive necessità. Ora che ad ogni scuola, come noi avevamo chiesto, non si impongono obblighi, ma viene data l’opportunità di promuovere, con l’affidamento di consistenti risorse, iniziative ad adesione volontaria che possono vederla coinvolta direttamente o in collaborazione con altri soggetti del territorio, sarebbe davvero un peccato sprecarla, chiamandosene fuori non per altre ragioni magari più comprensibili, ma in nome di una distinzione (fare scuola – fare assistenza) della quale le scuole stesse potranno e sapranno tenere conto, assegnando a ciascuno i giusti ruoli nella gestione delle attività e prima ancora nella loro programmazione.
Aprirsi al contributo di altri soggetti attivi sul territorio, facendo qualcosa di più e di diverso che ceder loro temporaneamente l’uso degli spazi, potrebbe anche servirci ad arricchire di senso l’espressione “comunità educante” che noi stessi, nel nostro contratto di lavoro, abbiamo scelto e voluto come descrizione più fedele della nostra idea di scuola. So bene che non è facile, che può costare fatica, e tutti ne abbiamo addosso tanta. Così come non sottovaluto la difficoltà di dover operare in tempi molto stretti e con modalità (penso all'utilizzo dei PON) la cui complessità rischia di risultare impari rispetto all'impegno che richiede a uffici già alle prese con un sovraccarico di adempimenti, spesso impropri: ma l’idea alta che abbiamo del nostro lavoro deve spingerci a raccogliere una sfida che può essere di rinnovamento e di crescita. Una crescita anche della rilevanza riconosciuta ad ogni scuola dalla comunità per la quale e con la quale agisce.
FESTA DEL LAVORO
Primo Maggio: gli uomini sanno, gli dei conoscono, i sapienti avvertono
di Emidio Pichelan

Quel Primo Maggio, seppur privo di cortei, bandiere, fischietti, canti e concertone, rimarrà il più strano e straordinario. Unico e irrepetibile. Nel trasferimento da La Guajira, la penisola desolata, resa ancor più deserto dalla luce (E. Dickinson), e da Riohacha, il capoluogo del Dipartimento, “la città di sabbia e di sole “ dov’erano nati i genitori di Gabo, il viaggio prevedeva una tappa ad Aracataca, nella (ricostruita) casa natale dello scrittore colombiano Nobel per la Letteratura. Il Primo Maggio del 2019, sotto un gigantesco ficus dalle radici tentacolari, anche minacciose nello sgusciare negli anfratti come rettili preistorici, mi è capitato di ripassare i nomi dei sindacalisti che, per la loro militanza, avevano perso la vita: in Colombia, ovviamente, ma anche in Brasile, in Centro America, in Messico, nella lontana Timor. E mi potevo immergere, per l’ennesima volta, nella straordinaria scoperta infantile del protagonista di Cien añs de soledad: el hielo, il ghiaccio. Lì, sotto quel ficus, tra le citazioni di Gabriel García Márquez sui muri infuocati di bianco dal Tropico in esplosione, era chiaro perché la scoperta del ghiaccio potesse sembrare meravigliosa. Come nei torrenti e nelle baie del Parque Nacional de Tayrona si poteva capire perché i grandi sassi levigati diventassero uova preistoriche.
Nel movimento operaio, rivoluzione e riformismo hanno abitato a lungo, in una dialettica perenne tra fascino e fattibilità, costi e benefici, pars destruens e pars costruens, mentre i miti e i riti del sindacalismo moderno – il sole dell’avvenire, anzitutto, metafora onnicomprensiva di riconoscimento dell’organizzazione sindacale, di una giornata lavorativa di 8 ore, del diritto allo sciopero e all’emancipazione dalla schiavitù di un lavoro inzuppato di lacrime e di sangue e di sudore – hanno proceduto a fatica. Lentamente. Una storia impregnata di sangue e di eroismi noti – alcuni -, ignoti – i più -; gli uni e gli altri meriterebbero una più attenta cura da parte degli storici e degli stessi sindacalisti.
La storia non fa salti, e gli uomini – li chiameremo “sapienti” – non sempre riescono a “stare sul pezzo”, leggendo correttamente i tempi. Come illustrato dal racconto di Northrop Frye, critico letterario canadese. Un giorno un suo amico medico decideva di concedersi un’esplorazione nella tundra artica. Veniva sorpreso da una tempesta di neve. “Ci siamo persi”, esclamava con voce strozzata dall’ansia, rivolto alla guida Inuit che lo accompagnava in quell’impresa dagli imprevisti incorporati. “No, amico”, replicava pronto l’Inuit; “no, amico, non ci siamo persi. Siamo qui”. Nel luogo e nel tempo in cui dobbiamo essere ed operare.
Su fratelli, su compagni,
su, venite in fitta schiera:
sulla libera bandiera
splende il sol dell’avvenir.
Nelle pene e nell’insulto
ci stringemmo in mutuo patto,
la gran causa del riscatto
niun di noi vorrà tradir.
(…)
O vivremo del lavoro
o pugnando si morrà.
(“Inno dei Lavoratori”, parole di Filippo Turati, musica di Amintore Galli)
Il 27 marzo del 1886, qualcosa come 135 anni fa, nel salone del Consolato operaio a Milano la Corale Donizetti eseguiva la prima dell’Inno dei Lavoratori, testo del giovane (29 anni) ma già affermato esponente del riformismo socialista Filippo Turati (il partito socialista non era ancora stato costituito) e musica del musico-pubblicista Amintore Galli. Si erano consumati poco meno di quarant’anni da quando Marx e F. Engels avevano osato pronunciare il nome dello spettro che s’aggirava per l’Europa, spaventando re, monarchi, sovrani, Papi e borghesi (“Il Manifesto” è del 1848). L’Inno assemblava tutte (o quasi) le parole dei diseredati: sfruttamento e riscatto, oppressione e unione, servitù e pugna, sudore e giogo, i poveri sono servi, condannati a una lotta senza sosta contro i negrieri e i tiranni. Un inno pedagogico, in sintonia con i tempi: nello stesso anno De Amicis, candidandosi a pedagogo dell’Italia di Depretis e della Sinistra al governo, pubblicava Cuore, e la Statua della Libertà, regalo dei francesi agli amici americani, prendeva il suo posto alla foce dell’Hudson, al centro della baia di Manhattan. Ad Haymarket Square, Chicago, si consumava l’ennesima, sanguinosa repressione di uno sciopero generale, convocato a sostegno della giornata a otto ore. Che “sulla libera bandiera” splendesse “il sol dell’avvenire” ci credevano in tanti; per questo donne e uomini si aggregavano e si organizzavano, sfidavano divieti e repressioni, tenendo alla dovuta distanza l’anarchia violenta e rivoluzionaria. Ma quanta fatica, quanta pazienza, quanti morti.
Vent’anni prima dell’Inno e del libro Cuore, sempre a Chicago, il Parlamento dell’Illinois aveva adottato una legge sulle otto ore giornaliere; l’iniziativa aveva camminato, ma troppo pigramente: e così proprio in quel 1886, l’anno dell’Inno dei Lavoratori, l’American Federation of Organized Traders and Labor Unions ne chiedeva l’estensione a tutti gli Stati della Federazione, pena la proclamazione di uno sciopero generale. E sciopero fu a Chicago, con scontri tra manifestanti e polizia, e il “fattaccio brutto” di Haymarket Square, rimasto sostanzialmente insoluto, come soleva accadere a fronte di conflitti sociali, trattati dalle autorità come “attentati all’ordine pubblico”. Un film visto e rivisto fino alla indigeribilità: proclamazione dello sciopero, divieto delle autorità, scoppio di un ordigno e morte di vittime innocenti, repressione politica e giudiziaria, processi dalla dubbia imparzialità e claudicante ricerca della verità e dei colpevoli, condanne alla pena capitale.
Il resto della storia del Primo Maggio è nota: la Seconda Internazionale, sorta per iniziativa dei socialisti e dei laboristi, convocata a Parigi per la prima volta nel 1889 – l’anno dell’Expo universale e della Torre Eiffel - adotta la data dei fatti di Haymarket Square, il Primo Maggio appunto, come Festa dei Lavoratori. E due anni dopo veniva adottata anche in Italia, salutata dalla rivista La Rivendicazione”, stampata a Forlì, con le seguenti parole: “Il Primo Maggio è come parola magica che corre di bocca in bocca, che rallegra gli animi di tutti i lavoratori del mondo, è parola di ordine che si scambia fra quanti si interessano al proprio miglioramento”. Un’enfasi retorica del tutto accettabile.
Risulta tutt’altro che alieno agli stop and go delle umane vicende il Quarto Stato di Pellizza da Volpedo (1868-1907), tanto peggio per chi non ha pazienza, incapace di scommettere sulla speranza del futuro. Il grande quadro, inusuale per dimensioni e per l’affollamento delle masse, terminato nel 1901, veniva esposto nella Quadriennale di Torino. Il soggetto esplicitava un messaggio diretto: spente le cannonate di Bava Beccaris sui dimostranti milanesi e accantonate le velleità autoritarie di De Rudiní (e del Re Umberto I, ucciso a revolverate dall’anarchico Bresci a Monza), l’era giolittiana alludeva a un riscatto risarcitorio, a lungo atteso. Quadro e messaggio passavano, invece, inosservati. Nel 1907, alla sua morte (suicidio) men che quarantenne in seguito alla morte improvvisa della moglie, gli eredi trovavano il quadro tra i suoi ben; rientrava in una collezione pubblica solo quando, nel 1920, il Comune di Milano, guidato da Emilio Caldara, carismatico primo sindaco socialista della metropoli, ne decideva l’acquisto. Con pubblica sottoscrizione, cause le casse comunali esangui. Due annotazioni ancora a completamento del breve schizzo storico: il fascismo, arrivato al potere appena due anni dopo l’acquisto da parte del Comune di Milano del Quarto Stato, pensò bene di anticipare il Primo Maggio al 21 aprile, giorno della Fondazione di Roma. Un modo inelegante per cancellare anche solo la parola socialismo, con quello che ne seguiva e segue. Il Quarto Stato, inteso come icona e sole dell’avvenire, diventerà il simbolo dei diseredati in marcia, uniti, per i diritti e la libertà, nel 1976: quando il regista Bernardo Bertolucci lo sceglie come locandina del film Il Novecento.
Non c’erano meriti particolari, negli anni Settanta del secolo scorso, nel militare in un partito e/o in un sindacato. Meglio ancora se in tutte e due. La neutralità, una bestemmia impronunciabile, e il guardare altrove, un peccato di omissione imperdonabile. Non ha avuto l’attenzione che merita, quel decennio, per quanto accaduto, tanto incisivo quanto – e forse più - del tanto lodato e/o detestato ’68. Un decennio sacrificato sull’altare di Tangentopoli. Le ideologie contavano, e non erano tutto e solo farina del diavolo. “Eravamo soli e senza senso”, per dirla con le parole di Antoine Roquetin di “La nausea” di J. P. Sartre nella recente lettura di M. Recalcati (“A libro aperto. Una vita è i suoi libri”, Feltrinelli, 2020).
Dunque, partiti e sindacati rientravano nel pacchetto delle “scelte obbligatorie”: era allora chiaro, e lo sarà sino a Tangentopoli, alla caduta del Muro, alla globalizzazione, allo sfarinamento – più propriamente, al “rifiuto disgustato” delle ideologie -, che la nuova Repubblica si fondava su alcuni punti, fermi e condivisi, della giovanissima Carta Costituzionale: la centralità della persona umana (artt. 2 e 3), i valori della democrazia e della libertà e dell’Europa. E – un punto sul quale la pubblica opinione, i partiti e gli stessi sindacati non si sono soffermati sufficientemente – sulla negazione che il popolo abbia sempre ragione. Mussolini, prima, e Hitler, poi, si erano arrampicati sul potere con il voto popolare – e con il consenso (o il non rifiuto) del fior fiore dell’intellighenzia. L’affermazione, temo, è troppo brusca: si dica, allora, che il popolo ha ragione in quanto agganciato allo spirito e ai principi della Costituzione, come scandito dal secondo comma dell’articolo 1 della Costituzione: “L’Italia è una Repubblica fondata sul lavoro. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione”.
In questa valle di lacrime, il singolo (la persona) e la comunità (non c’è persona senza comunità) si muovono, esplorano, cercano, vivono e crescono e soddisfano le proprie passioni. Nell’affascinante “Le vie dei canti” (1987) il grande Bruce Chatwin sostiene che fin dalle origini l’uomo ha sentito l’impulso di spostarsi, migrare. Il prototipo umano virtuoso è il nomade che, a differenza del sedentario, sfugge alla tentazione di voler cambiare il mondo, la sua casa è ovunque si trovi, per scelte e/o necessità e/o caso; e lo è grazie ai “guardiani” e ai “punti di riferimento della comunità”. La Bibbia racconta di un Dio creatore che predilige i doni del nomade (pastore) Abele. Per Costantino Kavafis, un greco nato in Egitto, una vita spesa studiando la grande cultura antica greco-romana-bizantina, il compito di “guardiano” e di “punto di riferimento” spetta al sapiente.
"Gli uomini sanno le cose presenti,
gli dei conoscono quelle future,
assoluti padroni d’ogni luce.
Ma del futuro, avvertono i sapienti
ciò che s’appressa. Tra le gravi cure
degli studi, l’udito ecco si turba
d’un tratto. A loro giungono le oscure
voci dei fatti che il domani adduce.
Le ascoltano devoti. Fuori, per via, la turba
non sente nulla, con le orecchie dure”.
(“C. Kavafis, “I sapienti ciò che s’avvicina”)
Gli dei lassù, da qualche parte, che conoscono il futuro, i comuni mortali che non possono che accontentarsi del presente, opaco e senz’anima. E poi ci sono loro, i sapienti, capaci di “parlare ai presenti con esempi del passato” (B. Gracián, gesuita spagnolo del XVII secolo): perché studiano e sono in grado di interpretare il passato e, dunque, di capire la direzione di marcia da intraprendere: “avvertono ciò che s’appressa”. Per tutto ciò, ai sapienti spetta il compito di guidare (“la turba non sente nulla”) la comunità in questa valle di lacrime.
Un profilo troppo impegnativo per una realtà, quella politica, pesantemente mondana, distante dai voli pindarici della letteratura e della poesia? Affatto, ove si ripassi la storia del sindacalismo confederale e, in particolare, del “sindacato nuovo” ideato e voluto dall’humus culturale dal quale sono sbocciati gli articoli 2 e 3 della Costituzione. La festa del Primo Maggio è una buona occasione per ri-leggere qualche passo di “Pensiero, Azione, Autonomia. Saggi e testimonianze per Pierre Carniti” (Edizioni Lavoro Roma, 2017), “Sapere, Libertà. Mondo. La strada di Pippo Morelli” (Edizioni Lavoro Roma, 2020). E, perché no?, il racconto elegante di Federico Bozzini in “Cipolle e libertà. Ricordi e pensieri di Gelmino Ottaviani, operaio metalmeccanico”. Ovviamente, senza perdersi il monologo recitato magistralmente da Marco Paolini.
I partiti come i sindacati sono costruzioni umane, guidate e amministrate da uomini più o meno sapienti, più o meno colti e amanti dello studio e attrezzati per leggere i segni dei tempi. La scelta e la preparazione del “sapiente” in grado di “avvertire ciò che s’appressa” costituivano la prima delle preoccupazione di un sindacato che teorizzava l’autonomia dai partiti e dal governo (art. 2 dello Statuto della Cisl), non certo dalla politica, il superamento di ogni ancillarità nella interpretazione della politica intesa come servizio alla comunità – ovviamente, a iniziare dai diseredati – e di cittadini-protagonisti della vita politica, superando i limiti vistosi e paralizzanti del corporativismo.
È un fatto che il sindacalismo confederale, nella lotta per la conquista dei fondamentali diritti sociali – riconoscimento dell’organizzazione sindacale, diritto di sciopero, emancipazione dallo sfruttamento (in primis, con la conquista della parola, don Milani docet), partecipazione agli utili frutto del lavoro umano, centralità della persona (il lavoratore) e del lavoro nella vita di una comunità (locale e nazionale), scelta europea come dimensione culturale e valoriale irrinunciabile – ha saputo “incanalare” (costituzionalizzare, democratizzare) i sommovimenti sociali del biennio ’68-69, difendere le istituzioni e, contemporaneamente, promuovere/assecondare le grandi riforme degli anni Settanta lanciando l’alfabetizzazione per la riqualificazione culturale ed economica del lavoro operaio meno qualificato (le 150 ore). Molto è cambiato da allora da noi, nelle democrazie avanzate e nel vasto mondo, ma i sindacati non cessano di “qualificare” i sistemi politici e di definirne la qualità democratica. Questo era ieri e l’altro ieri, agli albori della Repubblica costituzionale quando la riconquista della libertà e l’insediamento di una sana e robusta democrazia si accompagnarono all’affermazione di diritti sociali a lungo perseguiti come obiettivo primario. E’ giunto il momento di smettere di considerarci un Paese anomalo; uno sguardo anche superficiale alle realtà a noi vicine e lontane conferma come la c.d. “normalità” non escluda – ovunque - contraddizioni, anomalie, anomie. I tentativi di costruire una società né di destra né di sinistra, e una democrazia diretta (digitale) e senza corpi intermedi (e senza la rispettiva intermediazione) non hanno portato – finora – da nessuna parte (per quanto se ne sa, non possono portare da nessuna parte). Nel mondo umano noto a chi la storia l’ha coltivata e studiata, i soggetti politici e gli attori sociali non possono che “stare qui, sul pezzo, sui fatti e sulle linee di tendenze”, come nel raccontino di Northrop Frye. Si creda o meno nel peccato originale, le ingiustizie hanno popolato, abitano e caratterizzeranno il pianeta umano. E, dunque, ci sarà sempre bisogno del “sapiente” di Kavafis: colui che studia, legge i tempi, suggerisce alla “turba [che] non sente nulla” come affrontare il domani. I “sapienti” come le vestali del mondo moderno.
Al “sindacato nuovo” e al sindacalismo confederale si spalancano praterie di potenzialità. “Gli uomini sanno le cose presenti. / Gli dei conoscono quelle future (…) / Ma del futuro, avvertono i sapienti / ciò che s’appressa”: un mondo nuovo per un lavoro nuovo, e un sindacato nuovo. Non è mai mancato il lavoro per il sindacalista, i tempi sono sempre “complessi”, per usare l’aggettivo di chiusura dei comizi e degli interventi di Pierre Carniti. E’ lapalissiano: nei tempi eccezionali il lavoro del sindacalista sapiente diventa eccezionale.
CON ALTRO SGUARDO
Quanto è grande la gioventù di oggi
di Daniele Mencarelli

Lo ripeto a ogni occasione possibile, spesso avvertendo in chi mi ascolta, o legge, una delusione che proprio non riesco a comprendere. O che comprendo sin troppo bene. Noi adulti, genitori, educatori di ogni ordine e tipologia, semplici cittadini, abbiamo per le mani un patrimonio che dobbiamo accrescere in ogni modalità possibile. Forse solo togliendoci un poco più spesso dai piedi.
Mi riferisco ai giovani di oggi. Dentro questo presente stordito e piegato dalla pandemia di Covid19.
La gioventù che vive di fianco a noi ci è maestra in moltissime cose. Limitare i loro talenti alla sfera digitale, soltanto perché nativi dentro queste nuove tecnologie, è davvero troppo poco.
I nostri giovani sono informati, consapevoli, spesso dotati di un senso di civiltà che tanti dei loro genitori si sognano. Non solo. Hanno attitudine all’impegno verso gli altri, sono consapevoli che i loro slanci non possono e non devono fermarsi ai propri bisogni.
Un’altra loro straordinaria caratteristica, che li pone in termini generazionali finalmente oltre le impostazioni novecentesche, è una rinnovata curiosità verso i temi alti dell’esistenza. I giovani di oggi hanno infranto i tabù ideologici e con curiosità nuova si pongono di fronte alla vita con sguardo interrogativo, senza più il timore di confrontarsi con la ricerca spirituale. Con Dio. Non si accontentano più di narrazioni superficiali, ma spingono per entrare realmente in relazione con se stessi e il mondo. Un po’ ovunque, saltando di continente in continente, sono molte le voci che si levano per esaltare questo patrimonio di gioventù così importante. Anche nel nostro Paese, a partire da Papa Bergoglio, ma sono parecchi anche gli amici scrittori che lo sostengono, sta crescendo il numero di quelli che percepiscono questa meravigliosa e imberbe grandezza. Fatto non così naturale per noi italiani, la nostra è una Nazione fortemente gerontocratica, in cui i giovani vengono visti come una categoria che ha meno da offrire rispetto agli adulti. Questo retaggio culturale, di comodo, è semplicemente sbagliato. I giovani, semmai, hanno qualcosa in più rispetto agli adulti, in termini di passione e non solo. Inutile girarci intorno: la capacità di adesione a un progetto, sogno, da realizzare ha una misura a vent’anni che difficilmente avrà in seguito. Perché a vent’anni più della paura può lo spirito d’avventura, il coraggio della scommessa, e dell’amore. Certe storie che ho avuto la grazia di accogliere stanno lì a dimostrarlo.
Ora che finalmente si comincia a scorgere una nuova vita oltre la pandemia, iniziamo a immaginarci una società civile che abbia anche in posizioni apicali testimoni delle nuove generazioni, ragazzi e ragazze a cui trasferire le nostre esperienze e da cui attingere la loro vitalità, la loro capacità di visione. Non lasciamoli spegnere. Non muriamoci dietro i luoghi comuni del presunto buon senso. La nostra civiltà ha vissuto meravigliosi slanci nel momento in cui ha saputo guardare oltre. E gli occhi dei giovani, il più delle volte, vedono molto meglio dei nostri.
STORIA CONTEMPORANEA
Ogni mese, con interventi affidati allo storico Paolo Acanfora, si propone la rilettura di alcuni avvenimenti o temi della vita italiana e internazionale che si ritengono particolarmente rilevanti ai fini della comprensione della storia contemporanea.
Si tratta di una serie di contributi occasionati da anniversari le cui date sono individuate ripercorrendo, con cadenza decennale, un vasto arco di tempo che parte dal 1901. In questo mese è la volta del 1921.
1921 – La fondazione del partito comunista d’Italia
di Paolo Acanfora
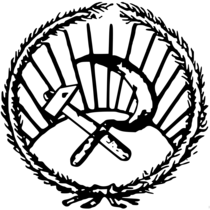
Tra gli anniversari di quest’anno un posto certamente significativo lo ha il centenario della fondazione del partito comunista. Molte nuove pubblicazioni sono uscite o stanno uscendo e, naturalmente, si intrecciano le analisi più o meno nostalgiche degli ex militanti con quelle degli studiosi (talvolta, anch’essi più o meno nostalgici). L’impatto sul dibattito pubblico è comunque piuttosto contenuto, limitato alla cerchia accademica o a ristretti circoli culturali. La proposta comunista è, naturalmente, un fenomeno storico che ha esaurito da tempo la sua incidenza sulla realtà. La pietra tombale posta con la conclusione della guerra fredda non è, a tutti gli effetti, scoperchiabile. La fine dell’Unione sovietica ha chiuso un’intera stagione che si era aperta non nel secondo dopoguerra e nemmeno con la rivoluzione russa del 1917 ma con il “socialismo scientifico” ottocentesco. Si possono proporre tutte le (giuste) analisi sulla distanza incolmabile tra la visione teorica marxista e la realizzazione storica del socialismo sovietico, ma è indubbio che il fallimento drammatico dell’URSS ha chiuso le porte a qualsiasi plausibilità di un progetto di rovesciamento rivoluzionario del capitalismo secondo i postulati dell’analisi comunista.
È del tutto chiaro che la realizzazione storica concreta dello Stato socialista, ovunque sia avvenuta (che sia l’Unione sovietica o la Cina di Mao, la Cuba di Castro o la Corea del Nord di Kim Il-sung, etc.), ha dimostrato senza possibilità di appello la sua incapacità di competere con il modello liberal-democratico, avendo dato vita a regimi irrimediabilmente tirannici e liberticidi.
Eppure la storia del comunismo, dei comunismi nei vari paesi e nei diversi periodi storici, è una storia ricca, articolata, piena di contraddizioni, di passioni, di tragedie, di improvvise convergenze e di altrettanto improvvisi dissensi. Ed è una storia da cui sicuramente non si può prescindere se si vuol capire il Novecento. Non è un caso che la sintesi storica del XX secolo più nota ed evocata è ancora “Il secolo breve” di Eric Hobsbawm. E l’interpretazione del secolo breve (condivisa o meno che possa essere) è esattamente fondata sulla centralità della vicenda rivoluzionaria comunista. Il XX secolo inizierebbe con la prima guerra mondiale – evento incubatore della rivoluzione sovietica – e finirebbe nel 1991 con il crollo dell’URSS. Ma anche se si guardasse alle sole vicende italiane, non potremmo non considerare che per circa mezzo secolo il partito comunista ha giocato un ruolo decisivo, contribuendo a fondare la democrazia repubblicana – che è a tutti gli effetti, ovviamente, una democrazia liberale – e caratterizzandone anche lo sviluppo (sino a difendere, con l’appoggio ai governi di solidarietà nazionale, le istituzioni democratiche dalle minacce del terrorismo neofascista e brigatista).
Questa complessa storia novecentesca ha, per il caso italiano, un’origine puntuale: il gennaio 1921. Per capire le ragioni della scissione dei comunisti dal partito socialista occorre fare riferimento naturalmente alla rivoluzione bolscevica dell’ottobre 1917. La fascinazione del mito bolscevico ebbe un ruolo cruciale nelle masse proletarie (operai e braccianti) dell’Italia (e dell’Europa) postbellica. Le gravi condizioni economiche e sociali del dopoguerra produssero quel che nei libri di storia è noto come il “biennio rosso”, un periodo di tensioni sociali caratterizzato da un numero impressionante di scioperi, manifestazioni, agitazioni. Per dare un’idea dell’escalation può essere indicativo il dato numerico di questi eventi: 300 nel 1918, 1660 nel 1919, 1880 nel 1920. La situazione era chiaramente fuori controllo e il problema dell’ordine pubblico assolutamente prioritario. Nell’ottobre del 1919 il XVI congresso del partito socialista aveva sancito la vittoria dei massimalisti, convinti che fossero mature le condizioni per una rivoluzione socialista sul modello di quanto era avvenuto in Russia. In quello stesso anno, d’altronde, su impulso sovietico, era nata la Terza internazionale e i socialisti italiani vi avevano aderito.
La paura di una rivoluzione mirante alla instaurazione della dittatura del proletariato aveva innescato inevitabilmente una reazione del ceto imprenditoriale, della borghesia, della classe dirigente e uno sviluppo inedito di un movimento nuovo, i fasci di combattimento fondati dall’ex dirigente socialista Benito Mussolini, nati senza grande successo nel 1919 ma che nel giro di poco tempo si legittimarono come il baluardo dell’antibolscevismo e, attraverso l’attività squadrista, come una forza d’ordine nelle campagne e nelle città. Il dato più drammatico di quegli anni è proprio la profonda incomprensione della natura del fascismo, dei suoi obiettivi, della sua cultura politica e l’illusione dei liberali e della classe dirigente tutta di poterlo manipolare, istituzionalizzandolo e controllandolo.
La diffusione della violenza fascista e la sconfitta della strategia rivoluzionaria dei socialisti contribuirono alla svolta del XVII congresso. Tra il 15 e il 21 gennaio del 1921, al Teatro Goldoni di Livorno, l’ala estremista del partito socialista accusava la direzione massimalista di predicare la rivoluzione senza essere in grado di realizzarla perché non all’altezza del compito. Rilanciando la necessità dell’abbattimento violento del regime borghese, i vari Gramsci, Bordiga, Togliatti, Terracini, Tasca abbandonarono il congresso, si riunirono al Teatro San Marco e fondarono il partito comunista d’Italia. Un nome che già ne indicava nel suo complemento di specificazione la natura internazionalista, il suo essere cioè la sezione italiana del’Internazionale comunista. Un aspetto che può apparire marginale ma che segna tutta la differenza con il partito comunista italiano che nascerà successivamente e che esprimerà, sin nel nome, un carattere precipuamente nazionale – di rivendicazione di appartenenza alla storia e al corpo della nazione.
In seno al congresso la posizione più marcatamente ostile a questo orientamento era stata espressa dal leader dell’ala riformista Filippo Turati. La sua posizione era fermamente contraria alla strategia della dittatura del proletario, che interpretava semplicemente come una forma di dispotismo tirannico, ma soprattutto ammoniva i suoi compagni che il loro rivoluzionarismo non avrebbe avuto altro effetto che sollecitare la reazione e rafforzare il fascismo. Quanto queste parole siano state poi confermate dagli eventi è un dato storico inequivocabile. La scissione socialista ha certamente contribuito a frammentare il fronte antifascista, già estremamente fragile in virtù della sua eterogeneità. Non è un caso che anche nella disperata “secessione” dell’Aventino, decisa dai partiti antifascisti in conseguenza degli eventi seguiti al delitto di Giacomo Matteotti, il partito comunista d’Italia fu l’unico a non partecipare.
La complicata storia del comunismo italiano era iniziata e avrebbe subito incontrato sul suo cammino il grande ostacolo del fascismo, interpretato con le lenti deformanti dell’ideologia come l’ultimo stadio del capitalismo. Si apriva una pagina importante della storia nazionale ed internazionale che conoscerà molte altre e diverse tappe.
HOMBRE VERTICAL
Il coraggio delle sfide
Un po’ di memoria per affrontare il presente
di Emidio Pichelan

Tutto sembrava remare contro: a partire dalla struttura scolastica, “qualcosa di mezzo tra una stalla e un deposito”, e continuando con gli alunni assenti – i maschietti nei campi e le ragazzine a casa, in attesa di un precocissimo matrimonio. Naturalmente, pareti spoglie, niente banchi, finestre senza vetri. Ma ci voleva ben altro per sciogliere i sogni e abbattere la volontà del giovanissimo neomaestro Ranjitsnih Disale in quel primo incontro con Zille Parishad Primary School di Paritewadi, distretto di Salapur, nello Stato federato indiano del Maharashtra (la capitale Mumbay – ex Bombay – si affaccia sul mar Arabico). Voleva fare il maestro, spinto dalla convinzione che erano gli insegnanti gli agenti trasformatori della vita delle donne e degli uomini con un misto di gesso e di sfide. Del gesso si può anche fare a meno e, perché no?, anche della tecnologia, ma le sfide non mancano mai. Sotto tutti i cieli e in tutte le latitudini, con o senza pandemia. “La vera potenza della scuola non sta tanto nella tecnologia quanto nella qualità educativa di fare lezione”. E questa è una variabile dipendente dalla passione del maestro, da quanto lui crede in quello che fa e che vuole fare. Una decina d’anni dopo quel primo incontro con la sua scuola elementare (il 3 dicembre scorso) il maestro Disale viene proclamato il miglior maestro dell’anno (1 milione di dollari, metà dei quali “condivisi” con i colleghi finalisti).
L’insegnamento è un’attività umana particolare, per la quale don Milani prevedeva un percorso formativo particolare. Con vera sorpresa trovo che anche Mario Isnenghi, lo storico della Grande Guerra (per la verità, di molto altro, e in un modo decisamente originale), evoca per l’insegnamento i termini “vocazione” e “missione”: qualcosa che “domina e dà senso alla mia vita intorno alla metà degli anni Sessanta e Settanta” (1). Comune era in quegli anni la convinzione che la scuola, il sapere, l’apprendimento di saperi e competenze fossero lo strumento insostituibile per lo sviluppo economico, sociale e politico di una comunità, di un Paese. Dove era pesante il fardello delle povertà materiali le quali, miracolosamente?, anziché strozzarlo sul nascere sembravano alimentare un dibattito partecipato e una gara – virtuosa e proficua – a “sperimentare” nuove modalità didattiche, disciplinari, organizzative. Lo stesso sistema istituzionale si metteva in situazione di sperimentazione.
La fase più creativa, per chi assumeva il sistema scolastico come ascensore sociale insostituibile – e, dunque, di giustizia sociale ai sensi del sontuoso art. 3 della Costituzione – e, perché non sottolinearlo con la dovuta enfasi?, anche come luogo di un gratificante nuovo protagonismo dei giovani insegnanti in ingresso nel mercato del lavoro, si snoda tra il 1962 (istituzione della media unica) e il 1974 (emanazione dei Decreti delegati e di quell’unicum costituito da “le 150 ore”(2). Senza dimenticare la circolare del ministro Franco M. Malfatti che “consentiva” – da apprezzare la delicatezza del verbo usato dalla burocrazia – la “sperimentazione didattica e organizzativa” dell’offerta formativa istituzionale. La sperimentazione degli anni Settanta ha molti padri e madri ma, come illustrato nel nostro “Scusate il disturbo”(3), un merito particolare spetta senza dubbio a “Lettera a una professoressa” e all’esperienza della scuola di Barbiana(4).
“Gli ho chiesto di quel tempi,/ quando ancora eravamo giovani,/ ingenui, impetuosi, sciocchi e sprovveduti./ È rimasto qualcosa, tranne la giovinezza/, - mi ha risposto./ Gli ho chiesto se sa ancora di sicuro/ cosa è bene e male per il genere umano./ È la più mortifera di tutte le illusioni,/ - mi ha risposto./ Gli ho chiesto del futuro,/ se ancora lo vedo luminoso./ Ho letto troppi libri di storia,/ - mi ha risposto”(5).
A dire il vero, di quell’esperienza è rimasto più del qualcosa di cui parla la mite, disadorna poetessa polacca: quella scuola è stata capace di cambiare la vita dei ragazzi fortunati nel trovare insegnanti motivati, e ha insegnato che nella vita professionale occorre osare, sfidare la tradizione, rimettere in discussione i luoghi comuni, essere protagonisti del cambiamento. La ricetta miracolosa della buona scuola sta nella passione, nel crederci, nel fare quello che si può e anche di più senza aspettare il riconoscimento economico, la stima sociale, la glorificazione da parte di un mondo troppo distratto e/o preoccupato per capire l’importanza che i ragazzi stiano a scuola. E, soprattutto, che ci stiano bene, ben messi al centro del progetto formativo.
Quell’esperienza innovativa non è durata più di un decennio, poi sono venute le controriforme neoliberiste dei tagli (delle risorse e del tempo scuola e delle materie curricolari, del ritorno dei voti decimali e di quello “opzionale” dei grembiuli) e delle riforme finite su binari morti (perché velleitarie e/o non capite e/o non gradite e/o rifiutate). Al netto degli sconquassi indotti dalla pandemia (per dirne una: nessun Paese a noi comparabile ha chiuso le scuole tanto a lungo), la situazione del nostro sistema scolastico non è dei più soddisfacenti. Dati alla mano, è come se cavallette fameliche avessero estirpato fino all’ultimo dei semi piantati nel biennio 1950-70.
I dati dicono che il sistema è tornato a essere (quasi) quello denunciato, nel 1970, da “La riproduzione. Sistemi di insegnamento e ordine culturale” di P. Bourdieux e J.C. Passeron(6): la funzione di riproduzione sociale anziché di motore dello sviluppo, garanzia del diritto allo studio e dell’eguaglianza di partenza dei nuovi cittadini.
L’Italia è il Paese che meno investe sulla scuola tra i 37 Paesi dell’Ocse (e non sarà un caso che sia anche quello che ha perso più tempo nel discutere di banchi a rotelle e di formazione a distanza); il drop out 2020 viaggia ancora al 13,5% contro il 10,2 della media europea (ma Belgio e Lettonia vantano un più che rassicurante 8%). Secondo i dati Istat del secondo trimestre del 2020, il 62,8% degli italiani tra i 25 e i 64 anni non va oltre al diploma superiore, solo il 27,9 dei giovani tra i 30 e i 34 anni è in possesso di un titolo universitario (contro il 42,1 degli altri Stati europei, un gap negativo di più di 10 punti percentuali!), il 23,9% dei giovani tra i 15 e i 29 anni né studia né lavora. A proposito del blocco dell’ascensore sociale chiamato scuola: secondo l’Inapp, l’Istituto nazionale per l’Analisi delle politiche pubbliche, appena il 12% dei giovani ha la probabilità di arrivare alla laurea se i genitori possiedono la licenza media, la percentuale si dimezza bruscamente se mamma e papà non hanno alcun titolo di studio, mentre si impenna al 48% in presenza di genitori diplomati.
“Siamo anormali”, afferma A. Prosperi, storico di meritata fama e di bella scrittura, “l’Italia è un Paese bellissimo per natura e arte, malata nelle istituzioni, nell’assenza di regole, nell’ingiustizia di un sistema fiscale fondato sull’evasione, nella mancanza di unità nazionale, dove i dettami della Costituzione restano buone intenzioni mai prese sul serio. Un Paese governato nell’ultima fase con dosi omeopatiche di paura e un po’ di ristori”(7).
Non mancano buoni motivi per essere pessimisti, ma nessuno definitivo. La settimana scorsa un Papa Francesco, evidentemente affaticato diceva messa nella cattedrale Immacolata Concezione di Qaraqosh, conquistata nel 2014 con il ferro e il fuoco dall’ISIS, dalla quale, in una sola notte, fuggivano 120mila cristiani e ben presto trasformata in poligono da tiro. “Questo nostro incontro”, scandiva il vecchio pastore biancovestito, “dimostra che il terrorismo e la morte non hanno mai l’ultima parola”.
Pochi giorni prima, dall’altra parte del mare oceano, un altro vecchio – il secondo cattolico tra i 46 Presidenti americani – nel giurare solennemente come neo Commander-in-Chief di un Paese (ancora) grande, seppure devastato dalla pandemia e sotto shock per il vulnus del 6 gennaio scorso, aveva il coraggio di chiedere a una giovanissima poetessa afroamericana di trovare le parole più idonee per rispondere alla domanda delle domande: se e come è possibile uscire da un’ombra che non pare finire mai? “Mentre la democrazia può essere talvolta rinviata,/ mai potrà essere sconfitta permanentemente./ In questa verità, in questa fede noi crediamo,/ perché mentre noi abbiamo i nostri occhi fissi sul futuro, la storia li ha su di noi./ Perché c’è sempre una luce,/ se soltanto noi siamo coraggiosi abbastanza per vederla,/ se soltanto noi siamo coraggiosi abbastanza per essere noi quella luce”(8).
La storia antica e recente dice – e noi nella storia crediamo– che dal fondo si rimbalza con nuovo vigore. Una pandemia ai tempi della terza (o quarta? o quinta?) rivoluzione industriale e tecnologica non può non insegnare a tutti, anche i “duri di cervice”, alcune (antiche) verità: la centralità dello Stato, ad esempio, l’importanza delle istituzioni, il dovere della solidarietà, il rispetto reciproco – anzi, meglio, dell’amicizia sociale di cui parla Papa Francesco. Nonostante le evidenti distrazioni, tutti, ma proprio tutti sono convinti dell’intreccio tra sviluppo e formazione (di base, secondaria, universitaria, continua). E tra formazione e la passione di cambiare il mondo, come ci hanno ricordato agli inizi di queste righe il maestro indiano e Hannah Arendt.
Mai come in questo momento è il caso di cercare e di fomentare e di usare quella componente, difficile da quantificare, ma essenziale per il “nuovo” mondo e il “nuovo” sistema dobbiamo costruire: la passione (e il coraggio delle sfide).
(1) M. Isnenghi, Vite vissute e no. I luoghi della mia memoria, Il Mulino, 2020
(2) F. Lauria, Le 150 ore per il diritto allo studio, Edizioni Lavoro
(3) E. Pichelan, Scusate il disturbo, stiamo imparando, Edizione Overview, Padova 2017
(4) Oltre a Scusate il disturbo, riteniamo doveroso citare almeno altre due testimonianze: Quando la scuola si accende. Innovazione didattica e trasformazione sociale negli anni Sessanta, quaderno di Venetica, rivista di storia contemporanea, Cierreedizioni, a. XXVI, 26/20212; e il seminario Fra sogno e realtà. Le scuole sperimentali milanesi negli anni 70, tenutosi presso l’Umanitaria di Milano il 6 novembre 2014, curato da Cristina Cocilovo e Maurizio Gusso, presidente di IRIS, Insegnamento e Ricerca Interdisciplinare di Storia, e animatore di Milanosifastoria.
(5) W. Szymborska, Il vecchio professore (Meta Morphosis blog)
(6) Da notare la sequenza di titoli che racconta la vivacità della riflessione e delle proposte sul sistema scolastico: 1967, Lettera a una professoressa; 1970, La riproduzione appena citato; 1971, Deschooling society di Ivan Illich, volume “scandaloso” che arrivava a proclamare la morte del sistema scolastico e, in generale, delle istituzioni.
(7) Cfr. Robinson, suppl. de La Repubblica, 6 marzo 2021.
(8) A. Gorman, “The Hill We Climb”, 2021.
LA POESIA DEI LUOGHI
Un giardino di Parigi
di Gianni Gasparini

Questo periodo di isolamento o confinamento e di limitazioni alla mobilità all’interno del nostro paese è servito se non altro a ricordare a ognuno le proprie appartenenze di regione e talvolta di provincia, messe in evidenza e persino esacerbate dalla distinzione tra zone contrassegnate da colori (rosso, arancione, giallo, bianco…manca il verde!) in funzione delle possibilità di aperture e di spostamenti. Credo che quando furono create le regioni a nessuno venne in mente che questo fatto istituzionale avrebbe avuto risvolti pratici così singolari e differenzianti, oltre che – ma questo era più prevedibile – carichi di tensioni tra governo centrale e singole regioni.
Da un anno recarsi all’estero per turismo rappresenta qualcosa di eccezionale, tanto quanto prima era facile e normale. Ma questo non impedisce di pensare, di immaginare. Penso allora alla Francia e a Parigi, al Quartiere Latino dove abitai anni fa e dove ho soggiornato moltissime volte. Mi immagino mentre scendo ancora una volta dal tgv alla Gare de Lyon e mi avvio a piedi verso l’appartamento dell’amico che mi attende. Varco la Senna ed entro nella Rive Gauche, guardo in direzione dell’abside di Notre Dame e per la prima volta la vedo tutta fasciata e bendata dopo il colpevole incendio dell’aprile 2019 che l’ha in parte distrutta e ne ha polverizzato la guglia orgogliosa e bellissima.
Parigi è una città multiforme come poche altre, attraente anche perché è un insieme di universi accostati che interagiscono tra loro, come ben si percepisce seguendo l’estensione di ciascuno dei venti arrondissements in cui si articola il territorio urbano. Tra i luoghi e ambiti memorabili di Parigi vi sono i parchi e i giardini, presenti nelle zone sia centrali che periferiche della metropoli. Impossibile ricordarli tutti, ovviamente. Mi limito a nominare luoghi che mi vengono alla mente e ai quali associo immagini di bellezza e serenità, di benessere condiviso con gli altri frequentatori: come il Parc de Vincennes e il Bois de Boulogne, il Parc Monceau, il Jardin des Plantes, le Tuileries, le Buttes Chaumont…
Scelgo ora un giardino tra i più ampi e antichi, quello che nel cuore del Quartiere Latino si affaccia al Boulevard Saint Germain: è il Jardin du Luxembourg, creato quattro secoli fa da Caterina de’ Medici e frequentato in tutte le stagioni dell’anno dai parigini e da coloro che passano per la capitale francese. Mi si affaccia il ricordo della prima Festa della musica, istituita in Francia nel 1982 dai ministri Jack Lang e Maurice Fleuret sotto la presidenza di François Mitterrand e che da allora si celebra ogni inizio d’estate, la sera e la notte del 21 giugno. Mi trovavo quella sera al Luxembourg quando i primi giovani a gruppi in diverse zone del giardino iniziarono a suonare, con gli strumenti più diversi, musiche di tutti i generi. In pochissimi anni la Festa della musica si è diffusa ampiamente in parecchi paesi, tra cui l’Italia, venendo associata al solstizio d’estate.
Il Giardino del Lussemburgo esprime un’armonia discreta dominata dal verde degli alberi e delle aiuole, e sembra accogliere benevolmente chiunque desideri passarvi qualche minuto o trascorrervi alcune ore. Tanti sono i mondi che si accostano fra loro in questo giardino, dove è facile sentirsi a proprio agio. Chi vuole sostare utilizza le panchine o le caratteristiche sedie di ferro che un tempo erano a pagamento: un anziano incaricato passava ogni tanto a chiedere pochi centesimi per l’uso della sedia, ora gratuita.
Sono soprattutto i bambini a godere delle opportunità che il Lussemburgo offre: lo spazio della sabbia, i giochi, le allées per correre, il bassin dove si muovono sull’acqua le barchette governate da terra, il teatrino con gli spettacoli di marionette, la giostra al riparo degli alberi. Ricordo una caratteristica della giostra, che non credo sia più operante: la signora che la curava, una donna paziente dal viso stanco e scavato, porgeva ad ogni bambino che montava un bastone con il quale bisognava cercare di infilare al volo, mentre la giostra girava, un anello che la signora teneva teso in alto: chi ci riusciva per primo vinceva un altro giro di giostra.
Tra i tanti aspetti del Lussemburgo, uno particolare è la garderie de plein air, una sorta di asilo all’aria aperta fondato nel dopoguerra da un’associazione privata. che consente al pomeriggio di alcuni giorni feriali della settimana di lasciare i bambini piccoli (non ancora scolari delle elementari) a giocare all’aperto sotto la sorveglianza di alcune insegnanti, in uno spazio recintato con la sabbia, lo scivolo e poche altre cose. Ricordo che questa garderie aperta a francesi e stranieri di passaggio era molto amata anche dai genitori, ai quali consentiva qualche ora di rilassamento e di immersione nelle opportunità culturali della città senza la preoccupazione di dover accudire ai figli.
La bellezza elegante del Lussemburgo, di cui sto scrivendo, è apprezzata da moltissime persone, sia di Parigi che di altre provenienze. Parigi ha una storia straordinaria e unica in Europa, che sta all’origine della sua attrattività per i turisti, i viaggiatori e gli operatori di tutto il mondo. La città è portatrice di un suo particolare “spirito”, un genius loci peculiare che non si rintraccia in altre metropoli e che è fatto di accoglienza della modernità e delle tecnologie più avanzate, di una capacità di ripensarsi continuamente in termini urbanistici e culturali, così come di un’attenzione al rendimento economico di ogni attività. Creatività e ricerca a tutto campo sono forse due espressioni chiave per tentare di cogliere la realtà sfaccettata di questa città-metropoli, che – non si può dimenticare – ha conosciuto negli ultimi anni l’oltraggio di gesti terroristici feroci e inauditi, da Charlie Hebdo al Bataclan e ad altri.
Mi chiedo allora: dove si può annidare la poesia nella vita di Parigi oggi, al di là dei cliché e delle immagini stereotipate? La risposta non può che essere soggettiva e mettere in gioco i sensori poetici di chi sia attento al linguaggio dei luoghi. Ci può essere poesia nella prospettiva di un ponte sulla Senna attraversato di primo mattino o di un vicolo solitario della Rive Gauche, in un volo radente di rondini tra le mansarde a primavera, o nel mercato di Belleville sfolgorante di colori e di aromi esotici il martedì e il venerdì di ogni settimana.
Per chi ama il Lussemburgo, la poesia sarà forse quella che un uomo accoglie dentro di sé mentre si accomoda su una sedia di ferro del giardino e in silenzio guarda lontano.
LETTURE
Adolescenza: istruzioni per l’uso
di Leonarda Tola

“Messo t’ho innanzi: omai per te ti ciba” (Paradiso X)
Marco Erba (1981) è un professore di Liceo che ha esordito come scrittore pubblicando con successo, prima in rete e poi con Rizzoli (2016), “Fra te e me”. A seguire altri libri che ormai lo hanno consacrato scrittore per ragazzi; l’autore è infatti consigliato da genitori e insegnanti che comprendono l’utilità per i giovani delle buone letture. Per incontrare l’autore e capirne la vocazione e il mestiere è necessario cominciare dalla sua prima opera.
Il perché del titolo è nel primo capitolo: “Fra te e me”. È la distanza che Edoardo, liceale della seconda C, marca con decisione nei confronti di zingari, negri, mulatte, gente dell’Est…. “Un abisso, un muro invalicabile” di inconciliabili differenze: “Io sono biondo, tu sei moro. Io sono elegante, tu sei vestito di stracci. Io ho l’abbonamento, tu sei senza pagare. Mia madre lavora, tua madre ruba. Io vivo in una casa ordinata, tu chissà in quale buco. Io sono onesto, tu sei inaffidabile. Io sono un italiano, tu sei uno zingaro. E io gli zingari li brucerei tutti. Come faceva Hitler”. Niente, in confronto all’odio smisurato che il ragazzo cova contro i cinesi: perché è colpa loro se il padre ha dovuto chiudere il suo negozio scivolando poi nell’abbruttimento, la malattia, la morte.
Edoardo è una delle due voci narranti che nel romanzo si alternano, in parallelo ma distinte, immettendo il lettore dentro il vortice di vite adolescenziali raccontate nel loro incandescente marasma: anche al femminile, con l’altra voce, Chiara, stesso Liceo seconda D, che nelle sue “Memorie” procede per sei tappe di una metamorfosi da “bruco sognatore", a “quasi farfalla”, a “farfalla”, a “farfalla ferita”, a “bruco che si credeva farfalla”, a “farfalla che si credeva bruco”.
È necessario sapere che Marco Erba per scrivere di adolescenti decide, con coraggio e sprezzo del pericolo, di farsi ‘possedere’ dalla mente di adolescenti che conosce fino al midollo, riuscendo a strappare loro anima e corpo e a scorticarli vivi. L’anima è il cielo segreto ora folgorato dai bagliori dell’euforia, ora immobile nella quiete estatica delle stelle fisse che è l’esperienza adolescenziale: slanci e cadute, entusiasmi e inquietudini, ardimenti e paure, allegria e disperazione, generosità e viltà, baci e pugni, ribellione. Il corpo è la lingua (l’italiano) con cui in questo libro i ragazzi di oggi in prima persona rappresentano il mondo e se stessi. In questa impresa titanica di imitazione-riproduzione del lessico e della grammatica giovanili Marco Erba tocca vertici di perfezione mai sfiorati da altri. Così autenticamente ‘da adolescenti’ è la scrittura (il parlato) dei due protagonisti che si stenta a credere che a scrivere sia un adulto con tutti i crismi. Lo dicono i commenti lasciati in rete, soprattutto di studenti coetanei, che dichiarano di rispecchiarsi nei personaggi del romanzo; anche per la parte, che non poteva mancare, della onnipresente connessione social: l’aria che i ragazzi respirano, la linfa di cui si nutrono e il veleno di cui possono morire. Così come non manca l’iniziazione crudele riservata ai più fragili come Chiara, “bruco sognatore”: “Non erano bulli, erano peggio, due iene, sempre a riderti alle spalle con la faccia da bastardi”… “L’età delle medie è la peggiore che ci sia”.
La verità profonda delle storie loro e dei simili a loro che fanno fatica a crescere, è tutta nella veridicità autentica del linguaggio. Il loro pensiero detto con le loro parole, il pensare e il fare, lo spendersi e smarrirsi, in una sintassi senza subordinate come è nella grammatica elementare delle vite tutte ancora da costruire: non ci sono periodi ipotetici di alcun tipo con i quali introdurre o assumere sguardi altri o punti di osservazione estranei. Questi ragazzi sono stati mostrati nella loro nuda impotenza. Per questo sono commoventi fino a sconvolgere i lettori adulti spinti a voler accorrere in loro aiuto, a lanciare zattere di salvataggio, a strapparli ai loro naufragi.
Evidentemente a questo ha ben pensato l’autore che, per quanto si sia fatto come loro, non è uno di loro e non ha creato Edoardo e Chiara per lasciare che soli si perdano. Senza farsi vedere né sentire, parlando come loro e per loro conto, li guida e accompagna ad orientare la bussola per dare un senso e la giusta direzione alla navigazione. Nell’età in cui ci si affaccia in mare aperto. E lo fa da maestro.
SUL FILO DEL TEMPO
Maggio, la rosa fiorisce senza un perché
di Mario Bertin
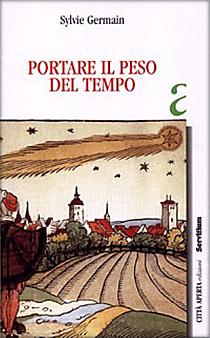
Maggio è nella tradizione il mese delle rose. Delle rose e del rosario. Recitato dagli abitanti della casa Salina, dal principe, dai parenti, dai servi e financo dall’alano Bendicò, come narra Tommasi di Lampedusa all’inizio del Gattopardo. Ma pure – fino a non molto tempo fa – in molte case della penisola. O presso le edicole dedicate alla Vergine agli incroci delle strade di campagna. O nei punti usuali di ritrovo. Tante voci frammiste tessevano, nel buio tiepido e profumato dei dopocena di maggio, “un brusio ondeggiante sul quale si distaccavano i fiori d’oro di parole inconsuete: amore, verginità, morte”.
Anche la scrittrice francese Sylvie Germain, parlando di maggio, fa riferimento alle rose. In particolare della rosa di Angelus Silesius, della rosa “che è senza perché”. E il pensiero si dilata e si approfondisce immediatamente in poesia e bellezza.
Silesius, poeta e mistico del Seicento, in realtà faceva di nome Giovanni Scheffer. Era nato a Breslavia. Studiò medicina a Strasburgo e a Padova. Per alcuni anni fu medico di corte. Disgustato della freddezza del protestantesimo del suo tempo, passò al cattolicesimo e cambiò il nome in quello di Angelus Silesius. Fu ordinato sacerdote e raccolse le sue meditazioni in un libro di versi intitolato Il viandante (l’errante) cherubico. Ignorato per lungo tempo, fu scoperto soltanto nella metà dell’Ottocento da poeti e filosofi, tra i quali da Rilke e Shopenhauer. Hegel, prima, e poi Heidegger lo collocarono tra i sommi.
Tra Silesius e Sylvie Germain (che peraltro fu allieva di Lévinas) esiste una particolare affinità, una uguale profondità metafisica e un simile colore onirico delle opere. Ambedue hanno saputo tessere insieme filosofia e immaginazione, il visibile e l’invisibile in sintesi di una evocazione inesauribile.
Quando parlano della natura, ambedue non pensano e non dipingono il paesaggio, ma rivelano un pensiero profondo che nutre la loro immaginazione poetica. Tutto ciò risalta con molta evidenza nel brano di Sylvie Germain che proponiamo qui di seguito e che è tratto dal suo libro Portare il peso del tempo (Città Aperta Edizioni, Troina 2005).
Fiorisci, raggelato cristiano
«Fiorisci, raggelato cristiano, maggio è alla porta! / Resti morto per sempre, se non fiorisci qui e ora», dice Angelus Silesius nella sua raccolta Il pellegrino cherubico. Ma come far fiorire una rosa d'inverno, costringerla a passare attraverso la neve, ad aprire i suoi petali che scricchiolano di brina? Come rianimare la linfa, sfidare il gelo? E in certi momenti d'intenso dolore, di lutto, di prova estrema, come trovare il piacere e la forza di cantare le rose? Ricordandoci, dal profondo dell'oblio che ci intorpidisce, del dolore che ci mortifica, che «maggio è alle porte», che la vita non dice mai la sua ultima parola, che la bellezza rimane sempre in gestazione. Facendo un'opera di memoria e, nello stesso tempo, proiettandoci nell'eterno avvenire del tempo, rifiutando dunque la pietrificazione, la riduzione del tempo allo spaventoso presente folgorato dalla sventura. Ricordandoci che il tempo è a più dimensioni, che ha a monte un tratto remoto e a valle un tratto non localizzabile, che è stato inseminato da una promessa prodigiosa e che è irrorato da un mistero infinito.
«La rosa è senza perché: fiorisce perché fiorisce / A se stessa non bada, che tu la guardi non chiede», recita un altro verso di Angelus Silesius. Nessuna causa precisa giustifica la sua fioritura, nasce e cresce in piena libertà, in piena gratuità, mossa da un desiderio totalmente disinteressato, per amore dello spazio, della luce. Non fiorisce solo nei giardini, nei parchi e nelle serre, spunta anche nella natura, persino tra le macerie, i calcinacci, gli sterpi. E forse proprio lì, tra le rovine e nel fango, la sua bellezza inaspettata si fa più splendida. Una rosa che sboccia in mezzo alle ortiche, che si slancia fuori della neve, che rosseggia nel deserto, che biancheggia contro un muro di cemento, spicca e abbaglia più di quella che cresce in un roseto fra migliaia di altre perché allora ci chiediamo da dove possa venire, da quali oscure profondità abbia attinto la sua forza, il suo slancio.
Una rosa d'inverno proclama magnificamente quanto la bellezza appartenga alla sfera della grazia e della prodigalità; si drizza, senza curarsi di essere ammirata, fragile e tuttavia pugnace, fugace e sconvolgente, come un infimo miracolo nato dalla terra e che sfida la propria pesantezza per rivolgere al cielo un saluto splendente, un sorriso grave e insieme di un'insolente dolcezza, anche quando il cielo è plumbeo e le radici della rosa sono rattrappite per il freddo, il dolore e la notte. Fiorisce perché vuole farlo, mossa da un desiderio senza controllo né misura.
Senza un «perché» diverso dall'amore. L'amore della terra e del cielo, congiuntamente.
L’ANIMA E LA LIM
I demoni di questa primavera
di Lorenzo Gobbi

La primavera è tornata con un passo imprevisto, e l’anima non sa come disporsi alla danza che aspettava di condividere con le rondini nel fiorire dei peschi, dei meli e dei ciliegi – diversa, sincopata: un ritmo quasi invertito, zoppicante (ho zoppicato da ottobre fino a due settimane fa, a causa di un infortunio alle anche e alle vertebre lombari, ma sono andato a scuola ugualmente, lentissimo, curvo, dolorante sul bastone ortopedico, incerto su qualsiasi terreno), intriso di fatica e di incertezza, traballante e malfermo.
Da un lato, lo sbigottimento: ancora? Come un anno fa? Ciò che abbiamo sofferto e durato non è servito a nulla? Finirà mai? Come andare avanti?
Dall’altro, il sospetto spaventoso e sottile, il timore che ci è difficile verbalizzare: i vaccini saranno sicuri? È gestita bene questa emergenza? Perché le cifre ondeggiano così, e la conta quotidiana dei morti e dei contagiati sembra sfuggire a qualsiasi logica, non solo a quella della speranza ma anche a quella delle legittime, ragionevoli aspettative?
Un senso di inquietudine ci attraversa la schiena come un brivido: “e se... se...” Le voci che ci risuonano intorno, non solo sui media e sui social ma anche tra amici e nelle famiglie, non si limitano a sussurrare suggerendo dubbi e ipotesi ansiogene, ma ormai le gridano ovunque: siamo divisi, inquieti, visitati da demoni inquietanti. Le divinità, insegna l’induismo, sono milioni; altrettanti, i demoni; però, mentre le divinità celesti, che partecipano a sfere dell’essere (della “manifestazione”) elevate, luminose e aeree, vengono benevoli tra noi come portatori di armonia, i demoni vivono sottoterra ed entrano ed escono dalla nostra realtà che si trova nel mezzo: in essa agiscono modificando e distruggendo, invadendo e possedendo, sottraendo e abitando - non sempre, ma spesso devastando. Sono gli dei della manifestazione precedente, cioè della precedente era del cosmo, o meglio: gli dei del precedente Manvàntara, rimasti sepolti sotto la crosta di terra che il diluvio distruttore che ha posto fine a tale era ha lasciato quando si è ritirato dalla terra (stiamo vivendo il settimo di 14 Manvàntara). Usando questa categoria mitica e ancestrale, che mi sembra ricca di spunti psicologici, credo che possiamo tratteggiare i lineamenti di alcune inquietudini che sembrano popolare e stravolgere i volti e i sentimenti e alterare le relazioni rendendole irriconoscibili, oggi come oggi, nella seconda primavera del Covid-19.
Ciò che viviamo ora non è più lo spavento dei primi attimi della pandemia che ha stravolto il mondo intero, quanto lo sgomento di un mancato rinnovamento, di una fallita restaurazione del cosmo: non è andato tutto bene, e non possiamo dire se lo sarà; ciò che sembra tradirci non è la solo potenza incontrollata e indomabile della natura, che ha suscitato contro di noi una minaccia invisibile ma micidiale (le “frecce” di Apollo nell’Iliade erano esattamente questo, così come il “colpo d’elfo” della mitologia nordica), capace di rinnovarsi per tornare a colpire, quanto piuttosto la nostra fiducia nei governi, nella scienza medica, nelle tecnologie farmaceutiche, nella politica internazionale e locale, nei comportamenti che avrebbero dovuto salvarci e ancora non l’hanno fatto – così sentiamo, e così avvertiamo nel profondo, con un terrore ancestrale: non c’è fiducia che resista, e nella fiducia profonda, quella che sostiene le nostre vite, ci sentiamo indeboliti e scossi. Dal sussulto delle profondità in cui ribolle la lava e le rocce si fondono si liberano i demoni, e vengono a popolare irrequieti, rapidi, mobili e sfuggenti, le vie delle nostre città e i corridoi delle nostre scuole, seminando inquietudine e sospetto, agitando le acque già inquiete del nostro spirito. L’inquietudine sussurra, serpeggia, si insinua in forme demoniache sotto forma di voci che ci raggiungono e si moltiplicano echeggiando dentro di noi, al punto che la nostra voce diventa irriconoscibile: il mormorio del sospetto, ad esempio, agita le nostre notti – forse qualcuno trama nell’ombra e trova complici, ordisce inganni e prepara subdolamente nuovi mali al nostro mondo grazie a una rete di connivenze estesa e temibile. Dunque, chi non vuole vaccinarsi (oppure chi l’ha fatto), chi non si indigna abbastanza per il cattivo funzionamento delle reti internet di istituto, chi desidera che tutti i docenti vengano a scuola per gli studenti disabili e Bes oppure chi su queste disposizioni solleva dubbi, chi vorrebbe l’immediata riapertura delle scuole senza se e senza ma e chi la sente come un’inutile e crudele esposizione alla minaccia del virus... tutte queste persone suscitano in alcuni di noi, senza che riescano a comprendere perché, un livore che stupisce anche chi lo prova: sembra trattarsi di persone che appartengono alla schiera dei nemici, cioè che siano gli alleati di ciò che ci minaccia: come tali desideriamo combatterli e realmente proviamo qualcosa di simile all’odio di Achille per Ettore.
Un senso doloroso e sottile di offesa patita, poi, cerca a volte le proprie ragioni aggirandosi nell’ambiente in cui viviamo: a qualcuno dovrà pur essere imputato il disagio che avvertiamo; qualcuno ne dovrà pur essere responsabile – e così, una banale divergenza su una modalità di lavoro diventa “una questione di principio” che suscita in noi un’aggressività devastante, oceanica – uno tsunami emotivo incontrollabile che si riversa sui familiari e sugli amici ma anche sulle classi, sulle famiglie e sui colleghi, o da loro si abbatte su di noi con furia primordiale. Gli esempi si potrebbero moltiplicare, ma ciò che li unisce è l’intensità emotiva di un senso di offesa e di rabbia, di minaccia e di rancore che non si presta all’analisi razionale ed è molto difficile controllare; e dunque una polarizzazione del nostro mondo interiore, diviso tra offesa e difesa, odio e amore, fiducia calda e assoluta, quasi mistica, e sprezzante sfiducia che sconfina nel livore.
“Siamo tutti schizzati”, sento dire spesso: colleghi e genitori, soprattutto. La primavera giunge a passo stanco, incerto: l’incertezza pesa, e non da ieri; la stanchezza si fa sentire; la fiducia, più o meno in tutti noi, si è almeno in parte incrinata o si vede sottoposta a sollecitazioni distruttive. Non si tratta, però, della fiducia nel dirigente scolastico, nel docente, nel governo, nel sindaco o nell’azienda farmaceutica: ciò che sentiamo scossa da una molteplicità di fattori è una fiducia ancestrale, arcaica, psicologica e profondissima, cioè la fiducia che potremmo definire “originaria”. C’è in noi, vivissimo, un senso forte e sotterraneo della bontà della vita, del suo essere preziosa e degna di essere vissuta; in esso troviamo le ragioni per affrontare le incertezze e le ansie, i lutti e le sofferenze che ci vengono incontro; ad essa spesso torniamo, la confermiamo, la rafforziamo, la moduliamo nel rapporto con la durezza a volte crudele degli eventi; ad essa ci aggrappiamo quando ci sentiamo sviliti e colpiti ingiustamente – considerati meno di zero dalle persone o dagli accadimenti, disprezzati al punto di trovarci calpestati. È questo sommovimento interiore che libera i demoni e permette alle loro voci di echeggiare in noi.
La pandemia è un trauma collettivo in pieno accadimento, nel quale i drammi individuali (i lutti, le malattie, le ansie, le limitazioni, i sacrifici, le difficoltà economiche...) si assommano e trovano il proprio orizzonte; non è ancora finita, e sta attraversando una fase nuova – critica, e non poco: siamo messi a durissima prova, scossi proprio nella fiducia originaria. Donald Kalshed (nei suoi saggi Il trauma e l’anima e Il mondo interiore del trauma, solo per citare due “classici” recentissimi della letteratura analitica sull’esperienza traumatica e ciò che genera in noi; ma consiglierei anche Christopher Bollas nel suo recente L’età dello smarrimento. Senso e malinconia, e i brevi, intensissimi essay che la scrittrice britannica Zadie Smith ha dedicato in presa diretta alla pandemia, raccolti in Questa strana e incontenibile stagione) spiega bene come la difesa istintiva da un’esperienza traumatica sia la scissione, in varie forme: ciò che in noi è minacciato, ciò che viene ferito, si trova a essere scisso e messo da parte, separato o riversato e nascosto in altro, perché sia al sicuro; e le difese si attivano oltre misura, primordiali e oceaniche, per garantirne la sopravvivenza e l’integrità, scagliandosi istintivamente contro tutto ciò che si avvicina a quel nucleo vulnerabile e prezioso.
Forse è proprio ciò che ci sta accadendo: il genitore accorre in difesa del figlio (minacciato, in realtà, dalla pandemia e dagli incerti scenari del futuro, dai quali il padre non lo può salvare) scatenando un’aggressività terribile e feroce contro un docente per un episodio o una divergenza che in un tempo “normale” sarebbero passati inosservati o al massimo avrebbero richiesto un chiarimento cortese e professionale – e così coalizza gli altri genitori, arringa i compagni di classe del proprio figlio convincendoli a boicottare il docente, scrive al preside, al giornale locale e all’ufficio scolastico, esige di essere ricevuto dalle massime autorità del caso e di vedere il docente almeno punito se non addirittura licenziato in tronco.
Accade, così, che la votazione sul documento riguardante i curricoli di istituto di educazione civica diventi una lotta contro la degenerazione del sistema dell’istruzione e dei valori dell’occidente: chi si astiene (come è legittimamente previsto dal regolamento) esige stavolta che si verbalizzi che non partecipa alla votazione perché si sente esule nell’istituto, in Italia e in Europa e dunque in futuro non prenderà più parte a ciò che accade nella scuola né voterà alle prossime elezioni (impossibile replicare, né tentare una riflessione per placare l’animo del collega: significherebbe mettersi dalla parte di coloro che, di comune accordo, minacciano per pura cattiveria il mondo intero a partire dalla nostra scuola). C’è chi si trova a togliere il saluto alla collega che non ha voluto vaccinarsi e pretende che anche i colleghi rifiutino di parlarle finché non si sarà vaccinata; c’è chi, invece, si scaglia con veemenza contro chi non condivida la sua idea che il governo abbia deciso di vaccinarci con AstraZeneca “perché ci stanno usando come cavie” nel solco della tradizione per cui “gli insegnanti sono considerati meno di zero”: “la nostra vita non vale nulla, e la scelta di questo vaccino per i docenti lo dimostra senza ombra di dubbio”; e via dicendo.
Il trauma è ancora in atto, a livello individuale e a livello collettivo: c’è chi reagisce irrigidendosi e ripiegandosi su di sé, chi congelandosi ed estraniandosi, e chi sentendosi squassato da un magma emotivo che ribolle all’interno e cerca vie d’uscita. Così, i demoni si riversano nelle strade e nelle piazze, nelle aule e nei corridoi, negli uffici di presidenza e nelle sale docenti: agiscono, devastano. Dividono, più che altro: scindono, frantumano, separano ciò che si sente minacciato; insinuano, sussurrano o anche gridano con voce sovrumana (nulla era più terrorizzante, per la mitologia greca, dell’urlo improvviso che sgorgava dalla gola di Pan nel silenzio delle selve: il “panico” ne era l’effetto; ne fa oggetto di riflessione James Hillman, Saggio su Pan). Ne siamo vittime, chi più chi meno, tutti: almeno, ne siamo minacciati. Sono i demoni di questa primavera, la seconda del Covid-19.
“I demoni fuggono gli incontri”, scrisse Efrem il Siro; eppure, tendono a frapporsi non solo tra noi e noi stessi ma anche tra noi e gli altri, infestando (è proprio la parola esatta!) le nostre più strette e vitali relazioni risuonando della nostra voce. Guido Zanderigo, l’amico fraterno a cui devo la mia embrionale e limitatissima conoscenza della cultura indiana che per lui, invece, è vita vissuta, mi ha spiegato che l’unica difesa contro i demoni e le loro voci consiste nel rito, e che il cuore del rito è il mantra, cioè l’accordo della voce con la vibrazione cosmica e primordiale; mi è parso di capire dalle nostre conversazioni che esso non sia una vibrazione contraria a quella delle voci dei demoni, ma che le accolga riportandole all’essenziale, al primigenio, fondendole anch’esse nell’armonia dell’Uno. Anche da qui, mi sembra di ricavare un’indicazione preziosa per me stesso e per questi giorni, ma dubito che se ne possa parlare senza immagini – metafore o suggestioni, analogie o intuizioni.
Non è bene disprezzare o condannare queste tempeste emotive, per quanto distruttive siano: hanno radici profonde e vengono dalle cavità sotterranee non solo delle nostre vite ma della stessa condizione umana; portano in sé qualcosa di ancestrale che merita ascolto, perché la nostra vita e sospesa tra l’alto e il basso, e i terremoti che sorgono dalle viscere della terra la terrorizzano quanto i fulmini che scendono improvvisi dal cielo.
Niente giudizi morali, dunque: piuttosto, un lavoro paziente sulle voci – le nostre: quelle in cui echeggiano i demoni di questa primavera. Un lavoro di comprensione, innanzitutto: in gioco c’è moltissimo, e la lava fumante che scende impetuosa lungo le pendici dei monti fino a devastare la fertilità della pianura può raccontaci molto di ciò che siamo. Un lavoro di trasformazione: prendiamo queste voci che ci sorgono da dentro, cerchiamo di modularle su un’armonia che ci sovrasti senza negare la nostra natura, che ci accolga senza annullarci ma trasformandoci. Facciamolo insieme, prima che sia troppo tardi: il diluvio si è ritirato, la terra ha racchiuso dentro di sé gli dei che donavano l’armonia precedente, ma il suolo non è ancora asciutto né abitabile; quegli dei sereni sono confusi, smarriti, feriti, sconvolti, e noi con loro. Le loro voci di lamento, sospetto, rancore, ira, rancoroso sconforto o addirittura rabbiosa disperazione sono un grido di soccorso: ascoltiamole così, aiutiamole a trasformarsi assieme a noi a misura di un’armonia che dobbiamo cercare e ritrovare, nuova e nuovamente manifestata, sorprendente e ancora sconosciuta. Stringiamoci, vibriamo assieme cercando un suono che ci rinnovi, un mantra che restauri il bene. Permettiamo ai demoni di trovare pace. Il sussurro diventi canto; il dolore si trasformi nel basso continuo che sostiene la tessitura dei soprani.
UN ANNO CON PINOCCHIO
Bugie, inganno, violenza
di Gianni Gasparini

La tesi o l’idea di fondo di questa nona puntata del nostro viaggio atipico attraverso le pagine delle Avventure di Pinocchio è molto semplice. Pinocchio, considerato ovunque il bugiardo per eccellenza, in realtà non è un mentitore ma piuttosto la vittima degli inganni e della violenza altrui (1).
Lo stereotipo di Pinocchio bugiardo ha avuto nel mondo una diffusione tanto ampia quanto ingiustificata: si tratta di un luogo comune che probabilmente ha goduto della vastissima diffusione delle Avventure di Pinocchio e di alcune immagini plastiche che Collodi attribuisce alle poche bugie del burattino, in particolare quella del naso che si allunga in modo spropositato.
Nel mondo americano lo stereotipo sembra aver avuto particolare fortuna: recentemente, a proposito di Donald Trump e delle sue bugie, è stato coniato negli Usa, come riporta G. Carofiglio, il Bottomless Pinocchio o Pinocchio senza fine, “una sorta di riconoscimento per chi abbia ripetuto almeno venti volte la stessa affermazione falsa”(2) . E una storica qualificata come Suzanne Stewart-Steinberg in un suo libro tradotto in italiano (3) non esita ad affermare apoditticamente che
Pinocchio è nato in un mondo di bugie, in cui egli è, come è noto, il più grande bugiardo; superato, forse, soltanto da Collodi stesso (4).
In realtà, che Pinocchio sia “il più grande bugiardo” (di tutta la letteratura, s’intende) è noto soltanto a chi non abbia letto con attenzione Collodi o a chi – accettando le facili scorciatoie dello stereotipo – voglia sorvolare di fronte ad alcuni elementi scomodi del testo.
Ne cito uno, a mio parere decisivo ma incomprensibile se si adotta il cliché del bugiardo e non si riconosce il carattere di fondo di Pinocchio, quello del poeta che corre e vede il mondo con occhi più acuti degli altri. Ad un certo punto il burattino dice a Geppetto “Io dico sempre la verità” (Cap. VIII). La maggior parte dei commentatori trascura o minimizza questa affermazione, che credo invece vada presa alla lettera nel suo significato profondo. In altri termini, Pinocchio è il personaggio archetipico che dice la verità sulla vita, sulle vicende umane, sulla lotta tra le grandi forze del male e del bene. Pinocchio dice la verità quando fa prevalere la poesia nello scorrere dei giorni, quando afferma – nonostante le proprie debolezze e infedeltà – la preminenza della dimensione affettiva e del dono/perdono su quella della violenza e dell’utilitarismo spicciolo, come vedremo in una prossima puntata.
In ogni caso, se vogliamo limitarci ad analizzare puntualmente il testo di Collodi relativamente alle bugie di Pinocchio, troviamo che egli mente pochissimo e che le sue bugie sono veniali, senza conseguenze, tanto più che lo stigma del naso segnala immediatamente agli interlocutori il goffo tentativo del burattino di costruire un universo fittizio, che viene in tal modo immediatamente smascherato. L’allungarsi del naso, che Pinocchio sperimenta la prima volta quando si trova sul letto della Fata ed è scampato al pericolo dell’impiccagione e poi a quello della malattia mortale da cui l’ha salvato la medicina presa in extremis (Cap. XVII), è un’esperienza sgradevole e imbarazzante, legata alla discrasia tra la parola e il corpo, un po’ come quando si arrossisce involontariamente di fronte ad altri. Analoga esperienza di allungamento del naso, già di per sé imponente, il burattino vive quando, dopo la battaglia dei libri tra i ragazzi che avevano marinato la scuola e dopo essere sfuggito al Pescatore verde che voleva friggerlo in padella, incontra un vecchietto che gli darà un sacchetto per vestirsi (Cap. XXIX). Si tratta di bugie innocue che hanno carattere di autoprotezione, a salvaguardia del proprio onore o di certi progetti.
L’unica volta in cui sembra che Pinocchio ricorra a una menzogna è quando, per uscire dalla prigione nel paese di Acchiappacitrulli in cui era stato assurdamente rinchiuso dopo esser stato derubato, afferma di essere anch’egli un malandrino, per poter usufruire della libertà concessa a tutti quelli che stavano in carcere. In effetti qui il burattino compie un semplice adeguamento alla situazione irreale e parodistica di un mondo alla rovescia in cui si è venuto a trovare e alla quale non vuole opporre resistenza. Questo gli permette infatti di recuperare lo status di persona libera di cui godeva in precedenza, prima della brutta avventura passata nel Campo dei miracoli, dove era stato derubato degli zecchini d’oro donatigli da Mangiafoco.
In effetti, Pinocchio è la vittima delle bugie e degli inganni altrui, anzitutto dei due figuri rappresentati dalla Volpe e dal Gatto, che non solo sono artefici di menzogne e raggiri volti a sottrargli le sue preziose monete ma si spingono ad azioni di rapina e di (tentato) omicidio, quando lo impiccano all’albero della Quercia grande dove verrà salvato in extremis per intervento della Fata. Ci si potrebbe domandare, qui e altrove nel racconto, se Pinocchio non sia per caso troppo fiducioso, ovvero ingenuo e credulone al limite della stoltezza: il burattino sembra non accorgersi dei segnali che lo dovrebbero indurre a diffidare di certi personaggi, perché la sua fiducia negli altri è incrollabile. Per questo egli crede anche alle cose più improbabili e assurde come l’albero degli zecchini d’oro, che secondo le assicurazioni della Volpe e del Gatto avrebbero dovuto dargli in brevissimo tempo e senza fatica frutti in denaro sonante.
Accanto alla Volpe e al Gatto, che svolgono il ruolo di malfattori in qualche modo occasionali, vi è poi la figura inquietante dell’Omino di burro, espressione della menzogna che fa presa non solo su Pinocchio, ma su Lucignolo e su una moltitudine di ragazzi che vengono adescati affinché perdano le caratteristiche umane per assumere quelle animali dell’asino. Qui la disumanizzazione porta diritta alla mercificazione, dal momento che gli animali vengono venduti ai più diversi acquirenti e il ricavato va ad arricchire l’Omino malefico, il quale presenta qualche sinistra rassomiglianza con gli odierni trafficanti di esseri umani e di organi.
In generale, poi, la violenza e la minaccia di violenza, fino alle conseguenze estreme, sono ben presenti in Pinocchio, che è in pericolo di vita più volte a motivo della malvagità altrui. Come nell’incontro col burattinaio Mangiafuoco, che minaccia di gettare sul fuoco prima lui e poi Arlecchino, allo scopo di meglio arrostire il montone che si stava preparando come pranzo, o come in quello col Pescatore verde, che non fa nessuna differenza tra Pinocchio come cibo per la propria fame e gli altri pesci impigliati nella rete.
Tra altri episodi che mettono in luce la crudeltà dei personaggi c’è poi quella del contadino che, preso Pinocchio alla tagliola, lo tiene legato alla catena e lo riduce a cane da guardia fino a quando egli nella notte non avviserà dell’arrivo delle faine, ladre di galline (Cap. XXI). E l’ortolano di nome Giangio è il contadino senza scrupoli che fa morire di sfinimento l’asino poi riconosciuto da Pinocchio come Lucignolo, e sfrutta il burattino a girare il bindolo tutto il giorno per una paga irrisoria, vale a dire un bicchiere di latte per Geppetto vecchio e malato. La violenza e i pericoli di morte erano del resto ben presenti a Carlo Lorenzini o Collodi, che aveva partecipato in prima linea, come mazziniano convinto, alle guerre risorgimentali di indipendenza del 1948 e del 1959.
Bisogna riconoscere che anche Pinocchio è autore di un gesto di violenza, quando all’inizio del racconto, rimproverato dal Grillo parlante – che rappresenta la sua coscienza o forse un avatar della Fata che apparirà più tardi – gli scaglia addosso un martello che stecchisce la bestia sul muro (Cap. IV). In questo caso, tuttavia, il gesto del burattino mi sembra una esplosione estemporanea di intolleranza e ribellismo che si risolve in un tentato grillicidio preterintenzionale. Le conseguenze del gesto di stizza vanno cioè al di là delle intenzioni di Pinocchio. E poi esse non sono irrimediabili, dal momento che il Grillo, dotato di una natura magica che lo rende impermeabile agli accidenti del tempo, riappare nel capitolo finale (XXXVI), quando affida la propria capanna a Pinocchio e a Geppetto, scampati dal terribile mostro marino e approdati alla spiaggia con l’aiuto del servizievole Tonno.
Non si può dimenticare infine che su questo sfondo di violenze, crudezza e spietatezza, gli episodi che evocano specificamente la giustizia – in parte già ricordati - ne trattano in termini parodistici o derisori, offrendoci un evidente elemento di valutazione negativa al riguardo da parte di Collodi.
-----------------------------------
- Riprendo qui in parte considerazioni svolte in Il caso Pinokkio: tra menzogna, violenza e perdono, in G. Forti, C. Mazzucato, A. Visconti, cur., Giustizia e letteratura II, Vita e Pensiero, Milano 2014
- Gianfranco Carofiglio, Della gentilezza e del coraggio, Feltrinelli, Milano 2020, p. 26
- Suzanne Stewart-Steinberg, L’effetto Pinocchio, Elliot, Roma 2011
- Ivi, p. 60, corsivo mio
IN MEMORIA
Giancarlo Cerini, una vita per la scuola

Cordoglio e commozione per la scomparsa di Giancarlo Cerini, avvenuta il 20 aprile scorso. Con lui se ne va una delle figure di maggior prestigio nel mondo della scuola, cui ha dedicato la sua esistenza lasciando in eredità un patrimonio prezioso di esperienze, idee e progetti.
"Una persona esemplare, che ha sempre unito alle doti di intelligenza e competenza anche quelle di una grande affabilità. Brillante, puntuale, lungimirante: ci mancherà tantissimo, soprattutto in un momento nel quale guardando all'uscita dalle pandemia si gettano le basi per un profondo rinnovamento del sistema scolastico". Così Maddalena Gissi, che ricorda anche la sua partecipazione a importanti iniziative promosse dalla CISL Scuola, come il convegno del 2016 sul sistema zero-sei, tema che negli ultimi tempi era stato al centro della sua attenzione e del suo impegno.
"Ci stringiamo ai suoi famigliari - ha affermato la segretaria generale CISL Scuola - con affetto e solidarietà, grati per ciò che Giancarlo ha dato a noi e al mondo della scuola".
----------------------------------------------------------------------
Rendiamo omaggio alla memoria di Giancarlo Cerini riproponendo la registrazione del suo intervento al Convegno Nazionale "Accogliere, educare, istruire. Quali tappe nel percorso da 0 a 6 anni", svoltosi a Bologna il 22 ottobre 2016 per iniziativa della CISL Scuola e di IRSEF IRFED.

