
In questa pagina:
Pensieri a voce alta: Convenienze e convinzioni (Maddalena Gissi)
La parola di questo mese: Alchimia (Lorenzo Gobbi)
La scuola è viva. W la scuola: Alla lavagna (Carlo Marconi)
La poesia dei luoghi: Abitare poeticamente i luoghi del mondo (Gianni Gasparini)
Storia contemporanea: 1981-1991. Da Cancun alla fine della Guerra fredda (Paolo Acanfora)
Il canto delle donne afghane: Viaggio nel paese delle ‘spose dell’oppio’ (Leonarda Tola)
Autobiografie scolastiche: Luigi Meneghello (Mario Bertin)
Zibaldone minimo: Ordine (Gianni Gasparini)
Scrivici, se vuoi, a redazione@cislscuola.it
Auguri di buon Natale e felice anno nuovo!
PENSIERI A VOCE ALTA
Convenienze e convinzioni
di Maddalena Gissi

Ma chi ve lo fa fare? Vi conviene? Si possono riassumere più o meno così tante delle domande che mi sono state rivolte, nei giorni scorsi, da chi si interrogava sulle ragioni della mancata presenza della CISL Scuola tra le sigle promotrici di un’azione di sciopero per la quale, mi si fa notare, non mancano certo le ragioni di disagio, di insoddisfazione e di delusione su cui far leva. E su questo, rispondo subito, non ho alcuna obiezione da porre. Abbiamo denunciato immediatamente, senza tentennamenti e senza ritardi, ciò che non va in un disegno di legge finanziaria le cui insufficienze e lacune abbiamo elencato puntualmente; evidenziandone prima ancora, in termini generali, la lontananza e l’incoerenza con tanti degli impegni assunti e sottoscritti in un Patto per la Scuola che continua a essere da tempo disatteso. Lo abbiamo fatto con prese di posizione molto chiare, che hanno visto al nostro fianco la confederazione al suo massimo livello, per sottolineare come la centralità della scuola sia un tema di interesse generale, in cui si inseriscono e trovano ancor più piena legittimazione le attese della nostra categoria. Il 16 novembre scorso, nell’incontro di CGIL, CISL e UIL con Draghi, Luigi Sbarra le ha richiamate esplicitamente, le ragioni della scuola; anche se l’incontro verteva soprattutto su previdenza e fisco, e voglio pensare che sia per questa ragione se altri accenni, oltre al suo, non se ne sono registrati. Dopo quell’incontro, è proseguita con iniziative in diverse città italiane la mobilitazione unitaria delle Confederazioni, nella quale la CISL Scuola si sente pienamente e attivamente coinvolta, assicurando ovunque il massimo sostegno e la sua presenza nelle manifestazioni.
Lo stesso obiettivo che le confederazioni si sono date, ossia costruire attraverso il confronto le condizioni per le necessarie modifiche al testo di legge di cui è in corso l’esame alle Camere, noi ce lo siamo dati per quanto concerne le questioni che in modo più diretto e specifico riguardano il mondo della scuola. Da qui la richiesta di incontro urgente rivolta al Ministro Bianchi nel momento in cui, dopo una fase di verifiche e “limature”, il disegno di legge veniva trasmesso formalmente al Senato. Incontro nel quale richiamare anche il Ministro a farsi parte attiva per dare sostegno alle azioni emendative da noi indicate come necessarie. Scrivo e sottolineo “anche”, perché nello stesso tempo erano già stati avviati, come sempre accade quando in ballo ci sono provvedimenti di natura legislativa e non contrattuale, numerosi contatti con esponenti politici e parlamentari, puntando a costruire il più ampio consenso possibile su ipotesi di emendamento per le quali, ed è un aspetto di cui non può essere ignorata la rilevanza, esistono procedure e tempi da rispettare, se davvero si vogliono raggiungere concretamente gli obiettivi cui si punta.
In un contesto del genere, concentrare attenzione ed energie sull’espressione della protesta, anziché focalizzarle sul conseguimento dei risultati concretamente possibili, ci è parsa una scelta sbagliata e in definitiva perdente, direi quasi di implicita rassegnazione a non vedere accolte le proprie richieste, alcune delle quali appaiono, nel contesto dato, del tutto irrealistiche. Così come si spinge ai limiti dell’autolesionismo la decisione di disertare, avendo proclamato uno sciopero, le relazioni sindacali; che porterebbe in sostanza, se praticata da tutti, a lasciare mano libera all’amministrazione di fare, o di non fare, ciò che crede, rispetto a questioni che hanno impatto diretto sulle condizioni di lavoro del nostro personale. Si pensi alla mobilità, per la quale va rinnovato il contratto integrativo e su cui si giocano partite decisive per le attese di decine di migliaia di persone. O all’impatto delle nuove disposizioni di contrasto alla pandemia, sulla cui gestione occorre essere quanto mai vigili e presenti.
Ecco che cosa ce lo ha fatto fare: non un valutazione delle nostre convenienze, ma la convinzione che sia doveroso, ancor più in momenti come quello che il Paese purtroppo continua a vivere, mettere al primo posto la soluzione dei problemi e non la ricerca di un’immediata visibilità, nell’illusione che basti, per renderla più appariscente, cavalcare il disagio anziché tentare di porvi rimedio. Lo abbiamo fatto assumendoci fino in fondo, com’è nostra antica abitudine, la responsabilità di scelte non sempre comode, ma molto spesso vincenti. Seguendo, in definitiva, la strada che le stesse confederazioni hanno tracciato nel confronto difficile e teso sulla finanziaria, valutando anch’esse positivamente quei “tavoli” inopinatamente disdegnati in alcune dichiarazioni di chi ha ritenuto che in questo momento, per chi rappresenta la scuola, fosse più opportuno agitarsi anziché confrontarsi.
Ho sempre considerato un grande valore quello dell’unità d’azione fra i sindacati. In un contesto di pluralismo articolato e vivace come quello che caratterizza il sindacalismo scolastico, l’unità si è sempre costruita fondandola su una grande capacità di ascolto reciproco e sull’esclusione di ogni pretesa di primato o egemonia. Si potrebbe stilare un lungo elenco di vicende nelle quali l’unità, almeno quella delle sigle più rappresentative, ha faticato a realizzarsi o non si è proprio realizzata. È una consapevolezza che mi fa vivere con serenità un momento non piacevole, ma non di rottura irreparabile. Né ci sentiamo isolati, in questa fase, nella quale è continuo e costante il dialogo con la categoria. Sono in pieno svolgimento i nostri congressi territoriali, preceduti da centinaia di assemblee con i nostri associati, e si sono appena concluse assemblee interregionali, gestite con un una modalità on line che ha fatto registrare un livello di partecipazione addirittura superiore alle attese. L’intera segreteria nazionale ha avuto modo di dialogare con lavoratrici e lavoratori che ne hanno constatato, fra l’altro, la grande conoscenza delle problematiche e la competenza nell’affrontarle con puntualità ed efficacia. Concretezza e visione si sono mostrati ancora una volta come connotati inscindibili del nostro modo di essere e fare sindacato.
Sono convinta che saranno altri eventi, passate le poche settimane entro cui si chiuderà la vicenda della finanziaria, a richiamare tutti alla necessità di far fronte comune per reggere le fatiche della partita, lunga e difficile, che continueremo a giocare per dare più giusto riconoscimento, più dignità e più valore al lavoro nella scuola. Una partita, scrivevo un mese fa, che la nostra categoria non potrà vincere giocando da sola, ma per la quale è indispensabile costruire un contesto di più ampia alleanza a livello politico e sociale. Un contesto nel quale anche eventuali azioni di sciopero, mirate a obiettivi precisi (penso al rinnovo del contratto) e non di pura protesta, potranno avere senso e risultare davvero utili ed efficaci.
LA PAROLA DI QUESTO MESE
Alchimia
di Lorenzo Gobbi
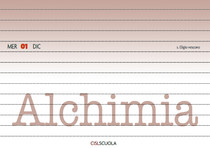
Un dialogo
Ciao, Giulia! Cosa leggi di bello?
Mi scaldo il cuore, Federica, con queste parole che mi cullano: L’opera al nero della Yourcenar. Non è che bisogna insegnare lettere per leggere un romanzo, anche noi matematiche lo facciamo… Così, aspetto di tornare in classe e sto qui a godermi il freddo umido della pianura Padana con qualche sprazzo di felicità.
Sì, per una siciliana come te stare qui con le finestre aperte causa Covid a fine novembre dev’essere un’esperienza quasi mistica. Sei vestita come un esquimese, mi sembra: giaccone da sci, guanti di lana, sciarpa e cappuccio alzato… I termosifoni lasciano molto a desiderare, in effetti, e con i soffitti alti che abbiamo un po’ di calore è solo un desiderio: è sempre stato così anche nell’era pre-Covid. Quanti gradi abbiamo, oggi, qui dentro? 15, 16?
Forse meno… mi porterò un plaid come le nostre alunne, che se lo tengono fin sulla testa ma poi stanno con il pancino di fuori, le spalle scoperte e i pantaloni strappati; del resto, tenere aperto bisogna e non si discute, io tengo aperto e amen. A volte mi sento un po’ come Zenone, l’alchimista del romanzo: sempre in fuga, sempre inseguita. Cosa faccio di male?, mi chiedo; perché ce l’hanno con me? Faccio l’insegnante, è così grave? Da una città all’altra, come Zenone; con pochi bagagli e pochissimi mezzi, come lui…
A volte anch’io mi sento un po’ come un alchimista: faccio cose strane, dove nessuno può vedermi; cerco di cambiare una materia che ha già una sua forma e di portarla a rivelare qualcosa di nobile che racchiude in sé; provo e riprovo, invento stratagemmi, tento e fallisco ma riprovo ancora. Ci credo sempre, sai? Trentacinque anni di servizio mi hanno fatto un po’ imbiancare, ma per fortuna esistono i parrucchieri.
Però, è vero: siamo un po’ come alchimisti, è una bella immagine. Cerchiamo qualcosa che si nasconde, ma siamo certi che c’è; non è che ci riusciamo sempre, ma ogni mattina siamo qua a cominciare daccapo. Anche l’opera alchemica non finiva mai, iniziava sempre daccapo. Sono andata a documentarmi un po’ sugli alchimisti e ho scoperto cose interessanti.
Raccontami.
Non era l’oro che gli alchimisti volevano produrre e non era chimica quella che praticavano: cercavano l’oro “non volgare”, la “quintessenza” o qualcosa del genere. La materia su cui lavoravano - il piombo, il mercurio, lo stagno, l’argento o la pietra - era l’occasione di un percorso tutto interiore ma portato avanti con pazienza, con le mani e con la mente: erano convinti che la materia fosse viva e pronta ad essere trasformata perché si liberasse in lei qualcosa di divino. Scusa, sono un po’ imprecisa, ma è così che mi sembra di aver capito.
Non credo che fossero molto apprezzati, però.
No, non lo erano: chi prendeva alla lettera ciò che facevano - e prendere tutto alla lettera è il miglior modo per non capire nulla - credeva che fossero dei chimici avidi, affamati di ricchezza, oppure che fossero dei ciarlatani, o anche degli stregoni velleitari, temibili ma inutili, ridicoli o addirittura pericolosi.
Beh, succede anche a noi: chi ci guarda da fuori spesso pensa che buona parte del nostro lavoro sia inutile e che dei giovani debbano imparare solo ciò che serve nella vita pratica, senza perdere tempo in sciocchezze come quelle che gli vogliamo insegnare qui, nelle nostre aule scomode e inospitali come l’antro di un alchimista.
Già: se qualcosa non “serve” nell’immediato, a produrre qualcosa di concreto e misurabile all’istante, c’è chi pensa che non serva a nulla.
E poi, vedi, sono pochi a capire che una trasformazione richiede pazienza, tempi lunghi e concentrazione interiore: è una ricchezza che non si può misurare, e che nessuna “ricetta” può garantire.
Gli alchimisti sapevano che tutto esiste per essere trasformato, ma nel senso che ovunque c’era una scintilla divina, un valore, qualcosa di prezioso che attendeva di essere liberato e moltiplicato; e anche che il primo passo è “l’opera al nero”, cioè la dissoluzione, lo scioglimento, la trasformazione attraverso la scomposizione difficile e sofferta.
Insomma, le certezze vanno messe in crisi, ciò che è noto va messo in discussione e ricondotto ai suoi nuclei essenziali, è così?
Ma non per il gusto di farlo: l’opera alchemica prosegue verso la fase del bianco e poi del rosso, cioè verso la ricomposizione e la trasformazione, la trasfigurazione in cui tutto diventa ciò che avrebbe sempre potuto essere ma che non avrebbe mai potuto diventare senza la pazienza dell’alchimista, senza la sua sapienza, senza il fuoco del suo antro e senza il passaggio nelle strettoie degli alambicchi.
Anche qui, c’è qualcosa che ci riguarda, mi sembra: le ricchezze dell’anima devono incontrarsi in modo nuovo e la stessa cosa possono fare l’anima e il mondo - perché insegniamo la letteratura, la matematica e la filosofia, se non per questo? E la storia dell’arte? Non è che le materie pratiche”, poi, siano solo “utili”: tutte sono un mezzo perché l’anima giovane incontri uno spicchio di mondo, perché sollevi lo sguardo e lo diriga verso un orizzonte ampio, ma ciò non può accadere senza uno sforzo, una pazienza e una dedizione a volte dolorose.
E nemmeno senza una sapienza: era questo che non veniva riconosciuto agli alchimisti, e proprio per questo venivano disprezzati e persino derisi, nel migliore dei casi; nel peggiore, c’erano la prigione, la tortura e il rogo.
Beh, non possiamo lamentarci, allora: almeno, al rogo non ci mettono, anzi: ci fanno gelare nel freddo dell’inverno. Ma quand’è che li alzeranno, questi termosifoni? Sono già freddi e siamo solo a metà mattina.
No, però… insegno solo da cinque anni, e mi sono sorpresa quando ho cominciato a capire quello che faccio ogni giorno; e anche quando ho cominciato a sentirmi sola, non riconosciuta per quello che sono, stretta tra schede di valutazione, competenze, verifiche, obiettivi, programmazioni e via dicendo - per carità, possono essere ottimi strumenti di lavoro, ma c’è dell’altro che sfugge a tutto questo e che lo supera di molto. Non sono una “facilitatrice”, sono una docente; non credo che ciò che faccio in aula ogni mattina si possa misurare con il bilancino, né regolamentare nei minimi particolari come mi sembra che si tenda a fare ogni giorno di più; non posso garantire risultati immediati, perché quello che cerco non è l’oro “volgare”, ma qualcos’altro che neanche io saprei definire. Credevo di sapere tutto della scuola perché ero stata una studentessa e invece, quando ho iniziato…
Chissà, forse è un’immagine che ci può aiutare, questa dell’alchimista: se non altro, a pensare al nostro lavoro come a un impegno che richiede sapienza e pazienza, dedizione, costanza, e anche una discreta dose di sofferenza; e a ritrovarci ancora vivi, ancora capaci di speranza in un quotidiano che spesso ci schiaccia.
Che ci appiattisce, direi: che ci distoglie dal centro del nostro esistere. Eppure, c’è ancora chi pensa che siamo dei privilegiati. Di’ pure dei parassiti, se vuoi: è questo che mi offende, perché qualche volta mi sembra di leggerlo negli occhi di qualche genitore.
Lascialo a noi “vecchie”, il pessimismo leopardiano! Sei troppo giovane per questo, aspetta ancora un po’. Però, è vero: c’è qualche genitore che dice chiaramente che suo figlio non ha tempo da perdere a studiare quello che gli propongo io, e che comunque non gli servirà a nulla… viva la sincerità!
È l’opera al nero: la dissoluzione dolorosa a cui anche l’alchimista deve sottoporsi perché ciò che si frantuma nel suo laboratorio possa ricomporsi in modo nuovo e arricchirsi di elementi preziosi, che gli altri lo capiscano oppure no. E non c’è altra via: non si può rifiutarsi di offrirsi in prima persona a una consumazione lenta, se si è veri alchimisti e ci si crede davvero.
Ecco, anche questo mi torna: in più di tre decenni, mi sembra di essermi consumata come una candela, a poco a poco, senza risparmiarmi, e di essermi ormai ridotta a ben poco. Tu sei qui a più di mille chilometri da tuo marito, non puoi chiedere trasferimento perché sei appena entrata in ruolo e ti fai in quattro comunque per fare bene il tuo lavoro; io andrò in pensione con qualche anno di ritardo, perché più di vent’anni di precariato con contratti a termine ed estati senza stipendio hanno lasciato il segno nella tabella dei contributi e così prima dei 67 non se ne parla nemmeno, di lasciarmi andare in pensione - e nessuno, neanche gli amici più intimi, crede davvero che tu abbia fatto tutto ciò che potevi fare, concorsi e corsi di specializzazione, abilitazioni multiple e decenni di supplenze dall’altra parte della provincia, tutto come ti è stato chiesto e al tempo esatto in cui ti hanno permesso di farlo: c’è sempre chi insinua che sei di certo stata tu a sbagliare qualcosa e che non la racconti giusta nelle tue lamentele, ma ci ho fatto l’abitudine.
Beh, anche i nostri tre mesi di vacanze e il nostro part-time superpagato sono leggende che è difficile sfatare.
Chissà se gli alchimisti si sentivano così: incompresi, consumati…
Può darsi, ma scendevano nel loro antro ogni notte a tentare di superare la fase dell’opera al nero: credevano nella possibilità della trasformazione, nel valore divino della materia, e ad esso si dedicavano.
Io credo nel valore umano, e non mi sono mai sorpresa a dubitarne.
Anch’io, Federica. Ma è ora di prendere la borsa e preparare gli alambicchi, perché la campana suonerà a momenti e io voglio essere davanti alla porta quando si apre, se no mi ritrovo mezza classe in bagno - la ricreazione è solo di 10 minuti, ma si può? E i bagni del secondo piano sono chiusi da almeno due mesi, così devono tutti scendere al piano di sotto e mettersi in coda; e poi, loro aspettano me e io aspetto loro, non è così che dev’essere?
Sì, Giulia: anche per me è così ogni giorno.
LA SCUOLA È VIVA. W LA SCUOLA
Alla lavagna
di Carlo Marconi

“Fede, segna i nomi alla lavagna!”
La bidella Mara ha bussato e ha fatto capolino dalla porta dell’aula. L’abbiamo vista piegare la testa di lato: ha spalancato gli occhi, ha arricciato le labbra e la fronte le si è riempita di rughe. La maestra Nanda ha capito subito e non ha esitato neppure un istante.
La maestra Nanda è un po’ Preside, un po’ idraulico, un po’ falegname: sa sempre cosa fare e sa fare di tutto.
Se nella scuola c’è un problema, entra il bidello Luigi oppure si affaccia la signora Rosa della Segreteria o arriva la maestra Carla di 2^B a darle un segnale e lei parte.
La maestra Nanda è anche vigile urbano.
Quando suona la campana dell’allarme, noi ci mettiamo in fila uno dietro l’altro e usciamo dall’aula in fretta e furia. Davanti a noi c’è la 5^B e dietro la 4^A. Nanda dirige il traffico e fa filare diritto anche i bambini e le maestre delle altre classi. Per fortuna la campana suona per finta. Cioè, suona per davvero, ma senza che sia successo niente di grave. La prima volta, quando eravamo piccoli, ci siamo spaventati: Sara ha gridato come se avesse visto un topo; Vito ha cominciato a correre sollevando in alto le ginocchia e pestando forte i piedi a terra senza spostarsi di un centimetro, proprio come se fossimo in palestra a fare gli esercizi; Ale, invece, è rimasta imbambolata, lì ferma al banco come se si fosse svegliata in quel momento.
Ormai, però, abbiamo capito come funzionano le cose. È tutto allenamento. Anzi, addestramento. Facciamo finta che ci sia un pericolo e usciamo “di corsa, ma senza correre”, come dice Nanda, così ci abituiamo ad affrontare le emergenze.
Il problema è che quella campana lì suona così forte da spaccare i timpani, e poi non ti aspetti mai che da un momento all’altro possa svegliarsi e cominciare a strillare come una gallina spennata.
Comunque, stavo dicendo, è entrata la bidella Mara, Nanda è dovuta uscire dall’aula e mi ha incaricato di scrivere alla lavagna i nomi dei bambini che disturbano.
Un po’ ci speravo, ma, a dir la verità, non me l’aspettavo troppo.
Tanto alla lavagna va sempre Marisa, la cocca della maestra. Che invidia. E che rabbia! Lei scrive i soliti 4 o 5 nomi, sempre, ogni volta. Fa il suo compitino e Nanda le dice “brava, brava, vai a posto!” e si vede che è soddisfatta del suo lavoro.
Ma ora tocca a me e finalmente posso decidere cosa fare.
E gli altri zitti, se non vogliono finire scritti e stampati sulla lavagna per poi vedersela con la Nanda!
Tutti mi guardano paralizzati.
Tommaso inizia ad agitarsi sulla sedia, mentre Eli se ne sta lì immobile con le braccia conserte appoggiate al banco. Se va avanti a non respirare in quel modo finirà per scoppiare.
Scrivere “Marisa” non se ne parla neppure. La Nanda sarebbe capace di dire “Marisa? Non ci credo!”.
Quasi quasi scrivo Luca, così impara a darsi tante arie da perfettino. Lui è quello che appena la maestra gira gli occhi ne fa di tutti i colori, ma poi non è mai colpevole.
Adesso Marisa, con quel suo modo di fare da “maestrona”, mi fa dei cenni col mento. Giro gli occhi verso la direzione che mi indica e vedo Nico che ha tutta l’aria di voler architettare qualcuna delle sue diavolerie. Scrivo Nico?
Alla fine scrivo Nico. Scrivere Nico significa andare sul sicuro. Tanto, che lo scriva o non lo scriva, le sgridate più severe se le prende sempre lui che sbaglia le operazioni, che si alza quando si deve stare seduti, che chiede le cose senza dire per favore, che si dondola sulla sedia.
Lo scrivo e poi lo cancello. In fondo mi sta simpatico. Perché deve prendersi un castigo anche stavolta?
Il tempo passa e la maestra non torna. Comincio a essere stufa di starmene in piedi a guardare tante belle statuine che continuano a fare smorfie e a indicarsi l’un l’altra. La lavagna è pulita, non sono stata capace di scrivere neanche un nome e so già che la Nanda avrà da ridire. Ma ora posso dirlo con certezza: questa storia di scrivere i nomi dei cattivi alla lavagna non mi piace per niente!
Perché la Nanda non fa come la maestra Giulia? Perché non ci mette a gruppi e non ci lascia lavorare insieme? Quella volta che Giulia è dovuta andare in bagno e ci ha lasciati da soli eravamo troppo impegnati a fare la ricerca di geografia per preoccuparci di chi parlava. Tanto parlavamo tutti. La Nanda invece dice che quando si lavora ci deve essere un silenzio perfetto, ma io non ho mai visto nessuno lavorare così. Se venisse nell’officina del papà sentirebbe il chiasso che c’è!
Ma ora un po’ di chiasso inizia ad esserci anche qui, in aula.
I compagni guardano la lavagna e fanno i loro commenti. Qualcuno ride, qualche altro non crede ai suoi occhi. Marisa ha la faccia rossa come il sugo al pomodoro di nonna Franca e strilla che farò i conti con la maestra. Ma ormai non ascolto più nessuno! Il brusio è diventata vera e propria confusione: non si distinguono più le risate dalle proteste.
Quando la maestra Nanda irrompe in aula ha già in bocca il nome di Nico che, effettivamente, si sta agitando come uno scimmione. Poi si volta verso la lavagna, resta un attimo a bocca aperta e urla: “Federica, sei impazzita? Cosa ti salta in testa?”. Vorrebbe aggiungere altro, forse minacciare un “compito di castigo” oppure una nota sul diario o, peggio ancora, un colloquio con i genitori, ma non riesce a dire più neanche una parola.
È arrabbiata, ma neanche troppo. Continua a fissare la lavagna e il suo sguardo sembra via via sempre meno minaccioso. In fondo ho fatto un bel lavoro: il suo ritratto le assomiglia proprio.
LA POESIA DEI LUOGHI
Abitare poeticamente i luoghi del mondo
di Gianni Gasparini

- Foto di Hans Braxmeier da Pixabay
Il grande poeta tedesco Friedrich Hölderlin (1770–1843) parlava, in pieno clima romantico ottocentesco, della prospettiva di “abitare poeticamente il mondo”. Prospettiva certo non facile, né ieri né oggi, perché implica il saper cogliere la capacità di trasfigurazione che offre potenzialmente la poesia a chi praticandola cerchi di farla entrare nelle articolazioni del sociale e della vita quotidiana. L’indicazione di Hölderlin è svincolata dal tempo e dalla società in cui si vive. Volendo applicarla alle società ipermoderne del XXI secolo, credo che dovremmo soprattutto vigilare sulle derive disumanizzanti che sono connesse alla modernità contemporanea. Potremmo così immaginare esercizi di “abitazione poetica” come quelli che valorizzano il silenzio, la capacità di contemplazione, gli aspetti gratuiti del vivere, la riscoperta del corpo attraverso il gesto antico del camminare, così come l’attenzione ad ogni elemento naturale che possa far capolino o emergere anche nelle realtà urbane. E non dovremmo trascurare, come suggerisce la filosofa e teologa Isabella Guanzini, di aprirci alle occasioni autentiche e liberanti di gioia che ci offre la vita quotidiana (Filosofia della gioia, Ponte alle Grazie 2021). Ma, contemporaneamente, dovremmo tener conto realisticamente dei fattori di complicazione e in controtendenza posti in essere dalla pandemia che da due anni ha investito il pianeta. Occorre riconoscere che il progetto di abitare poeticamente la vita è assai arduo quando si è costantemente preoccupati per la situazione sanitaria personale e collettiva, e si deve operare tra umani in termini di isolamento, distanziamento, uso di mascherine, divieti mai sperimentati e assidui controlli sanitari.
Torniamo a Hölderlin: è innegabile che, indicando “il mondo” come referente della capacità di investirlo poeticamente, la prospettiva del poeta tedesco implichi la presenza di luoghi. Una questione che sorge riguarda allora la maggiore o minore rispondenza di un luogo alla capacità di penetrazione poetica. In altri termini: ci sono luoghi più poetici in sé di altri? Vi sono località che si prestano più facilmente di altre ad essere investite, penetrate o abitate dalla poesia? La differenza tra città e ambiti eminentemente naturali può essere pertinente in proposito?
Facciamo un passo indietro e chiediamoci che cosa significhi aderire ad una visione poetica della realtà. Evitando un lungo excursus sulle radici e le manifestazioni della poesia, credo che in estrema sintesi si possa dire che un luogo è investito o pervaso dalla poesia quando chi ne parla lo proietta in una visione trasfigurata, dove esso assume significati nuovi rispetto alle sue sembianze reali.
È chiaro allora che sia la dimensione urbana di un luogo sia lo sfondo di un paesaggio naturale hanno chances equivalenti di fronte ad una interpretazione o trasfigurazione poetica, anche se di solito si è più portati ad associare la poesia ad ambienti naturali anziché alle articolazioni delle aree urbane. Un secolo fa Fernando Pessoa, il grande genio poetico portoghese, osservava che c’è poesia persino in un tram che arranca per le strade di Lisbona; e Federico García Lorca, l’altro genio iberico del Novecento, gli faceva eco scrivendo che ci può essere poesia persino in un cane che attraversa di sghimbescio una strada. Prima di loro Baudelaire ed altri avevano cercato di cogliere una dimensione poetica dell’industrializzazione ottocentesca, come quella legata all’orologio e alle macchine. La sensibilità nei confronti delle industrie e dei mezzi di trasporto meccanici come il treno viene espressa del resto dagli impressionisti e da altri pittori che hanno saputo trasmettere con le forme e i colori una visione nuova e certamente poetica dell’industria nella seconda metà dell’Ottocento in Europa. E vi sono, in ogni caso, città che sembrano prestarsi particolarmente ad una celebrazione poetica, in funzione di canoni estetici consolidati e condivisi da secoli. Verrebbe da citare qui anzitutto Venezia con piazza San Marco e tutto il resto, oppure Firenze con il suo centro inimitabile, o ancora Roma con i monumenti dell’Urbe. In realtà, questo elemento di poeticità non è scontato a priori: anche i luoghi più celebrati e considerati memorabili possono non essere “abitati poeticamente” se in chi ne fruisce prevalgono gli stereotipi, le semplificazioni e i gesti standardizzati ad uso turistico, invece di un genuino rapporto basato sulla trasfigurazione poetica. Può succedere, per contro, che anche spazi che non sembrano godere per i più di attributi di bellezza e attrattività acquistino una dimensione poetica agli occhi di chi li percorra in certe condizioni ambientali o stagionali o ne conosca dettagli significativi sconosciuti agli altri. Può accadere, ad esempio, di non essere colpiti da una visita al Duomo di Milano e invece di apprezzare creativamente gli alberi di un parco di un comune dell’hinterland ambrosiano. Insomma, la poeticità presunta di un luogo deve fare i conti con la sensibilità personale di chi si accosta ad esso.
Per finire sul rapporto tra luoghi e poesia, non si può dimenticare l’importanza dell’elemento rappresentato dal genius loci, quello “spirito del luogo” che secondo gli antichi era legato distintamente a singole località e che anche oggi, mutatis mutandis, possiamo considerare come qualcosa che contraddistingue singoli ambiti territoriali nella loro specificità. Il genius loci caratterizza sia realtà urbane significative che luoghi o ambiti naturali caratteristici: ad esempio Siena o Taormina, il Monte Bianco o Capri, e così via. Di fatto, esso parla quasi sempre di peculiarità di ciascuna località in termini di bellezza e di rarità. È molto probabile quindi che la scoperta o la messa a fuoco di un genius loci ci porti in prossimità di ambiti che si prestano ad essere abitati poeticamente.
STORIA CONTEMPORANEA
1981-1991: da Cancun alla fine della Guerra fredda
di Paolo Acanfora

Gli anni Settanta erano stati segnati da crisi sistemiche (la fine di Bretton Woods nel 1971, lo shock petrolifero nel 1973) ma anche da inedite fasi di sviluppo delle relazioni tra l’Occidente e il blocco sovietico (l’avvio della Ostpolitik nel 1970, la Conferenza di Helsinki del 1975). Il mondo andava ridefinendo i propri equilibri, con nuovi attori e nuovi paradigmi politico-economici. La necessità di rispondere agli scossoni monetari, finanziari, economici con gravi ricadute sociali e politiche – sino allo sviluppo, in alcuni paesi, di una drammatica stagione terroristica – aveva stimolato nuove soluzioni e nuove visioni della società.
Nel 1979 era stata eletta Margaret Thatcher alla guida del governo britannico. Un’elezione che innovava la scena inglese, europea e mondiale con radicalità. La Iron Lady dava avvio ad una infaticabile ed a tratti feroce battaglia contro le visioni comunitarie e contro gli assetti e gli equilibri interni alla Comunità europea, nonché per rivedere le relazioni con il Sud del mondo impegnato in una lunga e faticosa competizione per un New International Economic Order. I suoi slogan simboleggiarono efficacemente i mutamenti del nuovo corso. Sul piano nazionale operò per marginalizzare, come mai prima d’allora, la funzione dei sindacati, con una linea politica che è stata spesso sintetizzata con il motto “la società non esiste”. Negli organi comunitari avviò da subito una estenuante campagna all’insegna del “I want my money back”, finalizzata a rivedere il bilancio della Cee ed in esso il contributo britannico. Sul piano delle relazioni tra Nord e Sud del mondo trovò un partner straordinariamente affine nel nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, Ronald Reagan, eletto nel novembre del 1980. Il loro incontro nel summit tenutosi nell’ottobre del 1981 a Cancun in Messico contribuì a segnare la storia della Guerra fredda e degli anni a venire.
Nell’immaginario politico Cancun ha rappresentato la fine della (sempre faticosa) solidarietà tra Nord e Sud del mondo e qualsiasi possibilità di accoglimento delle richieste di revisione del sistema economico internazionale avanzato nel corso dei decenni dai paesi in via di sviluppo. La coppia Reagan/Thatcher ne era in qualche misura (a torto o a ragione) il simbolo. Le foto di gruppo dei grandi della Terra a Cancun una versione plastica. I nuovi paradigmi economici avevano trovato una chiara incarnazione politica. Riduzione delle aliquote fiscali, privatizzazioni, deregulation divennero le nuove parole d’ordine per una visione del mondo in cui lo Stato doveva ridurre notevolmente il proprio intervento nel settore economico e sociale ed in cui gli individui dovevano essere lasciati il più possibile liberi di operare in un mercato rinnovato e privo di vincoli. Veniva drasticamente rivisto il modello dello Stato sociale. Il cosiddetto Washington consensus divenne sul finire del decennio il nuovo paradigma con cui interpretare il modello di sviluppo dei paesi del Terzo mondo. Il neoliberismo e la globalizzazione divennero presto, nel gergo comune, due termini indissolubili.
Contestualmente, i rapporti strutturati negli anni Settanta tra Est ed Ovest avevano prodotto una progressiva dipendenza dell’Europa orientale dalle importazioni e dagli istituti di credito occidentali. Il dinamismo dell’Occidente aveva messo sempre più in evidenza le strutturali difficoltà del sistema sovietico, rimasto sostanzialmente ingessato e legato ad una visione rigida anche dei rapporti tra Urss e paesi satelliti. Tentativi di riforma furono dunque tentati con la nuova giovane leadership di Mikhail Gorbachev, alla guida dell’Unione Sovietica a partire dal 1985. Un momento di svolta cruciale, che si era concretizzato con l’avvio di nuove politiche all’insegna delle parole d’ordine “Glasnost” e “Perestrojka” (trasparenza e riforma). Un orizzonte riformista che faceva nascere speranze di “umanizzazione” di un sistema rimasto saldamente ancorato ai principi di coercizione e repressione propri della dittatura di classe.
Anche l’approccio statunitense cambiava. Sin dall’inizio della sua presidenza Reagan aveva lanciato una vera e propria “guerra apocalittica” a quello che egli definiva l’Impero del male. Le rappresentazioni hollywoodiane degli anni Ottanta erano inequivocabilmente segnate da questa lettura politico-teologica. L’avvento di Gorbachev spinse lo stesso Reagan ad una revisione (almeno parziale) della sua politica. Certamente nessuno si sarebbe aspettato che nel giro di pochi anni, l’Urss avrebbe messo in discussione le proprie posizioni ideologiche (solo per citare un esempio: l’abolizione dell’ateismo di Stato), le relazioni con i propri paesi satelliti (il ritiro dei presidi militari), la politica estera (il ritiro delle truppe dall’Afganistan) sino all’abbattimento del muro di Berlino che rappresentava – come niente altro – il vero simbolo della Guerra fredda in Europa.
Dalle picconate del 9 novembre 1989 prese avvio un ciclo rivoluzionario che portò in pochissimo tempo alla fine dei sistemi comunisti in Europa orientale (con tempi e modalità molto diverse da paese a paese) e, in ultima istanza, alla implosione della stessa Unione Sovietica nel 1991. Finiva una stagione che si era aperta con la conclusione della seconda guerra mondiale e che sembrava dovesse essere una condizione immutabile del sistema internazionale. Una cesura fondamentale della nostra storia recente che ha portato a ridefinire le stesse fondamenta della nostra convivenza civile.
IL CANTO DELLE DONNE AFGHANE
Viaggio nel paese delle ‘spose dell’oppio’
di Leonarda Tola

“Una società non ha
nessuna possibilità
di progredire se le sue donne
sono ignoranti”
(Khaled Hossein)
L’Afghanistan non è più nei titoli gridati dei giornali, non è la prima notizia dei telegiornali e se ne parla sempre meno rispetto ai giorni del ritiro delle forze militari degli Stati Uniti il 31 agosto 2021.C’è da temere che la straziante immagine del bambino issato su un muro dalla mamma e lanciato al soldato che lo riceve in braccio possa essere dimenticata. Eppure dei 14 milioni di afghani che sono esposti alla fame oltre la metà sono bambine e bambini, migliaia premono alle frontiere della Bielorussia respinti dal filo spinato insanguinato al confine europeo della Polonia. Il paese è ripiombato sotto il dominio dei talebani addestrati nelle scuole coraniche al radicalismo religioso, feroci custodi della modestia e della virtù delle donne ricacciate dentro le case, escluse dall’istruzione, minacciate da un passato che rivive nella nuova segregazione. Si sa che in Afghanistan esiste un’organizzazione clandestina fondata e costituita da donne attive nella difesa dei diritti umani e nell’aiuto alle donne in difficoltà e in sofferenza: una resistenza coraggiosa che cerca di opporsi al maschilismo talebano che le donne conoscono meglio di chiunque altro. Per altro, il ventennio di occupazione dell’Occidente, militare o di pace, come è stata chiamata, ha contribuito all’evoluzione culturale del paese anche attraverso l’istruzione estesa alle donne.
Quale sia oggi il valore femminile del popolo afghano è rivelato anche dal talento letterario delle donne. Non mancano le autrici afghane che si accostano alla storia, alle tradizioni e all’attualità con l’intento di dare voce a un mondo altrimenti dimenticato; è il caso dell’affermata scrittrice Fariba Nawa afghana di Herat, nata nel 1973 in una famiglia costretta alla fuga e all’esilio in America nel 1982 per sottrarsi all’invasione sovietica e alla guerra. A nove anni Fariba va a vivere in California con i suoi, fa studi sociologici e diventa giornalista freelance; la passione della scrittura è la sua naturale risposta alla nostalgia e al desidero di tornare nella patria amata e perduta per poterla raccontare in un libro di successo: La moglie afghana (Ed. Newton Compton 2015).
Fariba Nawa ritorna dopo 18 anni in Afghanistan per comprendere e comunicare la realtà del suo paese che ha subito traumatici cambiamenti nel “passaggio da un’autocrazia religiosa a una democrazia frammentata e infine divenendo una terra tormentata da una guerra su ampia scala”. È lo scenario documentato che l’autrice descrive attingendo alla profonda conoscenza dei fenomeni sociali e delle condizioni culturali della sua gente. Il libro non è un romanzo, ma il racconto-saggio, avvincente come un romanzo, di un viaggio d’amore e di studio nei luoghi familiari, partecipato ed emozionante che si alimenta dello sguardo solidale sulla condizione e il destino delle donne. Un viaggio affrontato con il coraggio necessario a sfidare le diffidenze e gli ostacoli di un ambiente che vede con sospetto una afghana di ritorno che si muove da sola. Lo sfondo su cui si disegnano le diverse storie, tutte vere, è il traffico dell’oppio che è diventata l’economia sommersa del Paese: “Senza il commercio illegale dei narcotici l’Afghanistan collasserebbe”, scrive l’autrice. La coltivazione del papavero, introdotta dal conquistatore mongolo Gengis Khan (XIII secolo) fu per secoli destinata ad uso medicinale; a metà degli anni ottanta del Novecento l’Afghanistan divenne il primo produttore di oppio del mondo. Negli ultimi due decenni di invasioni straniere e di guerra i signori della droga locali diventano arbitri della sopravvivenza dei tanti uomini disoccupati, sporadicamente assoldati al trasporto dell’oppio a piedi o a dorso d’asino attraverso il deserto. 15 milioni i consumatori “in Afghanistan dove essere ricchi vuol dire avere da mangiare”.
Il libro di Fariba Fawa ha una protagonista: è Darya figlia dodicenne di un trafficante di droga e schiavo dell’oppio, che l’ha venduta in sposa, per saldare i debiti, a un uomo che ha 34 anni più di lei, una moglie e 8 figli. Darya cerca di ribellarsi decisa a resistere o morire, autoimmolandosi, nel tragico gesto del suicidio dandosi fuoco praticato dalle donne. Chiede aiuto alla giornalista che si fa coinvolgere nella disperazione della bambina “sposa dell’oppio”: “occhi neri, specchio del carattere delle donne ritratte nelle miniature persiane”. Una narrazione appassionante e utile due volte: dà conto della condizione femminile domestica e sociale, lacerata dalla violenza tribale e ottusa dei maschi; si fa rappresentazione, qui tragica e tinta di sangue, della fatica universale delle donne a vivere nella verità e nella libertà. Non è finito il racconto sull’Afghanistan finito in pezzi. Le scrittrici come Fariba Nawa aggiorneranno le loro storie all’anno 2021: per le ragazze di Kabul e di Herat, nel paese dei ciliegi e dei melograni, un salto indietro nel vuoto insensato e scandaloso della storia.
AUTOBIOGRAFIE SCOLASTICHE
Luigi Meneghello
di Mario Bertin
Libera nos a malo è il libro di uno straordinario esordio di Luigi Meneghello. Un libro che ha fatto epoca. In esso vi è descritta con simpatia, con affettuosa nostalgia e con una ironia spesso dissacrante la commedia umana di una provincia veneta nei primi decenni del Novecento. Il racconto si apre con l’epopea della formazione scolastica elementare dell’autore.
“Libera nos a malo” è l’ultima invocazione del Padre Nostro, detto in latino, come si usava a quei tempi. Ma Malo è anche il nome del paese nativo di Meneghello. Si trova in provincia di Vicenza, dalle parti di Schio. Quando il libro uscì, nel 1963, l’autore aveva compiuto da poco i quarant’anni. In Veneto erano gli anni del boom economico.
Nel libro è narrata l’esperienza di vita dell’autore in un mondo “dove si parla una lingua che non si scrive”. Ed è soprattutto il sorprendente uso del dialetto che imprime al linguaggio nativo una specie di cadenza cantabile e, allo stesso tempo, una disinibita rivitalizzazione della realtà. D’altronde, era proprio quella l’epoca in cui si assisteva ad una inconsueta presenza del dialetto nei romanzi. Ne avevano già fatto ricorso Fenoglio e Testori, Gadda, Mastronardi e Pasolini. Per Meneghello il dialetto però è stato la lingua, come ha fatto notare Cesare Segre. “Ogni parola del dialetto vibra di sensazioni e ricordi, è qualcosa che si lega alla natura, alla vita, ai sentimenti”. La parola si fa evento.
L'avventura della parola

Giornata in solaio dove c'è, in tre o quattro casse e sparsa per terra, la storia della nostra famiglia, specie di noi figli, un caos di quaderni, conti, lettere, libri scompaginati. Le rilegature dei libri di scuola e le copertine colorate dei quaderni tornano a galla, sorprendenti e familiari come visi dal mondo dei sogni. Ci sono le cartoline illustrate che la mamma mandava al papà quando erano morosi; i quadretti della prima comunione; le riviste degli anni venti che erano già antiche quando vi cercavamo le donne con le còttole sopra il ginocchio; diari, disegni, composizioni di ginnasio, di liceo, d'università; lettere di amici e di ragazze.
Nulla di tutto questo ha la forza di un quadernetto che una mano incerta ha intitolato di “Righe”, coi Pensierini interposti tra Problemi e Dettati, e il balbettio dialettale, l'ortografia paesana del bambino che fui quand'ero in “Seconda Classe”.
“La mia maestra si chiama Prospera Moretti. La mia scuola è posta in via Borgo ed è bella e spaziosa.”
Non me la sento di ritornare ora in questa bella e spaziosa scuola, una vecchia casa in mezzo al paese, dove oggi abita gente che non conosco. C'erano tre classi in una stessa aula, di sopra. Era una scuola “privata”, curioso residuo di un altro mondo; serviva alle famiglie più benestanti per mandare a scuola i bambini prima dei sei anni. Poi dopo la terza si faceva un esame – il primo della nostra vita – per entrare alle “Cumunali”.
“Io non ho mai preso a calci la mia maestra come Bruno Erminietto.”
L'antefatto mi è ignoto. Quando comincia il breve dramma la maestra Prospera ha già perso la pazienza; è a fianco della fila esterna dei banchi, ha afferrato Bruno Erminietto per un braccio e tira. Lui è aggrappato a un banco, la maestra grida rimproveri, piovono colpi confusi. Ora il colpevole è staccato dal banco, alla mercé dell'antagonista adulta.
Viluppo di sottane, strilli. Bruno Erminietto morsica e scalcia, tirando agli stinchi introvabili tra le sottane; ecco, ha trovato gli stinchi e sferra ora pedate efficaci, arcando il corpo.
Fu sopraffatto e trascinato via strisciando coi piedi sull'ammattonato.
Alla mattina ci si metteva in fila nel corridoio, aspettando di salire in classe. Faustino faceva l'estroverso, mostrava l'unghia del mignolo lasciata crescere ad arte, dava spettacolo. Cercai di fermarlo.
«Quell'unghia lì s'incarna se non la tagli,» dissi; «diventa un'Unghia Incarnata.»
«E che cos'è un'Unghia Incarnata?»
Glielo dissi: mi era stato spiegato accuratamente.
«È un'unghia che diventa lunga così, mezzo metro, anche più; e ricurva in cima.»
«Benissimo,» disse Faustino. «Così potrò graffiarti anche da lontano.»
C'erano prima seconda e terza incastrate a intaglio: la prima in strati paralleli come una costa di mare davanti alla maestra; le dune e le roccette della seconda sotto le finestre, si articolavano all'interno in una plica di banchi centrali; in fondo i contrafforti della terza. Ai piedi della lavagna c'era la, strisciolina sabbiosa della primetta, dove soggiornavano i piccoli non ancora maturi per la prima, gli “osservatori” che osservavano con aria spaventata.
Mio fratello Bruno, ammesso a questa spiaggetta sui quattro anni, osservò la prima lezione della maestra Prospera con inquietudine crescente. La maestra spiegava come s'impugna la Penna, protendendo Pollice Indice e Medio nell'aria, proprio davanti al naso di Bruno: l'Indice e il Medio devono essere paralleli, e sotto c'è il Pollice che quando poi s'introduce la Penna la spinge in su e la ferma. È il modo antico di impugnare la Penna, l'unico veramente adatto a fare le aste e i filetti come si deve. Credo che noi allievi della maestra Prospera siamo gli ultimi in paese che l'hanno imparato.
Le tre dita della maestra scendendo dall'alto, grosse, tese, forcute, parvero a Bruno una trappola spaventosa; capì che c'era in aria il progetto di far fare anche a lui la stessa cosa, col Pollice l'Indice e il Medio, ed ebbe la certezza che non ci sarebbe mai riuscito. Le tre dita in discesa gli parevano gigantesche, deformi, e sempre più vicine al suo naso. Si sentì in pericolo immediato e si mise a gridare: dovettero allontanare tutte le Penne, e dargli delle Mentine.
La maestra Prospera non era una donna, per noi, ma un fatto della natura, come il campanile, l'Arciprete, la piazza. Avvertivamo tuttavia, dalla foggia antica dei capelli, dalla pronuncia forse, che c'era in lei qualche cosa di arcaico. Era infatti una donna all'antica, che premiava con le mentine di zucchero colorato e puniva con piccoli colpi di bacchetta sulle nocche delle mani. Qualche volta ci metteva in ginocchio dietro la “tavola nera” sui chicchi di sorgo; spesso ci mandava in castigo, al pianterreno. Viveva ritirata, e quando si lasciava la sua scuola la si perdeva quasi completamente di vista.
Morì dopo la guerra, quando io ero ancora in paese, e la portammo a seppellire proprio noi alunni della mia generazione, io Mino Faustino e Guido. Eravamo disorientati e rattristati, e ci ripetevamo le frasi che scoprimmo di saper tutti a memoria.
“Questa mattina ho aperto le imposte e ho visto il sole. Poi mi sono lavato la faccia, le orecchie e il colo. Mi sono vestito e petinato. Dopo aver mangiato il caffelatte io sono andato a scuola. La mia scuola è posta in via Borgo ed è bella e spaziosa. La mia maestra si chiama Prospera Moretti.”
«Ma c'è un ma...» Certo che c'era, un ma, ma non a quello pensava la maestra Prospera quando concludeva il rapportino alle mamme o ai papà, sempre con la stessa frase. «Sarebbe proprio bravino, come dico... Ma c'è un ma.» Per lei era solo un rito: un'allusione al fatto che il bambino – ciascun bambino – era “vivo”. Il suo ma era impersonale, un attributo generico dell'infanzia; e i suoi accenni avevano un'aria civettuola di finta severità.
Invece c'era davvero, un ma, c'era da un pezzo: il ma dell'orto, il ma dell'asilo. Qui a scuola s'era incarnato principalmente in quel piccolo feticcio che la maestra stessa aveva proposto presentandocelo di chiamare La Bambolina, e poi nella bionda cugina di Mino, che lui aveva facoltà, e io no, di uscire dal banco a vezzeggiare quando la maestra era occupata altrove. C'era il ma; ma bisogna stare un po' attenti quando sentono gli adulti che queste cose o non le capiscono o fanno finta di non capirle.
“Nella mia scuola, che è posta in via Borgo, chi fa il cattivo viene messo in castigo al pianterreno nel cesso.”
Nascevano complicazioni perché a volte il castigato, fatto uscire urgentemente, s'impadroniva della chiave e chiudeva dentro il compagno o la compagna o l'assistente che si chiamava Elsa; o la stessa maestra Prospera. Questo cesso era anch'esso spazioso, una specie di sala a mattoni, con un finestrino senza imposta che dava su un cortiletto. Per me diventava una fonte di sogni tutte le volte che otteneva il permesso di andarci l'Antonia.
L'Antonia era una florida donna coi capelli rossi, in età di otto anni. Le mie mire su di lei si concentravano su immagini suggerite da una parola in uso fra le “grande” di terza, di cui l'Antonia era la più cospicua. La parola era cesto, ed era la franca, fiorita, donnesca metafora del sedere.
L'ammattonato del cesso, il finestrino, l'Antonia, facevano una dolce corona d'immagini, e in mezzo il cesto dell'Antonia luceva come un ostensorio. Lo sognavo vividamente, ma senza spasimo, anzi con un sentimento molto vicino al piacere disinteressato che attribuiscono alla contemplazione estetica. Il cesto pallido e molle dell'Antonia, che cosa volevo farne? Contemplarlo, forse dal finestrino, soppesarlo benché sembrasse fluttuare: giocare insomma.
Tutt'altra cosa furono i miei rapporti con la Giulietta. Era una bambina di passaggio, nipote di uno dei dottori, venuta a Malo per qualche mese, bruna, moderna, piccante. Era stata messa con quelli di seconda nel banco davanti al mio; e io, curvandomi e storcendomi dietro una matita lasciata cadere, cercai di andarle a vedere le gambe. Vidi una coscia e rimasi come fulminato. Era pallida sopra l'elastico che fermava la calza nera, aveva riflessi azzurri, carne scompiglia-visceri.
Andavo e tornavo da scuola con mia cugina Este che era una delle grande, non importante come la Pozzàn, ma poco meno. La Pozzàn si fermò davanti al caffè Nazionale, e le grande attorno. Ci mettemmo in cerchio sul marciapiede.
«Allora stiamo arrabbiate con la Mantiero,» disse la Pozzàn.
«Con la Mantiero,» dicevano le grande. «Arrabbiate con la Mantiero.» Poi andammo tutti a casa a mangiare. Siccome io solo tra le grande ero piccolo e maschio, non avevo niente da dire e niente di speciale da fare, soltanto stare arrabbiato con la Mantiero. Ci misi il massimo impegno, benché nessuno mi controllasse.
Le grande erano in nove, otto arrabbiate con la Mantiero, e la Mantiero. In verità non si occupavano molto di me; io ridevo quando ridevano loro, e quando facevano la faccia seria la facevo anch'io, anzi un po' troppo qualche volta. «Che cos'ha quello lì? Gli viene male?» dicevano a mia cugina Este: non parlavano mai direttamente a me, ma solo per procura alla Este. Io spianavo in fretta la faccia e loro tornavano a confabulare. Quando poi avevano qualcosa di veramente segreto, dicevano alla Este di mandarmi via, e parlottavano tra loro mentre io aspettavo in disparte.
Stetti arrabbiato con la Mantiero per molti giorni e quando passava da sola sull'altro marciapiede, con lo scialletto nero stretto attorno alle spalle e un'espressione rattristata e dignitosa sul viso, io in mezzo alle grande sentivo un gradevole senso di complicità e cercavo l'occhio della Este o della Pozzàn per rassicurarle della mia intransigenza. Quelle non davano segno di nulla. Un giorno la Mantiero uscì in mezzo alle altre, e ci avviammo tutti insieme. Provavo un vivo senso di tensione, tanto più spiccato perché le formidabili grande sapevano nascondere bene i loro veri sentimenti. Parlavano del più e del meno, e la Mantiero partecipava alla conversazione e agli scherzi. “Ora la sbranano,” pensavo: invece in piazza si salutarono e tutte andarono via per conto loro. Appena possibile chiesi alla Este:
«Este, noi siamo arrabbiati con la Mantiero, eh?».
La Este mi disse: «Taci, sprotóne, cosa vuoi sapere tu?».
Mi resi conto che ero rimasto io solo a stare arrabbiato con la Mantiero: le grande avevano tradito la loro stessa causa con una frivolezza quasi incredibile. E non fu nemmeno l'ultima che mi fecero le grande. Scendevamo verso la piazza io la Flora e la Este: davanti a noi sul marciapiede uscì la signora Ramira, rossa di capelli, snella e presuntuosa. Mie cugine spettegolavano criticando la figuretta che ci precedeva ancheggiando. «La trà ‘l culo,» bisbigliavano.
Io camminavo in mezzo e volevo partecipare anch'io alla conversazione, dare un contributo. Ci pensai su e dissi: «La trà la frìtola». Questo contributo non era basato su un'osservazione empirica, ma lo stesso mi pareva abbastanza pregevole; invece le mie cugine si mostrarono scandalizzate e minacciarono di denunziarmi alla zia Nina. Ecco dunque: si possono fare i pettegolezzi sul culo, ma sulla frìtola no.
Dalla maestra Prospera imparavamo l'alfabeto e i numeri, e l'uso di certe parole come “spaziosa”, “chicchi”, “imposte”, e altre finezze della lingua scritta. Una volta trovammo anche “dirupi” che la maestra fece cercare alla Elsa in un libro molto grosso, nero, in cui disse che c'erano tutte le parole che ci sono.
Si arrabbiò però quando io, in seconda, scrissi in un tema a casa che la Pasqua è “una delle maggiori solennità ecclesiastiche”. Mi disse che io non potevo sapere cosa vuol dire ecclesiastiche, ma io cercai di bleffare e dissi che lo sapevo.
«E che cosa vuol dire?» domandò la maestra. Dovetti improvvisare: «Vuol dire le solenità dell'ano». Era una spiegazione abbastanza ingegnosa, ma fu respinta.
L'effetto delle parole scritte, quelle della lingua, su di noi che parlavamo dialetto, era assai strano. Mia madre ebbe un alunno press'a poco della mia età, che si chiamava Mansueto ed era allegro, spilungone, asimmetrico e simpatico. Andando a casa dopo una lezione su non so che fiore “odoroso”, Mansueto s'era fermato sotto il capitello di contrà Muzana e lanciava in aria una palla di gomma recitando come in una lauda:
La palla odo
rosa! la palla
odorosa! odo rosa!
Una parola credo di averla introdotta io a Malo, un pomeriggio. Eravamo in molti nel cortile della nonna, c'era un mucchio di sabbia e stavamo facendo certe invenzioni capricciose di castelli e torri, con grande eccitazione e trambusto. A un tratto vidi che la costruzione accennava a incrinarsi e dissi: «Crolla!». La parola magica sentita da me chissà dove, sconosciuta a tutti gli altri ma immediatamente capita, si sparse come una vampata. Tutti borbottavano «crolla, crolla,» affaccendandosi, mentre la nostra opera si accasciava. La parola nuova era l'evento stesso.
Avevo avuto delle avventure con le parole fin dal tempo dell'asilo (o come si diceva scola-l'esìlo), dove il mio arrivo era stato amareggiato da un'inattesa esperienza linguistica e insieme sociale. Fu quando espressi ingenuamente il proposito di fare pissìn, la sola espressione che conoscevo in materia, e fui deriso a lungo come una specie di signorina da quei sodi popolani tra i due e i cinque anni che dicevano soltanto pissare.
(Luigi Meneghello, Libera nos a malo, Bur Rizzoli, Milano 2020, pp. 16-22)
ZIBALDONE MINIMO
Una nuova rubrica per parlare di parole della nostra vita quotidiana in modo incisivo e conciso. Parole che ci parlano e che vorremmo rendere ancora più parlanti.
Ordine
di Gianni Gasparini

Ricordo un adagio latino che mi insegnarono da ragazzo: Ubi ordo deficit nulla virtus sufficit. Come se l’ordine fosse l’ingrediente o il flavour che dà consistenza a ciò che si fa e non si fa, persino a quella dimensione profonda che si identifica con la o le virtù.
Ma di quale ordine si tratta? ‘Ordine’ ci può richiamare per associazione di idee le forze dell’ordine, la polizia, i poteri dello stato che si esercitano sui cittadini, in modo legittimo – normalmente – nei paesi democratici e in modi abnormi in altri paesi. E ci può evocare idee o ideologie, movimenti che portano a situazioni devianti rispetto alla democrazia, a quelle figure che hanno incarnato specialmente nel XX secolo gli ‘uomini d’ordine’, gli ‘uomini forti’ e più apertamente i dittatori dei regimi nazisti, fascisti, autoritari.
Non è questo il senso di ordine a cui qui si vuole alludere. C’è infatti, anzitutto, l’ordine della propria persona, corpo e anima, a cui pensare. “Se in noi non è ordine, non creeremo ordine”: la parola disarmante di un contemplativo dei nostri tempi (padre Giovanni Vannucci, che fu monaco alle Stinche in Toscana) ci avverte della necessità di costruire o ricostituire ordine in noi stessi, nella nostra vita, nel nostro quotidiano, affinché questo possa riflettersi anche nei rapporti con le cose che usiamo, e soprattutto con gli altri e con la terra che abitiamo.
Portare ordine nel pianeta, partendo dalla piccola zolla che ciascuno di noi può coltivare, significa avere cura del pianeta. Vuol dire rendersi responsabili oggi della nostra terra e dell’ambiente, portando avanti un disegno di ordine improntato alla giustizia e alla pace.

