
In questa pagina:
Il Punto: Voglia di scuola vera (Maddalena Gissi)
La pianta del mese: Deschampsia media (Eva Kaiser - Flavia Milone)
Il Cantico: Uomini dalla fine del mondo (Pietro Barcellona)
Le fonti: La libertà è la regola (Mario Bertin)
Il filo dei mesi: Com'era il mese di giugno (Gianni Gasparini)
Aforismi: Festìna Lente (Leonarda Tola)
Il dibattito: Gli acrobati della valutazione (Elisabetta Ricci - Raffaele Mantegazza)
Hombre vertical: Camminando contromano (Emidio Pichelan)
Dai nostri iscritti: Pensiero a settembre (Matilde Bissoli - Lorenzo Gobbi)
Ricorrenze: Nefandezze "a furor di popolo"
Note musicali: Richard Wagner, Morte di Sigfrido (Francesco Ottonello)
Frammenti: Vivere senza convivialità? (Gianni Gasparini)
Scrivici, se vuoi, al seguente indirizzo: redazione.scuola@cisl.it
IL PUNTO
di Maddalena Gissi
Voglia di scuola vera

Tornare a vivere una scuola vera, uscire il più presto possibile da una condizione innaturale, che tale resta nonostante la generosità, l’impegno, la professionalità di cui un’intera categoria sta dando prova in questa lunga e difficile emergenza; ridare ai nostri alunni il calore di una relazione viva e diretta con i loro insegnanti e i loro compagni. Se questo è l’obiettivo da perseguire, non lo si può fare con la superficialità di qualche slogan, serve impegnarsi a fondo, e investire il necessario, per affrontare e risolvere gli enormi problemi che una ripresa in presenza delle attività didattiche comporta.
Da qui le ragioni che ci hanno indotto alla sofferta decisione di proclamare uno sciopero nei giorni conclusivi di un anno scolastico indubbiamente difficile e tormentato oltre misura; un’esperienza di cui – l’abbiamo detto e ripetuto più volte – potremo anche far tesoro domani, mettendo a frutto conoscenze, competenze, dimestichezze acquisite nell’utilizzo di strumenti e linguaggi con i quali siamo stati costretti ad avere consuetudine, ma un’esperienza dalla quale sentiamo tutti il bisogno di liberarci quanto prima.
Purtroppo non possiamo farlo semplicemente riaprendo le porte delle nostre scuole: anche per gestire una presenza molto circoscritta e ridotta come quella prevista per lo svolgimento degli esami di maturità si è reso necessario un complesso di regole e precauzioni definite in modo dettagliato e da rispettare scupolosamente. Il protocollo d’intesa che abbiamo sottoscritto pochi giorni fa individua le sedi per un monitoraggio a diversi livelli sulla loro corretta attuazione, in un contesto che impone comunque di mantenere un’attenta vigilanza.
È stato lo stesso presidente del Comitato Tecnico Scientifico della Protezione Civile a sconsigliare vivamente lo svolgimento di un “ultimo giorno di scuola” in presenza, proposta indubbiamente non priva di suggestione ma, secondo il parere unanime del CTS, ancora troppo carica di rischi. Il commiato dagli alunni, soprattutto per le classi terminali di un ciclo, è sicuramente un momento di particolare intensità emotiva nella vita di un insegnante, e in generale per chi lavora in una scuola. Non poterlo vivere significa anche rinunciare a quanto di gratificante può esservi negli abbracci, nei sorrisi, talvolta in qualche lacrima, che gli sguardi scambiati in quei momenti si regalano, come dono prezioso. Andrebbe spiegato a quel sindaco di un’importante città che, esternando sui social, ha lanciato agli insegnanti un’implicita accusa di pavidità, affermando che, “in quanto sono pagati”, per salutare i propri alunni potrebbero anche prendersi qualche rischio. Come se in gioco ci fosse soltanto la loro salute, non quella dell’intera collettività. Se ancora ce ne fosse bisogno, ritroviamo in questo episodio il vizio purtroppo dilagante di una politica intenta ad alimentare aspettative, solleticare desideri (o fomentare paure), elencare i problemi anziché affrontarli con la determinazione necessaria per risolverli.
Che ci sia necessità di riaprire le scuole è fin troppo chiaro. Ne hanno bisogno, e diritto, prima di tutto i 10 milioni di alunne e alunni delle nostre scuole pubbliche, statali e non. Ancor più di quanto non ne abbiano le loro famiglie di veder soddisfatta una comprensibile esigenza di assistenza e custodia: compito – va detto peraltro con molta chiarezza - che non può essere solo della scuola, cui ne spettano altri e di diversa natura.
Una riapertura in sicurezza, esigenza che non riguarda solo il personale scolastico, come già detto, ma l’intera collettività, richiede un volume di investimenti molto più alto di quello al momento ipotizzato. I costi per un’attività in presenza condotta secondo le indicazioni del CTS sono facilmente stimabili, e vanno dal miliardo di euro circa per la fornitura di DPI ad alunni e personale, ai quasi quattro miliardi necessari per garantire alle scuole un congruo numero di personale aggiuntivo nel periodo settembre 2020 – giugno 2021, se la presenza a scuola dovrà essere per gruppi ristretti e se, come auspichiamo, si accantonerà del tutto l’idea di alternare fifty-fifty lezioni in presenza e lezioni a distanza. Oggi abbiamo a disposizione poco più di un miliardo: non avremo personale in più, e grazie alle scelte fatte in materia di reclutamento si allargherà ulteriormente l’area del lavoro precario, esattamente l’opposto di quanto servirebbe per gestire con la massima efficacia una fase così difficile e complessa per la nostra scuola.
Concludendo, e rinviando alle nostre quotidiane prese di posizione per quanto riguarda gli sviluppi di una situazione nella quale ci sarebbe necessità di un serrato confronto, ma purtroppo insieme a evidenti limiti di capacità di governo si conferma una scarsa propensione a valorizzare le relazioni sindacali, vorremmo che fosse colto in tutto il suo significato il senso della vertenza che ci ha portati allo sciopero: non la difesa di interessi settoriali (pur presenti, legittimi e doverosamente considerati), ma quella di un interesse generale e comune, come lo è una ripresa delle attività scolastiche in condizioni di sicurezza, questione di grande complessità e di notevole impatto, per tutte le sue implicazioni, sull’insieme della collettività.
Sappiamo bene che le pesanti ricadute della pandemia sul sistema economico e produttivo richiederanno di destinare ingenti risorse per interventi che scongiurino un possibile disastro sociale. Che questa sia oggi un’assoluta priorità è fuori discussione, così come lo è quella di garantire un adeguato livello di protezione sanitaria, non essendo purtroppo scongiurato il rischio di una nuova ondata di contagio. Ma anche riaprire le nostre scuole, e farlo nella massima sicurezza, merita sicuramente di diventare una delle grandi priorità su cui scegliere e investire.
Per come stiamo vivendo quest'anno scolastico, riesce persino difficile percepire il mese di giugno come sempre è stato per la comunità scolastica, un momento di conclusione e di commiato, per quasi tutti di un "arrivederci" dopo essersi frequentati e "visti" per dieci mesi. Ci manca, questo momento, e cresce la nostra voglia di ritornare al più presto a una scuola vera.
LA PIANTA DI COPERTINA
Disegno di Eva Kaiser
Testo di Flavia Milone
Deschampsia media

La Deschampsia media è un’erba perenne inserita nelle liste della IUCN nel 2009 come particolarmente minacciata.
Le poche notizie reperite in letteratura riportano che la specie predilige pascoli umidi, rive dei fiumi e prati erbosi.
In passato, fu segnalata in Liguria e in Toscana e fu riosservata solo nell’immediato dopoguerra; un campione giace nei depositi dell’Herbarium Centrale Italicum.
Di recente, a Grosseto, a circa 400 m s.l.m sono state identificate poche decine di individui (cespi), in totale ben al di sotto delle 100 unità.
La specie, per le sue caratteristiche morfologiche e la sua fioritura tardiva, che avviene dalla seconda metà di giugno fino a metà luglio, è di difficile osservazione. In seguito al cambiamento climatico, la Deschampsia media risulta essere particolarmente vulnerabile alla diminuzione delle precipitazioni, particolarmente marcata negli ultimi decenni nel grossetano, che ha portato ad una perdita di umidità del terreno col conseguente disseccamento precoce che favorisce altre specie più tolleranti.
IL CANTICO
Uomini dalla fine del mondo
di Pietro Barcellona
Il testo che pubblichiamo è la trascrizione dell’intervento fatto in occasione della presentazione del libro di Mario Bertin “Francesco”, nel marzo 2013, da Pietro Barcellona, pochi mesi prima della sua morte. Lo presentiamo nella versione colloquiale originale, ripulito soltanto dai riferimenti al libro.

Francesco è una figura per certi versi sconvolgente nella storia dell'occidente. Non ci sono persone che hanno vissuto un'esperienza dello stesso tipo. Mi ha colpito molto. Non so se è stato un lapsus oppure se è stato un retropensiero che si è immediatamente manifestato; ma quando il papa ha detto: “mi hanno preso alla fine del mondo”, cioè questo concetto di irruzione di qualcosa che stava completamente fuori, io sono stato molto colpito. Perché negli ultimi anni della mia vita ho molto approfondito il tema del messia, dell'escatologia. E proprio questo problema dell'evento che rompe la continuità storica. E questo venire dalla fine del mondo mi è sembrata una dichiarazione che al di là di quello che il papa dice esplicitamente, secondo me significa una cosa: cos'è finito? Cosa sta finendo? Noi stiamo vivendo un tempo della fine, come Francesco ha vissuto. Sta finendo il mondo occidentale. Quello che rappresenta questo papa, al di là di queste cose che stanno suscitando l'attenzione dei giornali, dei media, questo papa di per sé – credo, naturalmente sarebbe impossibile fare previsioni – segna una discontinuità totale col primato che ha avuto finora la cultura occidentale. Il tramonto dell'occidente adesso si è compiuto. E l'occidente si deve consegnare a un'altra storia, a un'altra narrazione. Non può continuare. È proprio una svolta antropologica.
L'antropologia dell'occidente, quella con cui siamo cresciuti e siamo abituati a parlarci, è l'antropologia del soggetto. I bambini cominciano a declinare la prima persona: io voglio. Noi siamo abituati a vedere il soggetto di fronte al mondo. In questo paradigma, in questo schema, c'è una logica implicita di dominio: il soggetto domina il mondo. E noi abbiamo usato anche la tradizione religiosa con l'idea che la cacciata dal paradiso ha significato la consegna di un mondo. Fanne quello che vuoi. E invece, nella visione che cercherò di approfondire, l'antropologia è una antropologia relazionale. L'io non sta prima, non è fuori dalla scena e guarda facendo l'osservatore. È dentro il campo. E dentro il campo c'è in primo luogo la natura. E naturalmente questa antropologia è una antropologia non del soggetto ma della relazione creativa. Non può non esserci l'idea della creaturalità. Chi sta dentro è nato all'interno di un contesto, un gruppo, un padre, una madre, che poi fra l'altro sono due persone abbastanza tormentate dall'aver avuto un figlio così impossibile da classificare.
Ma questa antropologia della relazione introduce un concetto opposto a quello del dominio, che è il concetto della custodia. Un concetto sul quale mi pare che sta riflettendo anche questo papa. Cioè custodire il mondo, custodire la creazione. È uno sguardo opposto rispetto a quello a cui siamo abituati. Noi siamo piantati in questa monocultura dell'io. Anche quando - lo dico per averlo direttamente sperimentato - si fa un'esperienza psicoanalitica, l'io non si destruttura, non si decentra. Continua a esprimere agonismo, continua a esprimere contrapposizione. E però se l'io resta in campo come soggettività, quello che può fare al massimo è beneficenza, non amore.
Un'antropologia dell'amore è il contrario della beneficenza. È esattamente il contrario. Nel mondo in cui viviamo noi pensiamo che ci mettiamo in pace, facciamo i conti con la coscienza regalando generosamente. No. Qui il problema è completamente rovesciato. Non c'è questa idea della beneficenza come qualcuno che si permette di considerare un altro a un livello talmente basso che lo aiuta. Qui siamo oltre all'aiuto. Siamo nella comunione. Nella comunione di quale condizione? Nella condizione in cui si trova chi non ha un io così onnipotente da dominare il mondo; ma non ha perso il senso di sé. Ce l'ha all'interno di una relazione che lo porta unicamente alla condivisione. La comunione, come il contrario. Noi facciamo patti con Dio. Ti faccio le opere buone e tu poi mi dai il paradiso. Macché patti e patti. Qui si parte da una condizione che è la nudità dell'uomo.
Questa nudità dell'uomo ha un rapporto molto forte, questo bisognerebbe dirlo a tanti che ne parlano a vanvera, con il niente. Il libro si chiude difatti con una riflessione che prende questo tema del niente. E il niente, proprio per il soggetto, è qualcosa di distruttivo, di negativo. Invece per il mistico il niente è quello che Freud chiamava il sentimento oceanico, cioè l'idea di essere immerso in una drammatica, ma destinata alla gloria, vicenda universale, che riguarda le molecole, che riguarda le piante. Questo è il “cambiamento di sguardo” in cui consiste la conversione; non la conversione di chi va magari venti volte a confessarsi, ma la conversione come fatto interno, come fatto ignoto, non esibito. Tutto questo fatto delle conversioni: non amo questa cosa perché è riduttiva della presenza.
La presenza è un concetto di una trascendentalità straordinaria. Non so se vi ricordare il film Luci della ribalta di Chaplin, che mi ha colpito molto. Quando Chaplin deve spiegare le ragioni della vita alla ragazza che si stava suicidando, che fa? Descrive le cose, la presenza: la rosa è una rosa. E fa la mimica corporea, materiale delle cose. Le scene in cui Francesco è abbandonato in mezzo all'erba, sotto le piante, nella grotta in cui viene tormentato dai fantasmi, sono scene inauditamente trascendentali; ma perché sono il trascendentale interno all'esperienza della vita. Il trascendentale non si deve trovare chissà dove, magari appunto con un viaggio astronautico. Si deve trovare nella presenza. Ma la presenza non si può dire con i concetti. Fanno un sacco di cose, purtroppo io li ho anche sfottuti: il cortile dei gentili, la discussione tra il filosofo e il teologo. Sono tutte cose da buttare a mare. Il problema è l'iniziazione alla presenza. Sentirsi una pietra, un pezzo di erba, un pezzo di ramo. Ma questa cosa straordinaria noi l'abbiamo perduta perché l'occidente l'ha distrutta.
L'Occidente ha questa radice, una radice nobile, radice greca, per cui a un certo punto il conoscere sé stessi fa da spinta per una ragione logica capace di distinguere, analizzare, creare. Io so perché mi trovo a combattere. Che poi Aristotele e San Tommaso hanno costruito il blocco culturale. Meno male che c'è stato Francesco. Francesco ha completamente rotto questo schema. Non c'è più. Non si può fare teologia con Francesco. Qual è la teologia di Francesco? La teologia della nudità. Esiste una concettualizzazione dell'essere nudo, di chi non ha niente da perdere. E in questo senso i poveri non è che sono da commiserare, da compiangere. Questo concetto in un certo senso - io non lo faccio per ragioni di bottega - era presente anche in Marx, poi è stato naturalmente anche stravolto da esperienze drammatiche che ci sono state. Ma cosa pensava? Che solo chi non ha altro che le proprie catene, non ha niente, ha sé stesso, il sé nudo, può pensare che il Mondo va cambiato. Solo che il Mondo cambiato in quel modo ha portato ai disastri che conosciamo. Perché il Mondo non va cambiato nella superficie, ma in profondità.
È qui che viene il discorso sulla regola, perché la presenza poi ha una seconda parte che è la regola. Noi stiamo a romperci l'anima sulla legge. Perché la legge ha una caratteristica che noi spesso non valutiamo. Cioè è sempre eteronoma. Non è autonoma. La legge l'ha prodotta qualcuno e ce l'ha data. Anche sul Monte Sinai sono state consegnate le leggi, ma sono leggi date. Quand'è che invece si ha la costituzione relazionale nel rapporto conviviale della regola? Nella prassi. Il Vangelo è una prassi creativa di regole, ma regole immanenti. Quando a Cristo chiedevano: ma che dobbiamo fare? Diceva: seguitemi, io sono la via, la vita e la verità. E Francesco non voleva la regola. Ma non perché era anarchico. Guardate: c'è un errore di grammatica. Perché il vero fondamento normativo è la prassi sociale, mica sono i parlamenti. I parlamenti formalizzano le prassi sociali, per rendere più sicuro il rapporto tra società che sono oramai dilatate. Ma la prassi è normativa, la vita è normativa. Questo è scomparso dall'orizzonte. Perché la legalità è quanto di più falso ci possa essere.
Giustamente Cristo se la prendeva con la legalità, perché significava la lettera, i farisei, i rabbini, gli esperti della legge, i giuristi. Guardate: io sono professionalmente nato come giurista. L'ho fatto per mio padre che era avvocato. Ma ho passato tutta la vita a criticare il diritto. Perché è una stampella per gli zoppi. Il massimo che può dare il diritto è questo. Non c'entra niente con la giustizia. Perché la giustizia è immanente alla relazione, è la reciprocità della relazione; e proprio per questo non può essere trasformata in un catechismo. Questo per esempio la chiesa non l'ha capito affatto. Io ho avuto degli scontri con Monsignor Fisichella con cui mi è capitato di discutere. Ma a che serve dire il precettino: non avere rapporti prima del matrimonio. Una volta eravamo insieme e sono venuti un ragazzo e una ragazza chiedendo: ma allora che faccio con la mia ragazza? Lui: niente! E io: ma guarda, vai in pace... Te lo dico io anche se non sono autorizzato.
Perché il problema della regola è opposto a quello della legge. E difatti c'è uno studioso bravo, che non è molto conosciuto in Italia e invece molto all'estero: Giorgio Agamben, che ha scritto un libro bellissimo, anche molto difficile: L'altissima povertà. Che ha contrapposto la regola alla legge, e si è occupato proprio della regola francescana, perché la regola francescana è molto diversa dalle altre. Giustamente qui è raccontato uno scontro, persino un'incomprensione dei suoi confratelli, e il dispiacere, l'enorme dispiacere che Francesco deve provare quando alla fine, con questo Ugolino che placa per misericordia, accetta che si faccia una legge in modo da far rientrare l’ordine nella storia della Chiesa. Ma in realtà quello che viene fuori nella sostanza è questo enorme messaggio nuovo. La giustizia siamo noi. Ma se noi non prescindiamo dai greci che hanno inventato questa cosa dei concetti, nei testi sacri non c'è la giustizia, c'è l'uomo giusto. Così come non c'è la verità come concetto, ma c'è l'azione vera. La declinazione esperienziale è quella che traduce poi quello che noi formuliamo come concetto perché siamo figli della ragione occidentale.
Ma questo mondo è finito. Cosa può fare? Produce algoritmi oramai. Produce calcoli matematici. Non può più produrre poesia. Non può avere creatività. Deve denudarsi. Deve fare un'operazione radicale. C'è qualcosa di dionisiaco. Io ho sempre amato molto le baccanti. E Dioniso è stato un Cristo per certi versi. Perché c'è questo amore per la natura selvatica, le spine, buttarsi nel roveto. Non come cintura di castità ma come manifestazione di amore per le spine. Riuscire ad amare le spine significa compenetrarsi. Fu fottuto perché influenzato dai sofisti che l'hanno portato a un conflitto con la natura tanto che poi le baccanti se lo mangiarono.
E invece Cristo ha preso la croce e i chiodi per amore della verità. Non è una logica sacrificale, è l'amore del mondo, della natura, della vita. È la verità. Tutta questa concezione sacrificale che ci fa ritornare ai miti barbarici non c'entra niente. Gesù Cristo è morto sulla croce perché ha testimoniato la verità e l'amore. E questo mi riporta al concetto di essere nudi di fronte alla morte. Perché la nudità in realtà chiama in causa due cose che noi abbiamo perduto: la libertà e l'amore. La libertà non è quella di cui parlano tutti. La libertà è un'altra cosa. La libertà è non avere dentro di sé quelli che io chiamo i persecutori interni, che sono questi superio arcaico, primitivo, tirannico. La libertà è liberarsi di questo. Non dall'esterno, ma dentro di noi avviene la liberazione. Quando noi riusciamo a mettere fuori campo quello che io chiamo il sé luciferino, che è l'eredità diabolica che viene da questa visione arcaica del potere tirannico. E questa libertà contiene l'amore. Come si può avere l'amore se non si è liberi di amare? Se non si realizza davvero per la prima volta qualcosa che non c'era prima? Se non c'è la libertà l'amore è una deduzione. Non è una creazione. Ma tutto ciò che è creativo presuppone la libertà. La libertà nasce dalla nudità. Non può che nascere da questo, dal confondersi in certi momenti, salvo poi riprendere sé stesso, in questa sensazione di completo assorbimento nella natura.
L'ultima cosa voglio dire, che riguarda questo problema del rapporto con le cose, che ritorna nella terza parte del libro: le cose si intrecciano con i fatti, sono i fatti. L'amore non può essere inquadrato in un formalismo rigido. Questo amore tra Francesco e Chiara non è un amore astratto, è un amore concreto. L'ultima donna, che si prende cura del corpo di Francesco morto, è un'altra donna che lo ama. E il frate cosa le dice? Adesso che è morto abbraccialo, bacialo. E quella gli dà un bacio. Perché c'è una carnalità dell'amore che non è necessariamente il rapporto sessuale. La carnalità dell'amore, la sua fisicità, non è il rapporto sessuale. È un'altra cosa. È il travasamento della psiche di uno nella psiche dell'altro. Assomiglia all'estasi. Ma non può essere come adesso che si fanno le agenzie per incontri, o cose del genere: non è possibile. L'amore si produce per caso, perché è figlio della libertà. Non si può programmare. Non si può decidere. E qui c'è l'ultimo punto che riguarda proprio la fine di Francesco, che sente che questa morte arriva e che è allo stesso tempo il ritorno dal padre ma anche l'ingresso nel nulla. E questo io lo voglio sottolineare. Il nulla viene oggi sottolineato come nichilismo, ma il nulla è il vuoto per la pienezza. Se io continuo ad avere i miei pensieri egoistici in testa, non entra niente.
Analiticamente si dice che dopo una depressione una persona si deve svuotare, come se facesse una purificazione del corpo; perché solo così può entrare poi qualcosa. Il nulla è il contenitore dell'essere, perché è quello che lo rende possibile nella sua pienezza. Qui secondo me c'è un'altra riflessione da fare, rispetto a quello che è oggi il sentimento comune del cosiddetto nichilismo, di cui parlano sociologi, psicologi, ci sono rubriche....
Il niente è una cosa meravigliosa.
LE FONTI
a cura di Mario Bertin
La libertà è la regola
L’intervento di Pietro Barcellona si sofferma su molti temi dell’esperienza francescana delle origini cruciali anche per la vita individuale e collettiva di oggi. Poiché, per ragioni di spazio, è impossibile fornire di tutti una documentazione attraverso le Fonti, abbiamo scelto di documentare soltanto il dibattito Regola e di riportare gli articoli salienti della Regola detta “non bollata”, quella cioè più vicina ed espressiva del pensiero del Santo, che non ottenne l’approvazione ufficiale della Chiesa. Da questi testi emerge come Francesco pretendesse di vivere e che i suoi frati vivessero “in conformità del Vangelo”, con il quale intravvedeva un legame profondo di verità e di libertà, da osservare “alla lettera” (vedi la Leggenda Perugina, 4).
IL DIBATTITO SULLA REGOLA
Mentre Francesco era al Capitolo generale, detto delle Stuoie*, che si tenne presso la Porziuncola e a cui intervennero cinquemila fratelli, molti di questi, uomini di cultura, accostarono il cardinale Ugolino, il futuro Gregorio IX, che a sua volta partecipava all'assise capitolare. E gli chiesero che persuadesse Francesco a seguire i consigli dei frati dotti e a lasciarsi qualche volta guidare da loro. Facevano riferimento alle Regole di san Benedetto, sant'Agostino e san Bernardo, che prescrivono questa e quest'altra norma al fine di condurre una vita religiosa ben ordinata.
Udita che ebbe Francesco l'esortazione del cardinale su tale argomento, lo prese per mano e lo condusse davanti all'assemblea capitolare, dove disse: «Fratelli, fratelli miei, Dio mi ha chiamato a camminare la via della semplicità e me l'ha mostrata. Non voglio quindi che mi nominiate altre Regole, né quella di sant'Agostino, né quella di san Bernardo o di san Benedetto. Il Signore mi ha rivelato essere suo volere che io fossi un pazzo nel mondo: questa è la scienza alla quale Dio vuole che ci dedichiamo! Egli vi confonderà per mezzo della vostra stessa scienza e sapienza. Io ho fiducia nei castaldi del Signore, di cui si servirà per punirvi. Allora, volenti o nolenti, farete ritorno con gran vergogna alla vostra vocazione».
Stupì il cardinale a queste parole e non disse nulla, e tutti i frati furono pervasi da timore. (Leg. per., 114)
* Il Capitolo detto delle Stuoie, presente il cardinale Ugolino, secondo lo Specchio di perfezione e la Leggenda perugina, non può essere quello della Pentecoste del 1219.
REGOLA NON BOLLATA
I
Che i frati vivano in obbedienza,
senza nulla di proprio e in castità
La regola e la vita dei frati è questa, cioè vivere in obbedienza, in castità e senza nulla di proprio, e seguire la dottrina e l'esempio del Signore nostro Gesù Cristo, il quale dice: «Se vuoi essere perfetto, va', vendi tutto quello che hai, dallo ai poveri e avrai un tesoro nel cielo; e poi vieni e seguimi»; e: «Se qualcuno vuol venire dietro a me, rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua»; e ancora: «Se qualcuno viene a me e non odia il padre, la madre, la moglie e i figli, i fratelli e le sorelle e anche la sua vita stessa non può essere mio discepolo». E: «Chi avrà lasciato o il padre e la madre, o la moglie o i figli, la casa o i campi per amore mio, riceverà il centuplo e possederà la vita eterna».
II
Dell'accettazione e delle vesti dei frati
Se qualcuno, per divina ispirazione, volendo scegliere questa vita, verrà dai nostri frati, sia da essi benignamente accolto.
E se sarà deciso nell'accettare la nostra vita, si guardino bene i frati di non intromettersi nei suoi affari temporali, ma, quanto prima possono, lo presentino al loro ministro.
Il ministro poi lo riceva con bontà e lo conforti e diligentemente gli esponga il tenore della nostra vita. Dopo di che il predetto se vuole e può spiritualmente e senza ostacoli, venda tutte le cose sue e procuri di distribuire tutto ai poveri.
Si guardino i frati e il ministro dei frati dall'intromettersi in alcun modo nei suoi affari, e dal ricevere denari, né direttamente né per interposta persona. Se tuttavia fossero nel bisogno, possono i frati ricevere le altre cose necessarie al corpo, ma non denaro, come gli altri poveri, per ragione della necessità.
E quando sarà ritornato, il ministro gli conceda i panni dell'anno di prova, e cioè due tonache senza cappuccio e il cingolo e i calzoni e il capperone fino al cingolo*. Finito l'anno e il periodo della prova, sia ricevuto all'obbedienza. […]
Se poi venisse qualcuno che non può dar via le cose sue senza impedimento, ma ne ha spiritualmente l'intenzione, le abbandoni, e ciò è sufficiente.
Nessuno sia ricevuto contro le norme e le prescrizioni della santa Chiesa.
Gli altri frati poi che hanno già promesso obbedienza, abbiano una sola tonaca con il cappuccio e un'altra senza cappuccio, se sarà necessario, e il cingolo e i calzoni.
E tutti i frati portino vesti umili e sia loro concesso di rattopparle con stoffa di sacco e di altre pezze con la benedizione di Dio, poiché dice il Signore nel Vangelo: «Quelli che indossano abiti preziosi e vivono in mezzo alle delizie e portano morbide vesti stanno nei palazzi dei re». E anche se sono tacciati da ipocriti, tuttavia non cessino di fare il bene; né cerchino vesti preziose in questo mondo perché possano avere una veste nel regno dei cieli.
* Gran cappuccio usato dai contadini per difendersi dalla pioggia.
VI
Del ricorso dei frati ai loro ministri
e perché nessun frate sia chiamato priore
I frati, in qualunque luogo sono, se non possono osservare la nostra vita, quanto prima possono, ricorrano al loro ministro indicandoglielo. Il ministro poi studi di provvedere ad essi, così come egli stesso vorrebbe si facesse per lui, se si trovasse in un caso simile.
E nessuno sia chiamato priore, ma tutti siano chiamati semplicemente frati minori. E l'uno lavi i piedi all'altro.
VII
Del modo di servire e di lavorare
Tutti i frati, in qualunque luogo si trovino per servire presso altri o per lavorare, non facciano né gli amministratori né i cancellieri, né presiedano nelle case di coloro a cui prestano servizio; né accettino alcun ufficio che generi scandalo o che porti danno alla loro anima; ma siano minori e sottomessi a tutti coloro che sono in quella stessa casa.
E i frati che sanno lavorare lavorino ed esercitino quel mestiere che già conoscono, se non sarà contrario alla salute della loro anima e che onestamente potranno fare.
Infatti dice il profeta: «Se con la fatica delle tue mani mangi, beato sei e t'andrà bene»; e l'Apostolo: «Chi non vuol lavorare, non mangi: e ciascuno rimanga in quel mestiere e in quella professione cui fu chiamato». E per il lavoro prestato possano ricevere tutto il necessario eccetto il denaro.
E quando sarà necessario vadano per l'elemosina come gli altri poveri.
E possano avere gli arnesi e gli strumenti necessari al loro mestiere [...].
Si guardino i frati, ovunque saranno, negli eremi o in altri luoghi, di non appropriarsi di alcun luogo né lo contendano ad alcuno.
E chiunque verrà da essi, amico o nemico, ladro o brigante, sia ricevuto con bontà.
E ovunque sono i frati e in qualunque luogo si troveranno, spiritualmente e con amore si debbano rispettare e onorare scambievolmente senza mormorazione.
E si guardino i frati dal mostrarsi tristi all'esterno e oscuri in faccia come gli ipocriti, ma si mostrino lieti nel Signore e giocondi e garbatamente allegri.
VIII
Che i frati non ricevano denaro
Il Signore comanda nel Vangelo: «Attenzione, guardatevi da ogni malizia e avarizia; e guardatevi dalle preoccupazioni di questo mondo e dalle cure di questa vita». Per cui nessun frate, ovunque sia, e dovunque vada, in nessun modo prenda con sé o riceva da altri o permetta che sia ricevuta pecunia o denaro, né col pretesto di acquistare vesti, libri, né per compenso di alcun lavoro, insomma per nessuna ragione, se non per una manifesta necessità dei frati malati; poiché non dobbiamo ritenere che l'utilità e il valore della pecunia o del denaro siano maggiori di quello delle pietre.
E il diavolo vuole accecare quelli che lo desiderano e lo stimano più delle pietre. Badiamo, dunque, noi che abbiamo lasciato tutto, di non perdere, per sì poca cosa, il regno dei cieli. E se troveremo in qualche luogo del denaro, trattiamolo come polvere che si calpesta, poiché è vanità delle vanità e tutto è vanità.
E se per caso, Dio non voglia, capitasse che un frate raccogliesse o avesse della pecunia o del denaro, eccettuato soltanto per la predetta necessità relativa agli ammalati, tutti i frati lo ritengano un falso frate e apostata e un ladro e un brigante, e un ricettatore di borse, se sinceramente non si pentirà.
E in nessun modo i frati accettino né permettano di accettare, né cerchino, né facciano cercare pecunia per elemosina, né soldi per case o luoghi, né si accompagnino con persona che vada in cerca di pecunia o di denaro per tali luoghi. Altri servizi invece, che non sono contrari alla nostra forma di vita, i frati li possono fare nei luoghi con la benedizione di Dio.
I frati tuttavia, per manifesta necessità dei lebbrosi, possono per essi chiedere l'elemosina.
Si guardino però molto dalla pecunia. Similmente tutti i frati si guardino di non andare in giro per alcun turpe guadagno.
IX
Della questua
Tutti i frati cerchino di seguire l'umiltà e la povertà del Signore nostro Gesù Cristo, e si ricordino che nient'altro ci è consentito di avere, di tutto il mondo, come dice l'apostolo, se non il cibo e le vesti e di questi ci dobbiamo accontentare.
E devono essere lieti quando vivono tra persone di poco conto e disprezzate, tra poveri e deboli, tra infermi e lebbrosi e tra i mendicanti lungo la strada.
E quando sarà necessario, vadano per l'elemosina.
E non si vergognino, ma ancor più si ricordino che il Signor nostro Gesù Cristo, Figlio del Dio vivo onnipotente, rese la sua faccia come pietra durissima, né si vergognò; e fu povero e ospite, e visse di elemosina, lui e la beata Vergine e i suoi discepoli. E quando gli uomini faranno loro ingiuria e non vorranno dare loro l'elemosina, ne ringrazino Iddio, poiché dell'ingiuria subita riceveranno grande onore presso il tribunale del Signore nostro Gesù Cristo.
E sappiano che l'ingiuria fa torto non a coloro che la ricevono ma a coloro che la fanno.
E l'elemosina è l'eredità e il giusto diritto dovuto ai poveri; lo ha acquistato per noi il Signor nostro Gesù Cristo.
E i frati che lavorano per acquistarla avranno grande ricompensa e la fanno guadagnare e acquistare a chi la fa, poiché tutto quello che gli uomini lasciano nel mondo, perirà, ma della carità e dell'elemosina che hanno fatto avranno il premio dal Signore.
E con fiducia l'uno manifesti all'altro le proprie necessità perché l'altro gli trovi le cose necessarie e gliele dia. E ciascuno ami e nutra il suo fratello come la madre ama e nutre il proprio figlio, in tutte quelle cose in cui Dio gli darà grazia. E colui che mangia non disprezzi colui che non mangia e colui che non mangia non giudichi colui che mangia. E ogniqualvolta sopravvenga il bisogno, sia consentito a tutti i frati, ovunque si trovino, di prendere tutti i cibi che gli uomini possono mangiare, così come il Signore dice di David, il quale mangiò i pani dell'offerta che non era permesso mangiare se non ai sacerdoti. E ricordino ciò che dice il Signore: «Badate che i vostri cuori non siano aggravati dalla crapula e dall'ubriachezza e dalle preoccupazioni di questa vita e che quel giorno non venga su di voi all'improvviso, poiché cadrà come un laccio su tutti coloro che si troveranno sulla faccia della terra». Similmente anche in tempo di manifesta necessità tutti i frati facciano delle cose loro necessarie così come il Signore darà loro la grazia, poiché la necessità non ha legge.
XIV
Come i frati devono andare per il mondo
Quando i frati vanno per il mondo non portino niente per il viaggio, né sacco, né bisaccia, né pane, né pecunia, né bastone. E in qualunque casa entreranno dicano prima: «Pace a questa casa». E dimorando in quella casa mangino e bevano quello che ci sarà presso di loro. Non resistano al malvagio; ma se uno li percuote su una guancia, gli offrano l'altra. E se uno vuol togliere loro il mantello, non gli impediscano di prendere anche la tunica. Diano a chiunque chiede; e a chi toglie il loro non lo richiedano.
XVI
Di coloro che vanno tra i Saraceni e altri infedeli
Dice il Signore: «Ecco, io vi mando come pecore in mezzo ai lupi. Siate dunque prudenti come serpenti e semplici come colombe».
Perciò quei frati che, per divina ispirazione, vorranno andare fra i Saraceni e altri infedeli, vadano con il permesso del loro ministro e servo.
Il ministro poi dia loro il permesso e non li ostacoli se vedrà che essi sono idonei ad essere mandati; infatti dovrà rendere ragione al Signore, se in queste come in altre cose avrà proceduto senza discrezione. I frati poi che vanno fra gli infedeli, possono ordinare i rapporti spirituali in mezzo a loro in due modi. Un modo è che non facciano litio dispute, ma siano soggetti ad ogni creatura umana per amore di Dio e confessino di essere cristiani.
L'altro modo è che, quando vedranno che piace al Signore, annunzino la parola di Dio perché credano in Dio onnipotente Padre e Figlio e Spirito Santo, creatore di tutte le cose, e nel Figlio Redentore e Salvatore, e siano battezzati, e si facciano cristiani, poiché, se uno non rinascerà per acqua e Spirito Santo non potrà entrare nel regno di Dio.
Queste ed altre cose che piaceranno al Signore possono dire ad essi e ad altri; poiché dice il Signore nel Vangelo: «Chi mi riconoscerà davanti agli uomini, Io lo riconoscerò davanti al Padre mio che è nei cieli»; e: «Chiunque si vergognerà di me e delle mie parole, il Figlio dell'uomo si vergognerà di lui, quando tornerà nella gloria sua e del Padre e degli angeli».
E tutti i frati, ovunque sono, si ricordino che hanno consegnato e abbandonato il loro corpo al Signor nostro Gesù Cristo, e per il suo amore devono esporsi ai nemici sia visibili che invisibili, poiché dice il Signore: «Colui che perderà l'anima sua per causa mia la salverà per la vita eterna. Beati quelli che sono perseguitati a causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. Se hanno perseguitato me, perseguiteranno anche voi. Se poi vi perseguitano in una città fuggite in un'altra. Beati sarete, quando vi odieranno e vi perseguiteranno e vi bandiranno e vi insulteranno e il vostro nome sarà proscritto come infame e falsamente diranno di voi ogni male per causa mia; rallegratevi in quel giorno e esultate, perché grande è la vostra ricompensa nei cieli. Dico a voi amici miei: non lasciatevi spaventare da loro e non temete coloro che uccidono il corpo e dopo di ciò non possono far niente di più.
Guardatevi di non turbarvi. Con la vostra pazienza salverete le vostre anime. E chi persevererà sino alla fine, questi sarà salvo».
XXII
Dell'esortazione da farsi ai frati
Frati miei tutti, ascoltiamo ciò che dice il Signore: «Amate i vostri nemici e fate del bene a quelli che vi odiano». Infatti anche il Signore nostro Gesù Cristo, di cui dobbiamo seguire le orme, chiamò amico il suo traditore e si offrì spontaneamente ai suoi crocifissori. Sono dunque nostri amici tutti coloro che ingiustamente ci infliggono tribolazioni e angustie, ignominie e ingiurie, dolori e sofferenze, martirio e morte e li dobbiamo amare molto poiché in virtù di ciò che ci fanno, abbiamo la vita eterna [...].
XXIII
Preghiera, lode, rendimento di grazie
[...] Tutti amiamo con tutto il cuore e con tutta l'anima, con tutta la mente, con tutta la capacità e la fortezza, con tutta l'intelligenza, con tutte le forze, con tutto lo slancio, con tutto l'affetto, con tutti i sentimenti più profondi, con tutto il desiderio e la volontà il Signore Iddio, il quale a noi ha dato e dà tutto il corpo, tutta l'anima, tutta la vita; che tutti ci ha creato e redento, e che ci salverà per sua sola misericordia. Lui che ogni bene fece e fa a noi miserevoli e miseri, pieni di putrido fetore, ingrati e cattivi.
Nient'altro cí piaccia e ci soddisfi se non il Creatore e Redentore e Salvatore nostro, solo vero Dio e che è pienezza di bene, totalità di bene, completezza di bene, vero e sommo bene, che solo è buono, misericordioso e mite, soave e dolce, che solo è santo, giusto, vero e retto, che solo è benigno, innocente e puro, dal quale e per il quale e nel quale è ogni perdono, ogni grazia, ogni gloria di tutti i penitenti e di tutti i giusti, di tutti i santi che godono insieme nei cieli.
Niente dunque ci ostacoli, niente ci separi, niente si interponga. E ovunque, noi tutti, in ogni luogo, in ogni ora, in ogni tempo, ogni giorno, senza cessare crediamo veramente e umilmente e teniamo nel cuore e amiamo, onoriamo, adoriamo, serviamo, lodiamo e benediciamo, glorifichiamo ed esaltiamo, magnifichiamo e ringraziamo l'altissimo e sommo eterno Dio, Trino e Uno, Padre e Figlio e Spirito Santo, Creatore di tutte le cose, Salvatore di chi opera e crede in Lui, di chi ama Lui: il quale, senza inizio e senza fine, immutabile, invisibile, inenarrabile, ineffabile, incomprensibile e ininvestigabile, benedetto, degno di lode, glorioso, sopraesaltato, sublime, eccelso, soave, amabile, dilettevole e tutto sempre e sopra tutte le cose è desiderabile nei secoli dei secoli.
Nel nome del Signore prego tutti i frati affinché imparino la lettera ed il contenuto di tutto ciò che in questa vita è scritto, a salvezza della nostra anima, e frequentemente lo ricordino. E prego Dio affinché egli stesso che è onnipotente, trino e uno, benedica quanti insegnano e imparano, ritengono a memoria e praticano questi precetti, ogni volta che ricordano e fanno quelle cose che in essa sono state scritte a nostra salvezza.
E scongiuro tutti, baciando i piedi, di amare molto, di custodire e di ricordare queste cose.
E da parte di Dio onnipotente e del signor Papa, e in virtù d'obbedienza io, frate Francesco, fermamente comando e ordino che da queste cose, che sono state scritte in questa vita, nessuno tolga o aggiunga parola, né i frati abbiano un'altra Regola.
Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era in principio e ora e sempre e nei secoli dei secoli. Amen.
IL FILO DEI MESI
Com'era il mese di giugno
di Gianni Gasparini

Per chi va a scuola, il mese di giugno è simmetrico rispetto a quello di settembre: alla ripresa di attività del primo fa riscontro nell’altro la fine dell’anno scolastico, con un prolungamento a luglio per gli esami di maturità. Quest’anno come sappiamo è andata diversamente: lo sconvolgimento radicale creato dal Coronavirus ha causato di fatto la chiusura delle scuole a febbraio, in occasione del carnevale. Analoga sorte hanno subìto le università. Si ripartirà a settembre, mentre nel frattempo si è dispiegata una impegnativa attività di lezioni on-line, le quali peraltro non possono certo sostituire il rapporto educativo che avviene dal vivo nella scuola.
Tenuto conto di questo, nonché della riapertura di buona parte di attività e servizi verificatasi nella seconda metà di maggio, che cosa ci dice il mese di giugno dell’anno Duemilaventi?
La prima cosa che mi sembra ci dica è che il corso della natura procede con i suoi ritmi inarrestabili, continua come gli altri anni. Le giornate diventano più calde, si allungano e si preparano nel nostro emisfero al grande evento del solstizio d’estate, che veniva celebrato già da alcuni popoli antichi esperti nell’astronomia. Il monumento megalitico di Stonehenge in Inghilterra, ad esempio, venne apprestato proprio per cogliere con esattezza il solstizio estivo.
Credo che giugno, così come luglio, ci parli del nostro desiderio di entrare decisamente a contatto della natura, di esporre maggiormente il corpo alle radiazioni solari, di usufruire delle condizioni migliori per i bagni al mare, di avvicinarci ai monti per contemplarli e per salirvi.
Da tempo immemorabile in certi paesi, specie dell’Europa centro-settentrionale, il solstizio d’estate si lega alle importanti celebrazioni per la festa di san Giovanni Battista, alle celebrazioni del Midsummer (che non è il centro dell’estate, ma il suo inizio) a cui sono legate le incantate notti estive di cui ci parla Shakespeare nel Sogno di una notte di mezza estate.
Senza dimenticare le condizioni particolari e le restrizioni di cui dobbiamo tenere conto in questa prossima estate (mascherine e distanziamento interpersonale), possiamo immaginare i mesi estivi che abbiamo vissuto in anni trascorsi. Ricordare viaggi all’estero che non potremo fare quest’anno, o viaggi e percorsi in Italia che saranno meno agevoli. Anche il turismo culturale in città e borghi, una straordinaria ricchezza del nostro paese, sarà probabilmente sottoposto a rallentamenti e prenotazioni. La frequentazione delle spiagge, meta consueta lungo i mari che bagnano le nostre coste, dovrà sottostare a precauzioni mai sperimentate in precedenza. È probabile invece che negli spazi aperti della natura, soprattutto in montagna, continueranno ad esservi condizioni per una fruizione più libera e diretta dell’ambiente.
In ogni caso, la regola per l’estate sarà quella di adeguarsi responsabilmente alle norme vigenti in ogni regione e contesto locale, allo scopo di combattere efficacemente il contagio della pandemia.
Gli storici ci ricordano che quella dei mesi fu un’invenzione del calendario giuliano, emanato nel 46 a.C. da Giulio Cesare e giunta fino a noi: una suddivisione del tempo che introdusse un’unità di conto astratta e quantificata, indipendente dall’astronomia e dalla religione. Il mese e la settimana, che non hanno un riscontro naturalistico, si sono rivelati strumenti essenziali nella storia umana degli ultimi due millenni, dando sostanza e risposta alla nostra esigenza di orientarci nel tempo.
Tuttavia, quello che ha senso, in fondo, è il tempo nella sua interezza e continuità più che nelle sue divisioni. Lo afferma Mario Luzi in una poesia che inizia alludendo all’estate e ai suoi aromi.
Ci lasciamo con questi versi alti e intensi, a conclusione della periodica riflessione che abbiamo condotto quest’anno sul filo dei mesi.
E gli aromi?
d’aromi unico il tuo
dolcissimo e furente,
estate che ora nasci
nel gelsomino e nel tiglio
e cresci forte,
dilani
la primavera
ai suoi ultimi ritardi […]
Non ha senso l’istante. Ne ha il tempo,
ne ha la misteriosa
continuità di esso – pensa.
È ora, o quando?
è sempre. […]
(da Viaggio terrestre e celeste di Simone Martini, Garzanti, Milano 1994, pp.116-117)
AFORISMI
di Leonarda Tola
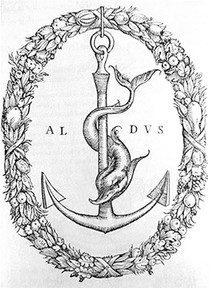
Festìna Lente
Il noto proverbio Festìna Lente (Affrettati senza fretta) accosta due parole in antitesi (per contrarietatem) che sembrano fare a pugni e collidere tra loro: ex verbis inter sese pugnantibus, scrive l’olandese Erasmo da Rotterdam (1467-1536), umanista e teologo che dedica un lungo commento all’aforisma, uno dei quattromila Adagia da lui raccolti. Con questo motto l’imperatore Augusto era solito (secondo Svetonio) richiamare i suoi generali a predisporsi alla battaglia con tempestività e prontezza mai disgiunte da ponderatezza e calma. Il detto pronunciato in greco dall’imperatore, σπεῦδε βραδέως (spéude bradéos) sembra voler ricalcare, correggendola, l’espressione più frequente negli autori greci e più ovvia: affrettati con rapidità, σπεῦδε ταχέως (spéude tachéos). Secondo il romano Augusto la fretta può non essere di pregiudizio alla buona riuscita di un’impresa alla sola condizione che essa sia accompagnata dalla prudente ponderazione di tutte le eventualità a cui si va incontro. La temerarietà nel fare in fretta può portare ad esiti nefasti in battaglia e in ogni altra situazione critica: “Per un capo è meglio la prudenza che l’ardimento”. A chi comanda si addice la capacità di valutare l’utilità delle decisioni in ragione della speranza che il guadagno che se ne può trarre sia maggiore del timore del danno che ne può derivare (maior emolumenti spes quam damni metu).
“Non si può essere temerari se i vantaggi che si ottengono sono minimi rispetto al non minimo rischio che si corre” affermava Augusto esortando i comandanti ad una visione tanto più strategica quanto più meditata riguardo alle conseguenze delle azioni di contrasto ad ogni sorta di nemico; paragonando i frettolosi “a quelli che pescano con un amo d’oro la cui perdita non potrebbe essere compensata da nessuna pesca”.
Così per le battaglie e le guerre ma anche per tutto ciò che, “se si vuole sia fatto bene, non va fatto rapidamente”. L’imperatore romano fa l’elogio della speditezza purché temperata dalla lentezza. Sintesi di un’antica filosofia della vita quali sono i proverbi, il detto, a partire dalla tradizione greca e latina si ritrova in molte lingue e dialetti dell’Occidente per sottolineare la superiorità dell’agire con accortezza nella valutazione del rischio in presenza di una sfida che impone rapidità e accelerazione. Uno per tutti il popolare “Pedro, adelante con juicio” di Antonio Ferrer nei Promessi Sposi.
Erasmo racconta la fortuna del motto Festìna Lente, adottato anche dall’imperatore Tito Vespasiano in una moneta d’argento dove fece incidere un’ancora avvolta da un delfino, simbolo l’una della fermezza e l’altro della destrezza operosa. La moneta giunse attraverso Pietro Bembo nelle mani di Aldo Manuzio, il grande tipografo del Cinquecento, meridionale trasmigrato e operante a Venezia, a cui si deve la pubblicazione di un incalcolabile tesoro letterario. Manuzio fece dell’adagio e dell’incisione il suo brand editoriale.
Postilla
Nell’emergenza pandemica che viviamo, chi governa, ovunque nel mondo, si è trovato a prendere decisioni, gravi quanto mai, in una vertiginosa oscillazione tra urgenza e prudenza, pronto intervento e attesa: ‘chiudere’ (le città) o ‘aprire’; fare presto a chiudere perché il rimedio non fosse tardivo, rallentare la corsa ad aprire per non vanificarlo. Sentenzia Ovidio: “Poni riparo all’inizio; la medicina arriva troppo tardi quando la malattia si è aggravata a causa degli indugi” (Principiis obsta; sero medicina paratur/ Cum mala per longas convaluere moras).Gocce del mare di saggezza che ci serve a stare dentro dove ancora siamo.
IL DIBATTITO
Gli acrobati
della valutazione
di Elisabetta Ricci
(con una nota di commento di Raffaele Mantegazza)

XXI secolo, società liquide, il mondo entra nell’era post-industriale e con esso la scuola che però mantiene i tratti di un’epoca diversa, improntata sull’industrialismo, sui “porti sicuri” delle ideologie figlie dei secoli precedenti. Ora invece i nostri “spazi di vita” sono sempre occupati, svuotati da relazioni umane spesso labili o addirittura inesistenti. Viviamo in “non luoghi” culturali e in questo strano “villaggio umano” la scuola è confusa si aggira in cerca di una dimensione nuova, diversa. Il popolo della scuola, o una parte di esso, si rende conto che occorre sfidare la nuova complessità attingendo da fonti diverse, futuristiche e futuribili. Siamo già al 2020, ci rendiamo conto di vivere in epoca post-moderna ma il nostro passo è lento, ci sono input di cambiamento ma li vediamo all’orizzonte, sfumati, lontani da noi docenti. I nuovi strumenti per affrontare la modernità ci sono ma hanno solo il “sapore” strano della sperimentazione o di qualche docente temerario che prova a voltare pagina perché magari capisce o pensa di capire che si sta vivendo una complessità nuova, dove ogni spazio umano e non è connesso e co-evolve continuamente. Il docente temerario si rende conto di vivere un’era di passaggio importantissima per la sua professione e per la sua utenza che è figlia dell’innovazione, della sfida, del cambiamento e della tecnologia o post-tecnologia, capisce che è necessario cambiare il passo e si rende conto che è in atto una sfida pedagogica dove ogni docente dovrà necessariamente gestire l’apprendimento e l’insegnamento in un’era nuova o post-tecnologica dove dovrà guidare un binomio diverso, lavorare in un “non luogo” rivalutando la centralità dell’essere umano, le sue peculiarità comunicative, le sue peculiarità culturali unite alle esperienze.
Sembrava questo, fino a qualche tempo fa un ragionamento fantasioso, per non dire partorito da una mente contorta. Così non è stato perché recentemente siamo piombati tutti all’improvviso in un mondo “diverso”, ripiegato su se stesso, forse quasi annientato. La scuola ha subito, come altre Istituzioni questo shock. Tutti ci siamo allontanati dalla vita “normale” e ci siamo ritirati in una vita “virtuale” e la scuola è diventata anch’essa “online” e il ragionamento fantasioso e poco scientifico del docente temerario è diventato realtà. La sfida adesso è aperta, l’era della complessità deve essere affrontata, ragazzi e docenti sono all’opera, non possono permettere al multi universo scolastico di collassare, è necessario allora non ri-formare questo sistema-scuola ma il docente temerario comprende che bisogna trasformare l’intero impianto scolastico, perché i tempi sono differenti ed è necessario per tutti adottare strategie lontane dall’inutile e pesante “burocrazia” anche didattica che da troppo tempo attanaglia la scuola. Il docente temerario, forse, non è proprio da solo a scalare la parete scivolosa della trasformazione, c’è un fondo di disponibilità e di apertura al nuovo in questo momento “diverso” che stiamo vivendo. Più di qualcuno ha voglia di ri-mettersi in gioco o di mettersi in gioco, bisogna, anzi è necessario nelle micro comunità scolastiche saper “gestire” la messa in relazione delle persone che vogliono rinnovare e rinnovarsi ed è indispensabile valorizzare la forza della collettività dei docenti temerari che vogliono contribuire al rinnovamento dell’azione didattica in toto, per far si che l’apprendimento possa diventare in via definitiva un’esperienza diversa che invogli gli studenti a viverla con piacere e curiosità. Sarebbe necessario fornire loro quegli “strumenti” per osare che vadano oltre la routine e l’uniformità di una scuola ormai superata. Esplorare quindi nuovi territori che la situazione paradossale che stiamo vivendo ha paradossalmente aperti.
Forse è il tempo della scuola che apra definitivamente alla creatività e valorizzi in modo stabile i talenti di tutti e di ognuno, elaborando in maniera creativa e non convenzionale nuovi percorsi con ventagli di soluzioni differenti e differenziate. Sarà necessario l’uso non convenzionale delle tecnologie che porteranno ad un sapere non più formale, dove i ragazzi potranno essere gli artefici della loro conoscenza e competenza abbandonando i vecchi processi lineari tipici della nostra scuola per processi circolari e virtuosi con al centro il ragazzo che apprende in team con gli altri studenti. Queste attività collettive saranno necessarie alla vita stessa di ognuno di loro. I pochi docenti temerari, sono o potrebbero essere attratti dalla bellezza di questa nuova sfida pedagogica che forse permetterà alla scuola con il suo ingranaggio antico e pesante di trasformarsi in una entità nuova, agile e pronta alle nuove frontiere da esplorare e conquistare. Se, però, questi insegnanti riformisti o visionari, per i più semplicemente visionari, si fermano a riflettere, capiscono che in questo momento di emergenza c’è una strana sovrapposizione nel mondo della scuola, una fusione ibrida tra vecchio e nuovo che porta ad una didattica a sua volta ibrida che partorirà una valutazione somigliante ad un acrobata che cammina sospeso su un filo sottile.
La valutazione nella nostra scuola è figlia della storia della legislazione scolastica del nostro Paese, dagli eventi sabaudi fino ad oggi, epoca del COVID 19. Esiste una galleria di documenti, di leggi e protagonisti che hanno fatto della scuola una delle istituzioni Sociali più importanti. I vari governi che si sono succeduti in un arco storico di circa due secoli sono stati gli autori che hanno dato vita alla Scuola Pubblica Italiana scrivendone l’impianto pedagogico e valutativo. La legge Boncompagni è figlia del Risorgimento, si passa per le due guerre mondiali, si arriva alla grande contestazione iniziata nel 1968 che darà alla luce una grande legge la 517/1977. Ci fu poi il ritorno al passato con la legge sulla valutazione di Maria Stella Gelmini, protagonisti i voti, che si appellò al motto “semplificare”. Questa fu per il docente temerario una semplice operazione di marketing e non certo un raffinato studio pedagogico al grido di “restaurazione”. Con il Decreto Legislativo 62/2017 si afferma, invece, la finalità formativa della valutazione per il miglioramento ed il successo e quindi “documento dell’identità personale”. Per arrivare ad oggi, tempo della pandemia, con l’Ordinanza Ministeriale 11 del 16 Maggio 2020 per la valutazione finale degli alunni dove il voto risulta comprensibile ed esaustivo senza bisogno di troppe spiegazioni, forse il docente temerario a questo punto si sente davvero sconfitto e ora capiremo perché.
Tante cose sono mutate in questi lunghi anni ma quel “catalogo” apparso con la legge Boncompagni nel 1851 è ancora in uso nella scuola del XXI secolo in epoca COVID, il catalogo che tutti chiamiamo registro, anche se elettronico, è ancora strutturato come allora e riporta voti o meglio numeri, pronti ad incasellare ragazzi che sono attori di un’era nuova e non catalogabile perché sono figli della liquidità, del continuo divenire,della flessibilità, della creatività, dei talenti e quel catalogo con cinque colonnette conterrà e conterà il loro futuro restringendolo in un’arida media matematica. Quindi il ragazzo del XXI secolo è valutato come il suo antenato che è andato a combattere durante il Risorgimento e le due guerre mondiali.
Con gli articoli 33 e 34 della Costituzione si ri-disegna il ruolo della scuola italiana e quindi indirettamente anche il modello della valutazione cambia. Nel 1968 gli studenti esprimono il loro disagio e si rivoltano rivoluzionando l’impianto scolastico. Nell’Agosto del 1977 viene emanata una delle leggi più innovative della nostra scuola pubblica, figlia della rivoluzione sessantottina, la legge 517/1977 ricordata soprattutto per l’abolizione delle classi speciali e l’inserimento nelle classi comuni di alunni “H”, innovazione importantissima. Modificò significativamente le norme sulla valutazione introducendo “la valutazione diagnostica e formativa”, i voti furono sostituiti da giudizi analitici e globali, tali giudizi furono legati a una valutazione del percorso, dei livelli di maturazione, del processo di apprendimento, con una lettura evolutiva e non statica dei risultati. È sempre figlia di questa grande legge la definizione che segue: “l’insegnante è stimolo e regista”. Il docente temerario, insieme a pochi altri dopo aver fatto un “viaggio” a ritroso nella storia della valutazione scolastica si rende conto che ad oggi “anno del Signore” 2020 si è sempre al catalogo, alle pseudo modernizzazioni della visuale valutativa che da molti viene definita scientifica e all’avanguardia.
Tutto ciò, però, ha generato spesso confusione e appiattimento del sistema valutazione, perché di sistema si tratta, e in questo periodo strano ci troviamo a lottare, non solo contro i male fisico che il COVID ha portato tra di noi, ma anche contro gli equilibristi della valutazione che hanno emanato un’ordinanza, a mio avviso poco chiara, non tenendo conto che in questo momento storico i nostri ragazzi meno che mai possono essere incasellati e valutati con voti che rappresentano numeri vuoti e pseudo giudizi poco calzanti. Sarebbe stato bello, invece, se i legislatori illuminati del nostro sistema scolastico avessero ripreso la “vecchia” legge 517/1977, figlia di un’epoca feconda che non amava le caselle del registro per valutare un ragazzo, ad oggi non si può più parlare di valutazione, sarebbe più adeguato parlare di valorizzazione dello studente, negli anni’ 70 del secolo scorso, questo salto di qualità fu fatto anche se per poco tempo. Oggi, ai tempi del COVID quella legge calza a pennello, potrebbe essere sicuramente rivisitata con tutte le postille di “modernità” che si sono aggiunte nel cammino valutativo globale. In altre parole il docente temerario, che già la legge 517/77 definì come “insegnante regista” era già presente allora e avrebbe voluto costruire una scuola diversa ma i venti cambiarono nel nostro Paese. Ad oggi, però, “l’insegnante regista” è necessario per guidare gli alunni figli della didattica a distanza e poi a valutare, o meglio, a valorizzare questi ragazzi con la valutazione a distanza che dovrebbe essere dinamica, innovativa e soprattutto empatica con alla base quelle soft skills o competenze trasversali (se ben non si capisce la lingua inglese) che comprendono proprio l’empatia, l’intelligenza creativa e tanto altro, in questo tempo”nuovo” sono indispensabili, a mio avviso, per non incasellare in modo anacronistico un ragazzo in continuo divenire. Non è necessario, o forse non sarebbe utile seguire un metodo scientifico per valutare ragazzi che hanno dovuto vivere, loro malgrado, un momento così difficile, anzi sono stati in grado, in linea di massima, di adeguarsi a questa grossa “novità” di una scuola “distante” e con quello che “sapevano fare” hanno cercato e ci sono riusciti, di superare le difficoltà e cosa assolutamente sorprendente hanno aiutato noi insegnanti meno esperti e poco temerari, tecnologicamente parlando ad usare queste “strane macchine” che per molti di noi erano “infernali” fino a qualche mese fa. Abbiamo imparato reciprocamente non solo a gestire anche creativamente questo strano connubio tra scuola “vintage” e scuola “post-moderna” e il risultato è stato che abbiamo imparato un nuovo modo di “fare scuola”, dove la cooperazione ragazzo/docente è diversa, inimmaginabile, rivoluzionaria e soprattutto temeraria e proprio da questa unione imprevista ed imprevedibile è, forse, iniziata la trasformazione della scuola del XXI secolo. Concludo con questa frase di Don Bosco che mi sembra attuale e calzante: “amate ciò che amano i giovani, affinché essi amino ciò che amate voi.”
Grazie
Una Maestra
------------------------------
Benedetti gli insegnanti temerari
Riccardo Massa sosteneva che "cambiare la scuola significa cambiarne il dispositivo" intendendo con questo termine quell'insieme di pratiche, oggetti, saperi, soggetti, architetture, tempistiche che costituiscono l'anima e il motore dell'accadere educativo a scuola.
Questa lettera ha il sorprendente coraggio di riprendere questa intuizione e di sottolineare come la logica delle riforme "spot" (cambiamo un po' la valutazione, modifichiamo appena la maturità, rifacciamo il trucco ai programmi) non solo significa cambiare tutto per non cambiare niente (anzi, non cambiare niente per non cambiare niente!) ma mettere sempre più gli insegnanti in una situazione di sudditanza. La logica è banalmente efficace: voglio dei semplici esecutori che educhino futuri esecutori, ordino e pretendo di essere obbedito da parte di coloro che faranno la stessa cosa con i ragazzi. E valuto attraverso procedure e logiche che nulla hanno di pedagogico coloro che saranno chiamati a valutare allo stesso modo. E il cerchio si chiude.
E invece no. Perché gli insegnanti temerari esistono, e hanno il coraggio del filosofo che disse ad Alessandro, che lo voleva suo servo promettendogli in cambio ciò che volesse: "allora spostati dal sole che mi fai ombra". Gli insegnanti temerari, i ragazzi che hanno il coraggio di pretendere una scuola all'altezza dei loro desideri e delle loro passioni, le famiglie che non si arrendono alla descolarizzazione strisciante (per capirci, non Illich - magari! - ma l'home-schooling) possono salvare la scuola; salvarla da se stessa, dalle tentazioni autoreferenziali, dall'innamoramento per gli strumenti che fa dimenticare i fini. Lettere come queste sono un manifesto di una scuola che deve vedere nel prossimo anno una stagione costituente. Che non dobbiamo chiedere per favore (a nessuno) ma iniziare a costruire, piaccia o no a chi pensa la scuola come dispositivo di ottundimento e di cancellamento della cittadinanza attiva e civile.
Raffaele Mantegazza
HOMBRE VERTICAL
a cura di Emidio Pichelan
Camminando contromano

Timeo Danaos et dona ferentes
Lo stallo era ormai evidente, la forza muscolare si era inceppata. Il ricorso alla umana astuzia diventava d’obbligo. Ma se i Danai (i Greci, gli Achei) diventavano furbi, i Troiani rimanevano diffidenti: dei nemici non intendevano fidarsi nemmeno quando si presentavano con le mani ricolme di doni. Ne diffidavano anche quando si presentavano con doni.
Così ci racconta Virgilio nell’Eneide.
C’è un qualche motivo per diffidare della voglia – da parte della cosiddetta pubblica opinione – di canonizzare donne e uomini il cui lavoro, sostanzialmente (by training, nella lingua degli anglofoni), consiste nel salvare la salute e la vita degli altri? Premesso il dovuto – la cosiddetta pubblica opinione va e viene, è ondivaga, capricciosa, innalza sugli altari e con la stessa facilità getta nella polvere -, l’operazione mitizzazione, concessione di medaglie sa (molto) di fuga dal dovuto: analisi razionale e valutazione di quanto accaduto in questi mesi terribili.
Le cose non sono andate per il verso giusto. Nessuna responsabilità da parte dei decisori politici? Si possono mandare i lavoratori e i professionisti a combattere/contenere un nemico subdolo a mani nude, senza il minimo sindacale per compiere il proprio lavoro (salvare la vita del prossimo), senza rischiare la propria e, ahimè!, mettere in pericolo le vite affidate alla loro missione?
Meno oro e incenso, e più scienza e coscienza nel maneggiare il bene (anzi, i beni) dei cittadini. Meno turiboli vaporosi e più mea culpa.
La cenerentola e il bacio di mezzanotte
Alla fine, il ministero e la task force e i tavoli (rotondi, quadrati, isoscele, solidi o sgangherati che siano) qualcosa partoriranno. E non è detto che il parto non sia anche innovativo, creativo, fantasioso, rivoluzionario.
Il punto è un altro: qualcosa vorrà pur dire se in questi mesi duri, ansiogeni si è discettato di tutto e di più, meno della scuola. Se non ora quando per indire gli Stati Generali per un domani diverso (non si ripeteranno, si spera, le stesse scelte perché, oggettivamente, qualche guasto, pesante quelle scelte hanno prodotto nel sistema Italia)?
Di tutto parlano i politici e la cosiddetta pubblica opinione, di fase 1 e 2 e 3 – sempre in attesa di Godot (il vaccino) -; alla scuola vengono riservati trafiletti, accenni. Lo sappiamo: in Italia, da molti decenni la scuola è una cenerentola in attesa di un principe azzurro che, in forza di un bacio (di riconoscimento) la risvegli e la faccia sedere al suo posto: sul trono, immediatamente a fianco del potere decisionale.
Diceva Gandhi: “Perdere la pazienza è perdere la battaglia della libertà”. La battaglia di Gandhi non era solo quella nazionale e nemmeno del sapere. Ma della civiltà. “Questa civiltà è tale che con un po’ di pazienza si distruggerà da sola”.
Il campanello suona forte e chiaro da decenni. La pandemia ci dice che il tempo è scaduto.
Un minuto di silenzio, una benedizione, una sepoltura comunitaria
“In quei luoghi [Case di Riposo] stiamo assistendo a tragedie terribili e inaccettabili. Se siete arrabbiati, frustrati, spaventati avete ragione. Lo sono anch’io. Stiamo perdendo i nostri genitori, i nostri nonni, la generazione che ha costruito questo Paese. Possiamo e dobbiamo fare meglio”. Sono le parole pronunciate dal Primo Ministro canadese Trudeau che, “oscuro in volto” ha deciso di mandare l’esercito nelle Case di Riposo (canadesi).
Nel nostro Paese gli “oscuri in volto”, gli “indignati”, gli “arrabbiati” sono i parenti dei troppi morti nelle nostrane Case di Riposo: i politici nostrani non hanno (finora) trovato il tempo per chiedere scusa, per indignarsi.
Corrado Augias, firma di “La Repubblica” e volto noto ai telespettatori, ha proposto un minuto di silenzio collettivo (di una giornata comunemente concordata) per ricordare la generazione capace di rimettere in piedi l’Italia dopo le follie fatali di una dittatura e di un conflitto mondiale. Lo esige la civiltà alla quale diciamo di appartenere; ce lo ricorda Augias, citando il grande Giambattista Vico: “Osserviamo tutte le nazioni […] custodire questi tre umani costumi: che tutte hanno qualche religione, tutte contraggono matrimoni solenni, tutte seppelliscono i loro morti”.
Primo maggio: grazie RSU, sentinelle del lavoro
Sono cittadini lavoratori che dedicano tempo, energia, pazienza – molta energia e molta pazienza – a tutela del lavoro. Si chiamano RSU, rappresentanze sindacali unitarie. Quando si parla di lavoro e di sindacato, come nella giornata del Primo Maggio appena passata, l’attenzione viene catturata (almeno a sinistra; come noto, la destra non ama né la sinistra né il sindacato. In sovrappiù, né la sinistra né il sindacato godono di buona stampa) dalle sigle sindacali confederali e da qualche volto frequentatore (non sempre opportunamente) degli studi televisivi e del concertone.
Di loro, delle sentinelle vigili, quotidianamente sul pezzo (il lavoro) si parla poco: eppure sono lì, per rappresentarlo (il lavoro), tutelarlo, difenderne il diritto a esistere e ad essere rispettato e riconosciuto. E a far emergere, come successo nel recente “scandalo Trivulzio” (a proposito, com’è che è sparito dalle pagine di “La Repubblica”?) quello che non va.
Il lavoro non se la passa bene da un po’, nonostante sia stato posto nella Costituzione repubblicana a fondamento del nuovo patto vincolante tra governanti e governati della nuova Repubblica. La storia dice che il lavoro non se l’è mai passata bene, e c’è chi non demorde dall’ideare una società senza lavoro, senza sindacato, senza rappresentanze, senza mediazione. Come a dire: una società di donne e uomini cittadini consumatori senza identità, senza una storia, senza una personalità. Senza politica.
Le grandi organizzazioni umane sono imperfette, commettono degli errori, i loro leader non sono sempre all’altezza del compito e delle sfide. Ma chi ha avuto la fortuna di frequentare le seconde e le terze e le quarte file del sindacalismo confederale sa bene quante energia, quanto entusiasmo, quanta passione, quanta dedizione albergano sui luoghi di lavoro. Sa bene che sarebbe (il lavoro) molto, ma molto più squallido e arido e triste e precario senza il lavoro anonimo e appassionato delle RSU.
Le rappresentanze sindacali unitarie sono del tutto volontarie e, va da sé, molto ma molto impegnative: contrattano sul luogo di lavoro, negoziano il salario e i percorsi di carriera, vigilano sulla sicurezza, difendono i lavoratori. Sono dei punti di riferimento imprescindibili; grazie al loro impegno, i lavoratori sono meno soli. Sono dei volontari della più pura specie. Anonimi, non per volontà loro.
DAI NOSTRI ISCRITTI
Pensiero a settembre
di Matilde Bissoli (introdotta da Lorenzo Gobbi)
Non capita tutti i giorni di ricevere lettere così. Spiegavo nella mia quarta liceo musicale come arriveremo a settembre, o almeno quali sono le ipotesi sul tappeto; poi, mi sono dedicato a Manzoni e alla sua tormentata ricerca religiosa, alla sua grandezza di innovatore unita ai suoi dubbi di uomo inquieto, grande comunque nel donare alla nostra cultura, cioè all’anima del nostro Paese – quella che respira in ognuno di noi, che ce ne accorgiamo o no. Dopo la lezione, Matilde mi scrive sulla chat dell’applicazione che usiamo per la didattica a distanza: “Prof, se le scrivo i miei pensieri, lei li legge?”. “Certo!”, rispondo; avrei voluto aggiungere: “Puoi dubitarne?”. È vero, però, che noi insegnanti spesso parliamo agli studenti e alle studentesse e ci confrontiamo tra di noi su di loro: è più raro, anche se non rarissimo, che parliamo davvero con loro o che lasciamo parlare semplicemente loro (“non è pertinente” è stata a lungo anche la mia obiezione, ma mi sto sforzando di farla scomparire dal mio vocabolario). Ricevo dunque queste parole, che colgono con immediatezza i punti essenziali di una riflessione che appartiene anche a me e che mi sembra preziosa per tutti:

Come sa, prof, sono Matilde Bissoli, una normalissima ragazza di 17 anni alla quale piace suonare e leggere; a 10 anni ho iniziato a studiare flauto e circa 4 anni fa ho iniziato a studiare pianoforte. La musica mi accompagna da molto tempo e proprio per questo mi sono iscritta al Liceo Musicale “Carlo Montanari” di Verona, e lì ho trovato anche lei tra i miei insegnanti. Volevo dirle che in questi ultimi anni sono state fatte molte riforme, molte delle quali riguardano la scuola. E adesso sono già state pensate decine di ipotesi su come si tornerà a scuola: i banchi a 1m di distanza l’uno dall’altro, gli studenti divisi in gruppi… insomma, sono state lanciate molte idee riguardanti il ritorno sui banchi ma non si saprà nulla di concreto fino a settembre. Perché sì, si tornerà a scuola a settembre, come continua a ricordare la ministra Azzolina: "A settembre si deve tornare a scuola, gli studenti hanno diritto di tornare a scuola". Questa occasione potrebbe essere il punto di svolta per la scuola: oltre a rivedere la logistica e il come si tornerà a scuola si potrebbero rivedere anche alcuni concetti che sono attualmente alla base dell’istruzione.
Alla base del sistema scolastico ci sono sicuro gli studenti, senza i quali non esisterebbe una scuola: nonostante ne siano le fondamenta, però, sono spesso dimenticati. A volte ritengo che il metodo di valutazione non sia adeguato: ovviamente, verifiche ed interrogazioni testano lo studio di uno studente ma non gli permettono di mostrare tutto il suo potenziale. Molti studenti durante queste prove ritengono di non dare il meglio di sé perché l’ansia e la preoccupazione per il voto prendono il sopravvento su di loro: pensano di essere il voto che prendono ed è in parte colpa loro e in parte colpa dei professori. Io sono stata fortunata: sin dalle medie ho sempre avuto insegnanti che amavano fare il loro lavoro e che me lo facevano capire, ma molti miei coetanei no, si trovano con insegnanti che vanno al lavoro solo per prendere lo stipendio e non si curano di cosa realmente lo studente ha imparato ma solo dei loro risultati in verifiche ed interrogazioni. Dovremmo fare un lavoro reciproco: gli insegnanti potrebbero essere più comprensivi (non nel senso che se una persona consegna in bianco gli va data la sufficienza, ovviamente), dovrebbero chiedersi il perché di certi errori e parlare delle cause con gli studenti. Gli studenti non dovrebbero sentirsi attaccati dai professori: dovrebbero sforzarsi di capirne il punto di vista (ad esempio, non ci si può lamentare di un’insufficienza se non si ha studiato).
Per quanto riguarda le valutazioni qui la categoria dei professori si divide in due: quelli che seguono la media matematica (i quali sono in minoranza rispetto ai secondi) e quelli che valutano la crescita formativa dello studente (la maggioranza) .
I primi hanno in parte ragione perché ovviamente la valutazione va data ma potrebbero non essere così pignoli: la maggior parte dei professori che rientrano in questa categoria sono molto severi e se una persona non ha la sufficienza piena loro non garantiscono di darla, lasciando la scelta al consiglio di classe.
I secondi penso che abbiano totalmente ragione: la scuola non sono solo materie ma sono soprattutto persone e nonostante uno studente non sia ancora Einstein in fisica o un William Shakespeare in inglese, apprezzano la crescita e l’impegno messo dallo studente il quale viene “premiato” a fine anno. Ma una domanda che mi sono posta spesso è: perché caricare gli studenti per metterli alla prova e non rendere tutto più semplice facendo verifiche meno corpose? Spesso non capisco perché ci mettano in difficoltà riempiendoci di materiale per una verifica per poi chiederci solo ¼ di esso. Perché dobbiamo vivere in costante ansia ed essere costantemente testati? Questo rientra parzialmente nel discorso che ho fatto prima, cioè nel fatto che ormai molti studenti si vedono come dei numeri: ammetto io stessa di essermi sentita come la mia media matematica, sapendo di poter dare molto di più ma non riuscendoci a causa di qualche blocco. So che nella mia situazione ci sono molti altri studenti: questo non potrebbe essere un “segnale di allarme”? Non potrei dare idee concrete, non saprei come valutare se non con numeri ma penso che guardarsi un po’ intorno, vedere le statistiche su come si sentono gli studenti negli altri Paesi e il modo in cui vengono valutati potrebbe essere utile.
“La scuola italiana è tra le più stressanti al mondo” (repubblica.it del 19 aprile 2017): nonostante il dato sia di 3 anni fa, lo ritengo comunque valido, a conferma tutte le considerazioni che ho fatto precedentemente. Scrive il giornalista: “E non è una questione di preparazione in quanto, prima di affrontare un compito scritto o una interrogazione, l’ansia attanaglia tre ragazzini italiani su quattro anche quando ritengono di essere abbastanza preparati. (..) In primis, è la “paura di prendere un brutto voto” a scatenare l’ansia (nell’85 per cento dei casi per i ragazzini italiani, nel 66 per cento dei casi a livello Ocse). Ma non solo. Perché tre quindicenni italiani su quattro (il 77 per cento) diventano nervosi quando a scuola si trovano al cospetto di un compito che non sanno risolvere”. Penso non ci sia nulla da aggiungere: sarebbe l’ora di trovare l’origine e capire il perché gli studenti si sentano così, e viste queste ricerche cercare di renderli meno stressati, dividendo il programma in modo più omogeneo. Con queste mie considerazioni non voglio assolutamente andare contro la scuola, anzi: ritengo che ci dia un’ottima formazione e che ci dia molti spunti per prepararci all’università e successivamente per trovare il nostro ambito di lavoro.
Per quanto riguarda la logistica penso sia uno dei problemi più grandi: molte scuole hanno un gran numero di studenti e molte aule “pollaio” (la mia in primis nella quale stiamo in 27 “leggermente” stretti), e difficilmente si riuscirà a far rispettare la distanza di sicurezza. Far lezione con guanti e mascherine sarebbe molto strano, come anche tornare in classe solo con metà compagni, ma preferirei accettare queste condizioni pur di tornare a scuola in sicurezza piuttosto che tornare a scuola con la paura di andarci.
RICORRENZE

Per questo mese, in cui si concludono le attività didattiche, abbiamo scelto di evidenziare solo una data, quella del 10 giugno, nella quale ricorrono due anniversari di grande rilievo nella storia del nostro Paese, entrami collocati nel periodo buio del ventennio fascista, di cui segnano due passaggi chiave; il primo (assassinio di Matteotti) prelude al consolidarsi del regime come dichiarata e formale dittatura, col secondo (entrata in guerra dell'Italia, di cui ricorre quest’anno l’ottantesimo anniversario) si imbocca la strada che porta al declino del fascismo, un tragico epilogo che restituisce al Paese una libertà pagata con altissimo prezzo in dolore, lutti e distruzioni.
10 giugno 1924 - Assassinio di Giacomo Matteotti
L’uccisione di Giacomo Matteotti, come è noto, avvenne dopo che il deputato socialista aveva pronunciato alla Camera dei Deputati, il 30 maggio del 1924, un discorso nel quale denunciava i brogli che avevano caratterizzato le elezioni svoltesi il 6 aprile dello stesso anno, con una vittoria schiacciante della lista guidata da Benito Mussolini.
Rapito e ucciso il 10 giugno, il suo corpo venne ritrovato solo il 16 agosto nelle vicinanze di Roma.
Il 3 gennaio del 1925, intervenendo alla Camera, Benito Mussolini pronunciò quella che si può definire una vera e propria rivendicazione politica e morale di quell’uccisione: «Ebbene, dichiaro qui, al cospetto di questa Assemblea e al cospetto di tutto il popolo italiano, che io assumo, io solo, la responsabilità politica, morale, storica di tutto quanto è avvenuto. Se le frasi più o meno storpiate bastano per impiccare un uomo, fuori il palo e fuori la corda! Se il fascismo non è stato che olio di ricino e manganello, e non invece una passione superba della migliore gioventù italiana, a me la colpa! Se il fascismo è stato un'associazione a delinquere, io sono il capo di questa associazione a delinquere! Se tutte le violenze sono state il risultato di un determinato clima storico, politico e morale, ebbene a me la responsabilità di questo, perché questo clima storico, politico e morale io l'ho creato con una propaganda che va dall'intervento ad oggi».
Siamo a un passaggio decisivo, che vede di lì a poco lo scioglimento di partiti e sindacati, la fine della libertà di stampa e di associazione, la riforma in senso autoritario dello Stato e delle amministrazioni locali, l’introduzione di meccanismi elettorali che assegnano ogni potere al partito fascista come partito unico.
Alle elezioni avvenute col nuovo sistema (un’unica lista per la quale votare sì o no), la lista proposta dal Gran Consiglio del Fascismo sfiora il 90% dei voti.

- Casa e tomba di Giacomo Matteotti a Fratta Polesine (RO)
10 giugno 1940 - L'Italia entra nella II guerra mondiale
Dal balcone di Palazzo Barbo, di fronte a una piazza Venezia gremita all’inverosimile, Benito Mussolini annuncia l’avvenuta dichiarazione di guerra alla Francia e alla Gran Bretagna, che segna la discesa in armi dell’Italia a fianco della Germania nazista.
Anche in quel caso, come sedici anni prima, eventi drammatici avvengono col sostegno di un consenso le cui dimensioni, pur mettendo in conto il peso delle intimidazioni tipiche della prepotenza fascista, destano impressione e costituiscono un ammonimento da tenere sempre nella dovuta considerazione: anche le peggiori nefandezze, e la stessa perdita della libertà, possono talvolta avvenire “a furor di popolo”.
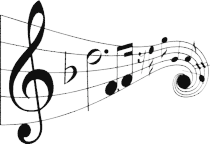
NOTE MUSICALI
a cura di Francesco Ottonello
Richard Wagner (1813 – 1883): Morte di Sigfrido
La Morte e Marcia funebre di Sigfrido è l’epitaffio musicale glorioso ed elegiaco che Wagner serbò alla figura di Sigfrido, personaggio nodale della mitologia germanica, la cui saga ispirò il grande ciclo dell’Anello del Nibelugo. Condensare in poche righe la portata artistica e cultura di un lavoro come l’Anello del Nibelungo sarebbe quasi impossibile o comunque estremamente difficoltoso. Può essere però di indizio, per capire la portata di questo ciclo di quattro opere del teatro musicale, citare quello che Quirino Principe, insigne studioso del mondo culturale germanico e della musica in particolare, ricorda: «Le opere che ci schiacciano con la loro grandezza […] sono opere perfettamente compiute, in cui neppure una virgola, o una nota musicale, o un tratto di colore, o un minimo elemento architettonico può essere trascurato, rimosso o aggiunto, e che alludono alla totalità del cosmo. Fra tali opere annoveriamo la Commedia dantesca e Der Ring des Nibelungen di Richard Wagner».
La Marcia funebre di Sigfrido è collocata in un momento apicale della vicenda raccontata da Wagner (ricordiamo che egli era autore sia delle parole che della musica), quando ci si avvia alla conclusione del dramma, in cui tutto finisce per ricominciare: un ciclo si chiude e un ciclo si avvia al suo nuovo inizio.
Con Il Crepuscolo degli Dei, il titolo dell’opera da cui la marcia funebre è tratta, termina l’epoca degli Dei e inizia l’era dell’uomo. Tutto torna all’inizio, in un perpetuo ciclo vitale.
Una delle caratteristiche più significative e innovative utilizzata da Wagner per connotare la saga dei Nibelunghi è quella di utilizzare temi musicali caratteristici (leitmotiv) a vari parametri drammaturgici: un personaggio (Alberich, Donner, Fafner, le Figlie del Reno); un sentimento (estasi d’amore, esuberanza giovanile, collera); un oggetto (anello, elmo magico) e così via. Una sorta di monadi musicali, che si combinano fra loro come tessere di un mosaico e tutte insieme compongono questo grandioso affresco che è l’epopea dei Nibelunghi.
La Marcia funebre è una parentesi sinfonica nell’opera che prelude al tragico finale, imperniata su celebri leitmotiv della saga; in essa si possono riconoscere il tema della morte, il tema di Sigfrido e quello della stirpe di Sigfrido, il tema della spada, il tema di Brunilde e il tema delle nozze. La Marcia funebre è in pratica il collage di otto melodie caratteristiche.
Aggregarsi, disaggregarsi. Vivere senza convivialità?
di Gianni Gasparini

Aggregarsi, stare insieme, unirsi: un gesto umano, il più elementare che conosca la nostra specie da sempre. Le forme dell’aggregarsi sono le più diverse e hanno gradi di implicazione reciproca che variano dalle più labili nello spazio alle più intense e impegnative nel tempo. Il contatto fisico di persona inizia al momento stesso della nascita, quando il lattante ha bisogno del corpo materno, e non termina più, articolandosi in innumerevoli modalità nel corso della vita. In una società mondiale globalizzata come la nostra, che conta oltre 7 miliardi di individui, sono molto presenti, oltre ai contatti interpersonali, forme di interazione e aggregazione che sono nel segno delle dimensioni di massa.
Ora, quello che il virus sta determinando in tutti i paesi colpiti – e negli altri che rischiano di esserlo, essendo la pandemia mondiale e a rapidissimo tasso di diffusione – è la tendenza alla disaggregazione e alla lontananza fisica tra esseri umani. Questa tendenza corrisponde a una prescrizione considerata fondamentale dagli scienziati per ridurre il contagio, insieme all’uso della mascherina: mantenere le distanze interpersonali quando si cammina o si sta in uno spazio pubblico, quando si sta in coda e si entra in un negozio, quando si sale su un mezzo di trasporto, e via dicendo. E, a quanto si può constatare, questa norma si è tradotta, da un paio di mesi, in un comportamento standard adottato praticamente da tutti, in una nuova abitudine che si è insinuata e instaurata nel nostro modo di vivere il quotidiano e di rapportarci gli uni agli altri.
Nella cosiddetta Fase 2, di graduale e prudente ripristino delle attività, si stanno precisando poi distanze ancora più severe che incombono su attività e consuetudini radicate: le distanze per prendere un caffè al bar o per sedersi a un tavolo al ristorante, quelle per prendere il sole sotto un ombrellone alla spiaggia e – immagino – per tuffarsi in acqua; le regole con cui stare in chiesa a seguire la messa dopo mesi di sospensione. E così via.
È come se si fosse di colpo sviluppato un tabù riguardo a tutte le forme di aggregazione, di incontro e di convivialità – dalla scuola al lavoro, dalle feste alla compresenza sui mezzi di trasporto e altrove – che sono state cancellate o vengono tollerate con modalità rigorose di distanziamento fisico. È qualcosa di assolutamente inaudito nei tempi moderni, che neppure le catastrofi più terribili avevano causato. Ed è una cosa, penso si debba dirlo francamente, inumana.
Intervistato in questi giorni, Renzo Piano, in isolamento a Parigi, ha affermato con un accento di tristezza: “Dalla finestra di casa riesco a vedere il Beaubourg: è vuoto, come tutti gli altri edifici pubblici che ho fatto in giro nel mondo. Edifici pensati come luoghi d’incontro, architetture della convivenza, che oggi, paradossalmente, questo terribile virus ci obbliga a pensare come pericolosi” (v. F. Irace, “Il Ponte di Genova di ferro e di aria”, Il Sole 24 Ore, suppl. Domenica, 10 mag.2020).
Tenendo conto che il Coronavirus purtroppo non sembra essere un incidente passeggero, ma qualcosa che rischia di diventare cronico nei nostri sistemi, è evidente che vengono poste in dubbio le basi stesse della ideazione e creazione di luoghi, ambiti, mezzi di trasporto e di altro tipo che consentano una fruizione dei servizi e dei luoghi, specie nei contesti metropolitani.
Jeremy Rifkin, tra i più autorevoli pensatori del nostro tempo, ritiene che bisognerà elaborare “nuove modalità di comportamento, studio, lavoro, vita sociale, per mantenere sempre una distanza di sicurezza l’uno dall’altro” e dunque, rispondendo indirettamente a Renzo Piano, occorrerà disegnare di nuovo teatri, cinema, stadi, aerei, “perché contengano meno gente e meno ammassata” (O. Occorsio, intervista a J.Rifkin, in AA.VV., Il mondo che sarà – Il futuro dopo il virus, La Repubblica, Roma 2020). Una prospettiva agghiacciante in termini economico-sociali e di relazioni umane, che secondo Rifkin prevede la morte della globalizzazione così come l’abbiamo conosciuta.
È presto per immaginare che cosa faranno i designers e gli architetti del prossimo futuro. Ma, al fondo di tutto, la questione da porre a noi stessi credo sia la seguente: possiamo fare a meno degli incontri faccia a faccia, delle aggregazioni tra umani, della convivialità che contrassegna innumerevoli nostri comportamenti e attività nei sistemi sociali in cui abbiamo vissuto e convissuto finora?
Credo che la risposta sia decisamente negativa. Senza la possibilità di incontri ravvicinati e di convivialità verrebbe meno l’essenza della condizione umana. E senza la partecipazione a eventi collettivi con grandi assembramenti di persone – dagli stadi ai teatri, dalle manifestazioni socio-politiche a tante altre – sarebbe vulnerata la nostra realtà di cittadini della modernità.
Se è necessario usare ora forme di distanziamento interpersonale, accettiamole, ma senza dimenticare la nostra insopprimibile esigenza di aggregarci liberamente gli uni agli altri. Interagiremo e ci aggregheremo forse in modi nuovi, ma neppure questo terribile Coronavirus potrà e dovrà toglierci il bello del ritrovarci e dello stare insieme.
(Gianni Gasparini, 15 maggio 2020)

